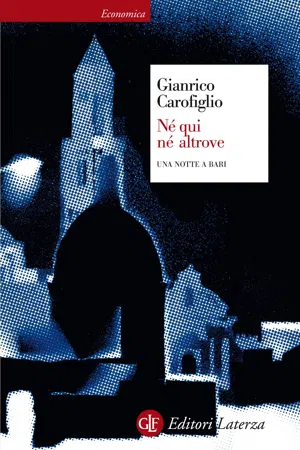Quarto
La notte a Bari alla fine degli anni ’70 era un luogo buio, silenzioso e poco cordiale. Non c’era luce, non c’erano rumori né musica, non c’erano posti dove andare la sera a parte i cinema. Quelli erano tanti, anche più di adesso. Tanti, e alcuni, per le ragioni più varie, bellissimi.
C’era il Gran Cinema Oriente, il primo in cui sia mai andato nella mia vita, bambino di quattro o cinque anni; quello in cui ogni anno arrivava il nuovo film della Disney, il primo in cui sia andato da solo, a undici anni. Oggi al suo posto c’è una sala Bingo. Evito i commenti.
C’era il Gran Cinema Margherita, magnifico edificio liberty, costruito e affrescato all’inizio del Novecento sullo sfondo del cielo e del mare. Chiuso da trent’anni, praticamente in rovina. Ogni amministrazione giura che lo metterà a posto e, come si dice, lo restituirà alla città.
C’era il cinema Orfeo. Oggi sala Bingo.
C’era la misteriosa Arena Giardino, con i suoi sedili di legno tinteggiati di verde e i suoi film di Totò in certe notti di settembre, immobili e incantate. Rasa al suolo.
C’era l’ABC-Cinema d’Essai (questo il nome completo, ma per tutti era l’ABC). Una sala minuscola a due passi dal faro, dove oggi, più o meno, sono arrivate la città, i negozi e le banche, ma dove – fra gli anni ’70 e ’80 – c’era una sequenza irreale di edifici diroccati e sinistri, di casette a un solo piano abitate da anziane prostitute. Passando davanti a queste casette davo sempre una sbirciata, sperando di intercettare qualche frammento di torbido erotismo mercenario. Ma lo spettacolo era sempre lo stesso: signore infagottate e sovrappeso che guardavano la televisione e, se si accorgevano di te, ti lanciavano uno sguardo invitante e sensuale come un’autopsia.
Il cinema era un’isola in questo territorio di allucinato, affascinante squallore. Pare che sia in ristrutturazione. Almeno, considerate le dimensioni microscopiche della sala, non potranno mai farci un Bingo.
C’era il Jolly, antico dopolavoro dei Postelegrafonici, che era il nostro preferito. Aveva sedili di legno scuro – i più scomodi che abbia mai provato –, era il più economico e ci andavamo un paio di volte alla settimana, all’ultimo spettacolo. E spesso, dopo il film, restavamo a chiacchierare lì davanti, sottovoce, fino a tardissimo. Ha chiuso alla fine degli anni ’80 e passarci davanti mi fa sempre pensare alla casa degli Usher.
Poi c’era il Galleria, a due passi dall’università. Aveva una sala immensa, con più di mille posti a sedere. A volte ci andavamo di pomeriggio, durante la settimana. Certi martedì, certi mercoledì d’autunno capitava di essere anche solo tre o quattro persone in quella sala sterminata e deserta. Una volta, non mi ricordo nemmeno che film fossimo andati a vedere, Paolo disse che per capire fino in fondo la magia del cinema bisognava stare lì, davanti a quello schermo enorme e a quei sedili vuoti. Aveva dannatamente ragione.
Oggi quella meravigliosa sala non esiste più, e il Galleria è un cinema multiplo che però, alla fine dei conti, è sempre meglio di un Bingo.
Con tutto questo la situazione dei cinema a Bari è meglio di quella di altre città. Ce ne sono ancora tanti dove si può andare a piedi, passeggiando nel centro della città o sul lungomare. Per andare al mio preferito, però, la macchina è necessaria, ci vuole un’ottima conoscenza del territorio e deve essere estate. Questo posto si chiama Arena ai Riciclotteri: ignoro cosa significhi il nome e non ho mai cercato di scoprirlo.
La stessa persona stacca i biglietti, ti vende le birre gelate custodite in un vecchio frigo anni ’60 e fa gli interventi di manutenzione sul vecchio proiettore sferragliante. Tutto è assai romantico e fuori dal tempo in quest’arena collocata fuori città, nel mezzo di nulla, fra capannoni industriali dismessi, depositi, rotaie sulle quali, nel pieno delle scene più emozionanti, rombano treni diretti chissà dove, a quell’ora della notte. Le file di sedili verdi di legno e metallo sono collocate su un pavimento di ghiaia e le facce dei frequentatori, me incluso, sembrano quelle di un gruppo di turisti da macchina del tempo, in gita premio dal passato. Se passate da Bari in estate, andate a vedervi un film in questo cinema. Se riuscite a trovarlo.
* * *
Ho divagato.
A parte i cinema, dicevo, non c’erano posti dove andare la sera. Non posti per noi, almeno.
Esistevano circoli privati – la Vela, l’Unione, il Barion – per soci anziani che essenzialmente giocavano a carte. Quei circoli privati esistono ancora. I soci sono anziani (molti sono gli stessi di trent’anni fa) ed essenzialmente giocano a carte.
Esistevano alcuni locali notturni di reputazione assai dubbia, dove si praticavano varie attività, tutte pericolosamente sul confine (e spesso oltre il confine) del codice penale e dove non ci avrebbero mai fatti entrare, ammesso che la cosa ci interessasse.
Esistevano le discoteche, naturalmente. Erano aperte solo nel fine settimana, avevano nomi vagamente pacchiani – Rainbow, Snoopy, Cellar, Merendero, Privé – e a me non piacevano: un po’ per confuse ragioni ideologiche, un po’ perché il mio stile di ballo ricordava quello di una foca monaca e certamente non incrementava il mio successo sociale.
Erano posti densi di fumo, musica assordante, profumo Patchouli dei ragazzi, profumo Charlie delle ragazze e, comunque la si pensasse, non erano posti dove bere una birra, chiacchierare, cazzeggiare, tirare tardi fino all’alba. Fino a tutto il 1979 posti del genere a Bari non ne esistevano. Era questa una delle ragioni per cui sognavo di andarmene via, verso una vita e dei posti più liberi, adatti a me, nei quali potessi essere me stesso e vivere secondo la mia natura. Cioè un estroso temperamento artistico, un po’ cialtrone ma capace di folgoranti slanci creativi, pronto all’ubriacatura, alla rissa e soprattutto all’avventura con le donne (a loro volta, s’intende, molto ben disposte all’avventura con me).
Giuro che pensavo veramente certe stronzate quando rientravo a casa, ragazzino di diciassette, diciotto anni, nel buio delle notti degli ultimi anni ’70.
Fu qualche giorno prima del capodanno 1980 che in via Netti, nel cuore profondo, maleodorante e minaccioso del quartiere Libertà, si inaugurò la Taverna del Maltese. Dopo, cambiarono molte cose.
La Taverna del Maltese era un locale underground, nel senso letterale del termine: era infatti in uno scantinato. Vi si accedeva scendendo per una scala ripida, che terminava in un piccolo ingresso: da lì si passava in una lunga sala a forma di L. C’erano tavolacci e panche di legno scuro, manifesti ai muri, scaffali con giochi di società; un bancone al centro, un piccolo palcoscenico con pianoforte (alquanto scordato, perché negarlo) a una estremità. La Taverna del Maltese apriva verso le nove di sera e chiudeva in orari imprecisati e imprevedibili. A volte a notte fonda, a volte quasi all’alba.
Quanto si trattasse di una totale novità, per Bari e per noi, è difficile spiegarlo. È addirittura difficile ricordarlo, adesso.
La Taverna del Maltese, e tutto quello che in breve avrebbe cominciato a girarci attorno, fece irruzione nelle notti silenziose e vuote di Bari, evocando un’umanità imprevista, notturna, sotterranea, allegra, cialtrona, tragica, ridicola, a volte anche geniale.
Erano artisti, picchiatori, musicisti, aspiranti cuochi, aspiranti magistrati, romantici, scansafatiche, cantautori, scrittori, ubriachi, pazzi, drogati, belle ragazze, anoressiche, puttane, poeti, ricchioni, lesbiche, indecisi, politici, punk, traditori della causa, spacciatori, ninfomani, liceali e professori.
La nostalgia è un’emozione che non frequento molto: ma, devo dirlo, mi fa effetto ripensare a certe notti al Maltese (per tutti, in breve, quel posto diventò semplicemente il Maltese) e a quell’insieme scomposto di vecchi giubbotti di pelle, sciarpe, tette, scarpe da ginnastica, odori, barbe, culi, speranze pronte a venire deluse, cuori pronti a essere infranti, segreti, amori, destini a scomparsa. Facce e illusioni risucchiate nel tempo.
L’apertura del Maltese fu un crinale. Per le nostre notti, da quel momento ci fu un prima e un dopo.
Come si fossero dati un cenno d’intesa, un sacco di personaggi in cerca di autore o perlomeno di prima occupazione, possibilmente non faticosa e che consentisse di rimorchiare, si scatenarono nell’apertura di ogni tipo di locali e ritrovi notturni, quasi tutti realizzati come variazioni sul tema: circolo alternativo di sinistra, ma aperto alla città.
Tutti praticavano la formula del circolo privato (anche il Maltese, che la introdusse sul modello di quello che succedeva in altre città), che significava: entrano solo i soci o gli ospiti dei soci, ma non saremo eccessivamente fiscali o cavillosi.
Funzionava così: arrivavi davanti all’ingresso e suonavi il campanello. La porta era sempre chiusa e quasi sempre c’era un campanello; se non c’era, davi dei cazzotti alla porta. Dopo un tempo imprevedibile veniva ad aprirti un tipo con barba, maglione fuori misura e, spesso, un odore corporale intenso, segno di un rivoluzionario disprezzo per l’abitudine borghese delle abluzioni troppo frequenti.
“Siete soci?” era la domanda.
Tu non eri socio e dicevi che volevi solo dare un’occhiata e, comunque, così per sapere, quanto costava associarsi?
Di regola costava diecimila, nei posti più a sinistra cinquemila, ma se insistevi ti lasciavano dare un’occhiata. Il che, nella maggior parte dei casi, consentiva di risparmiare le dieci o le cinquemila, e bastava per sempre.
Ricordo una turbinosa sequenza di nomi. Spleen, Guernica, Gotham City, Rimini, Fleurs du Mal, La dolce vita, Caffè Voltaire, Capitan Fracassa, Sherazade, Atahualpa, il Pellicano. Un manicomio, un po’ allegro, un po’ inquietante.
A scanso di equivoci va detto che le strade della città rimasero deserte e silenziose. Tali sarebbero rimaste per almeno altri quindici anni, quando si scatenò la movida notturna che aveva lasciato esterrefatto Paolo. Rispetto a prima, però, era possibile uscire e rifugiarsi in queste tane, quasi sempre sotterranee, dove pulsava una vita nuova e dove sembrava si nascondessero possibilità insospettate.
Oltre al Maltese i miei preferiti erano il Pellicano e soprattutto l’Atahualpa.
L’Atahualpa era in via Garruba, anch’esso nel cuore del quartiere Libertà.
Oggi il quartiere Libertà – che allora era il regno del degrado, assieme al CEP e al rione Japigia – è un posto bizzarro e interessante. Ci abitano africani, asiatici, albanesi, greci, russi, ucraini, rumeni, giovani professionisti, qualche scrittore, qualche artista, ancora un sacco di studenti fuorisede e, naturalmente, un certo numero di trafficanti, ricettatori e pistoleri. Oggi, assieme al quartiere Madonnella, è la zona antropologicamente più variopinta e più interessante della città.
A Libertà, ma anche a Madonnella (a sud-est del Teatro Petruzzelli), si possono trovare, le une vicine alle altre, case popolari affogate nel degrado e immobili ristrutturati ed elegantissimi, loft, vecchie botteghe senza insegna dove si vende di tutto (dalle stoviglie di plastica ai piccoli elettrodomestici, dai giocattoli al cibo per cani), salumerie, panifici, pescherie, palestre, boutique, laboratori, spacci dove si gioca alla birra anche alle dieci del mattino, circoli privati dove si gioca a carte (le due opzioni sono intercambiabili), sale ricreative, biliardi, negozi di elettrodomestici dall’aspetto e dal sound nordafricano, agenzie di pompe funebri, cartolerie, tabaccherie, pizzerie, stocchisti, scuole di danze latine, bische, ristoranti giapponesi, ristoranti cinesi, ristoranti arabi, posti telefonici, internet point e money transfer, supermercati etnici, negozi di giocattoli, negozi di caramelle, inattese botteghe di artisti, supermercati cinesi.
Oggi è un posto interessante per abitarci e, fra l’altro, fare la spesa costa ancora molto meno che nel quartiere Murat, solo a qualche centinaio di metri di distanza.
A cavallo fra gli anni ’70 e gli anni ’80 il quartiere Libertà era soltanto un posto degradato e pericoloso. L’Atahualpa era nel cuore del degrado.
Era un ristorante vegetariano e se non siete stati ragazzi a Bari negli anni ’70 non potete capire che eccitante novità fosse. E poi quel nome. Atahualpa, il fiero re Inca, prima tradito e poi massacrato dall’infame Pizarro. Mi piaceva un sacco che quel nome arrivasse direttamente dalle Ande, dalle praterie della storia, fino agli anfratti delle nostre vite.
Era il posto più magicamente sfigato, squallido e romantico di quegli anni. Si mangiavano zuppe di cereali andini, hamburger di soia, torte di carota e molte altre cose dai nomi improbabili, che purtroppo non riesco a ricordare. Ma non importa, perché tutto, dal primo al dessert, aveva lo stesso sapore. I camerieri avevano un’aria dolcemente assente, come se in cucina si fossero mangiati dei funghi un po’ diversi da quelli che ci servivano nelle zuppe. Alcune sere nel locale eravamo solo Paolo, Giampiero e io. Era tutto deliziosamente fuori posto ed era chiaro che non poteva durare.
Quello che invece è incredibilmente sopravvissuto fino a oggi, con la stes...