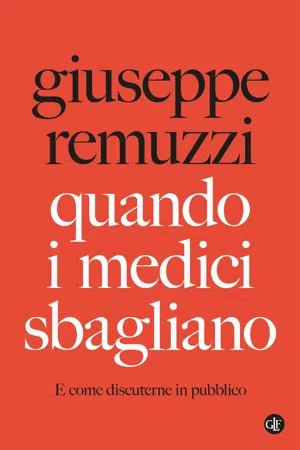1.
Aiutiamo il pubblico
ad apprezzare gli scienziati
C’è l’idea che gli scienziati non siano apprezzati dal grande pubblico. Non è vero. Medici, ingegneri e scienziati sono al primo posto per le categorie più stimate, in Europa. In fondo ci sono i giornalisti e i politici. Ma molti (il 40% dei cittadini europei) pensano che gli scienziati possano fare cattivo uso delle loro scoperte e l’80% vuole che l’attività degli scienziati sia soggetta a più controlli. La gente stima gli scienziati, ma ha paura delle novità. Di fronte a una novità è quattro volte più probabile che la gente reagisca in modo negativo, più che positivo. Gli OGM che salveranno il mondo dalla fame sono visti come al servizio delle multinazionali. La ricerca sulle cellule staminali ed embrionali si pensa possa tendere a creare uomini tutti uguali al servizio dei militari. Gli studi sul genoma, che sono il primo passo per capire la natura delle malattie e curarle, sono visti come un modo di modificare la natura.
Perché? Perché la società non capisce la scienza, si è detto per anni, “non c’è abbastanza cultura scientifica”. Il giorno in cui i cittadini avranno abbastanza cultura scientifica, tutto sarà risolto. Non è così. Va fatto lo sforzo da parte degli scienziati di capire il pubblico e portarlo man mano ad apprezzare la scienza e i suoi metodi. Lo si può fare raccontando delle storie piuttosto che con lezioni accademiche. Una delle più straordinarie, quella che ha cambiato il corso della scienza, è la storia di Charles Robert Darwin e della sua teoria sull’evoluzione raccontata in un libro meraviglioso – Darwin era anche uno scrittore sopraffino –, L’origine delle specie, del 1859. Darwin da studente è un disastro, passa il tempo a cacciare, bere e giocare d’azzardo (“Cambridge è troppo divertente”, scriveva). La passione per la scienza gli viene da William Darwin Fox, un cugino che collezionava scarabei, e da due suoi professori, John Henslow e Adam Sedgwick. E da un viaggio intorno alle coste del Sud America. Negli anni che seguono soffre di una malattia misteriosa, ma intanto le sue idee si diffondono. La fama di Darwin viene dai suoi libri. È scrittore sofisticato e ha il gusto di esserlo (è un peccato che nessuno lo consideri un letterato). L’origine delle specie ha un successo enorme. È piacevole e chiaro, pieno di esempi e riflette la grande onestà intellettuale di Darwin che gli argomenti li usa tutti, non solo quelli che gli servono. Le sue idee hanno pervaso la scienza, e la scienza medica, ma anche l’arte, la filosofia, la politica e molto altro.
Regali di Darwin all’umanità che nell’occasione del bicentenario della sua nascita il “Lancet” ha raccolto per farne omaggio ai suoi lettori. “Perché l’orecchio medio è innervato da due nervi separati?”. È perché i pesci primordiali da cui veniamo avevano due ossa mandibolari distinte. “Artrite reumatoide, asma o sclerosi multipla colpiscono solo l’uomo, mai le scimmie”. Perché? Cominciamo a capirlo solo adesso a partire dalle intuizioni di Darwin. Ansia e depressione non sono malattie, ci difendono da tanti pericoli e ci evitano guai peggiori. Quello che ha suggerito Darwin per l’origine delle specie si applica anche ai tumori. Quando i geni di una certa cellula si modificano così da indurla a proliferare, come succede nel cancro, subito si attivano altri geni capaci di riparare il DNA che rimettono tutto a posto. Ogni giorno nel nostro organismo migliaia di cellule subiscono alterazioni del DNA (succede alle cellule del polmone in chi fuma, per esempio). Se i sistemi di riparazione non funzionano capita che qualche cellula cresca in modo incontrollato. All’inizio prevale la riparazione e i giovani sono protetti dal cancro. Col passare del tempo però è sempre più probabile che qualcuna sfugga ai meccanismi di difesa, ed è tumore. L’uomo è programmato per passare i suoi geni a chi viene dopo, fin qui sono tutti d’accordo. Poi però, sostiene Jarle Breivik che è professore dell’Università di Oslo, noi non serviamo più. Appena i nostri ragazzi sono capaci di prendersi cura di loro stessi noi diventiamo sempre meno interessanti per i nostri geni. “I nostri geni non si curano di noi, a loro interessa passare ai nostri figli e per farlo non esitano ad eliminarci”.
Sono solo pochi esempi, ce ne sono moltissimi d’altri. Perché il cuore si scompensa, per esempio, oppure perché invecchiamo o perché i germi diventano resistenti agli antibiotici. Regali di Darwin – che di medicina sapeva poco – alla medicina.
Più tardi Darwin ha influenzato Gauguin, Rodin e Klimt, Munch e Beardsley. Ai primi del Novecento George Frederic Watts dipinge l’origine dell’uomo e Fernand Cormon uomini delle caverne. Arnold Böcklin e Franz von Stuck dipingono metamorfosi e brutali incontri, e scontri, fra creature. Gli artisti presi dalle idee di Darwin cominciano ad occuparsi di quanto la specie umana sia fragile e ad averne paura. John Collier, genero di un discepolo di Darwin, dipinge The Land Baby, una sirena per metà dentro l’acqua e per metà fuori che guarda con stupore una bimba nuda sulla terraferma, che però ha le gambe. La marcia del progresso, fatta di individui in fila da sinistra a destra, una sorta di cammino dell’evoluzione, da scimmie a scimmie-uomo all’uomo di oggi si vede per la prima volta nel 1970. È un’immagine che abbiamo tutti negli occhi senza nemmeno sapere chi l’ha disegnata.
Confrontarsi col dato scientifico oggi, dopo che Francis Collins e Craig Venter nel 2000 hanno decodificato l’intero genoma – tre miliardi di lettere che contengono le istruzioni per creare quelli che si pensava fossero 35 mila geni – dell’uomo prima e poi del topo nel 2002, vuol dire confrontarsi con la struttura e la funzione del DNA da cui dipende tutto quello che siamo. “La più grande rivoluzione dopo Leonardo”, ha detto qualcuno. Il 26 giugno 2000 Francis Collins e Craig Venter erano alla Casa Bianca vicino al presidente Clinton. “La scienza del genoma cambierà la nostra vita e ancora di più la vita dei nostri figli. Sarà una rivoluzione per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento della maggior parte se non di tutte le malattie dell’uomo”. Questo, fra l’altro, nel discorso del presidente di quel giorno. Sono passati oltre vent’anni, conosciamo i geni responsabili della depressione, dell’insonnia, del fatto che un individuo sia religioso o no, e sappiamo che chi ha certi geni ha più possibilità che il matrimonio duri a lungo, chi ne ha altri di separarsi. Ma da allora la nostra vita non è cambiata e nemmeno lo stato di salute.
Anche Collins aveva fatto le sue previsioni quel giorno. “Nel giro di dieci anni – aveva detto – si potranno prevedere certe malattie rare, i test genetici saranno disponibili ai medici di medicina generale e per qualche malattia si potrà fare la diagnosi prima di impiantare un embrione in utero (e questo solleverà tante discussioni)”. Collins ci aveva visto giusto, tutto quello che aveva previsto quel giorno è successo davvero, compreso che la medicina genetica “almeno all’inizio sarà soprattutto per i ricchi e chi vive nei paesi emergenti non ne avrà grandi benefici”.
Ma nemmeno Clinton ha sbagliato poi così tanto. La scienza del genoma la cambierà davvero la nostra vita e anche presto. Oggi sequenziare il genoma costa 14 mila volte in meno che dieci anni fa (adesso lo si può fare con meno di 1000 dollari). L’intero genoma di 1000 persone era già stato sequenziato nel 2011, americani, ma anche europei, asiatici, africani.
E tutto questo a cosa serve? A capire – si pensava – chi rischia di più per malattie comuni come il diabete, l’autoimmunità, il cancro, le malattie del cuore. I progressi più straordinari sono stati nel campo delle malattie rare. Lì è più facile perché per la maggior parte si tratta di mutazioni di singoli geni. “Ho impiegato vent’anni e speso 50 milioni di dollari per trovare il gene responsabile della fibrosi cistica, quel lavoro lì adesso lo potrebbe fare un bravo studente che abbia un sequenziatore (serve per mettere in fila i geni che ci sono nel nostro DNA) e accesso a Internet in modo da poter confrontare le sequenze che trova con quelle già pubblicate”, ha scritto Collins su “Nature” nel 2010.
Ma trovare un gene è solo il primo passo, non vuol dire ancora aver trovato la cura della malattia, anche se in qualche caso dal gene si è già passati alla proteina e dalla proteina al farmaco. È il caso di una decina di malattie, proprio come aveva previsto Collins. Aver sequenziato il genoma aiuterà anche a poter curare il cancro. Qui stanno muovendo i primi passi trastuzumab, imatinib, gefitinib, erlotinib, nomi astrusi per altrettanti farmaci biologici che si legano ad un certo recettore con la precisione di una chiave che si infila nel buco della serratura e impediscono a certe forme di tumore di crescere. Quei recettori e la loro funzione si sono potuti scoprire grazie a tutti quelli che hanno lavorato al progetto genoma. E la cosa nuova – e bellissima – di questo tipo di ricerca è che tutti hanno accesso ai dati degli altri.
Insomma a dieci anni dall’aver sequenziato il genoma qualche passo avanti si è fatto, con vantaggi reali per certi ammalati di malattie rare e per poche forme di tumore. Ma le speranze che conoscere il DNA aiutasse a capire le cause del diabete, dell’Alzheimer, dell’infarto del cuore e di tante malattie comuni non si sono trasformate in niente di rilevante sul piano clinico. Forse le malattie comuni sono causate da tante varianti (polimorfismi), ciascuna relativamente rara in tanti punti del DNA. Allora si capisce perché è così difficile trovare cure che vadano bene per tutti gli ammalati di malattie molto comuni. E c’è di più. L’essere stati capaci di sequenziare il genoma ha fatto capire che adesso per avere i benefici che tutti ci aspettiamo per la salute dell’uomo servono conoscenze nuove soprattutto di bioinformatica ed esperti che sappiano ricavare dall’enorme quantità di informazioni che derivano dall’analisi del nostro DNA i soli dati rilevanti a capire la causa delle malattie. L’errore che è stato fatto dopo l’annuncio della sequenza del genoma è stato forse di pensare “adesso sarà facile capire le cause delle malattie e trovare i farmaci per curarle, sarà solo questione di pochi mesi o pochi anni”.
Non è stato così, anche se certamente succederà, ma non sarà subito. Ci vorranno decenni. E poi si dovrà capire come, perché e dove si esprimono certi geni e chi contribuisce a conservarli o a modificarli (nel bene e nel male). E la prossima sfida sarà comprendere il rapporto tra i geni e le condizioni ambientali. Molti di quelli che fumano si ammalano di cancro del polmone e quasi tutti vivono meno di chi non fuma, ma qualcuno no, non si ammala e vive a lungo, perché? Per certi tumori, una volta considerati incurabili, qualcuno guarisce già oggi con certi farmaci biologici, ma la maggior parte di quelli che si ammalano dello stesso tumore muoiono, perché?
“Abbiamo già visto cose straordinarie in questi dieci anni – hanno chiesto qualche tempo fa a Francis Collins –, forse il più è stato fatto?”. “Sono pronto a scommettere che le cose più importanti le dobbiamo ancora vedere”.
COVID-19 non è il primo coronavirus che l’umanità si trova ad affrontare e non sarà nemmeno l’ultimo, viene dagli animali, ma di sicuro non si sa quando abbia fatto il “salto di specie” per arrivare all’uomo e nemmeno come. Non lo sappiamo e comunque è una domanda a cui è molto difficile rispondere, forse possiamo riferirci alle epidemie precedenti anche perché COVID-19 è solo uno dei tanti coronavirus che hanno già circolato fra gli uomini in passato. Due di quei virus (OC43 e 229E) sono stati scoperti solo negli anni Sessanta ma circolavano da centinaia di anni fra i bovini – il primo – e i pipistrelli – il secondo – prima che arrivassero all’uomo. Ci sono stati coronavirus anche dopo la SARS, molti circolano negli animali. Quando arrivano nell’uomo provocano malattie lievi, raffreddore soprattutto, eventualmente un po’ di tosse, salvo HKU1. La cosa più interessante però è che l’andamento di tutti questi coronavirus come della maggior parte delle infezioni virali respiratorie è stagionale, i contagi tendono ad aumentare d’inverno mentre in primavera e in estate la curva di solito scende. Non è una regola assoluta ma qualcosa che va tenuto in considerazione per prepararsi a eventuali nuove pandemie e per mettere in atto misure di salute pubblica più efficaci.
Sarebbe bello se fra un paio di anni anche COVID-19 finisse nel dimenticatoio, ma non chiedetemi di fare una previsione: non lo so, non lo sa nessuno, anche perché questa volta siamo di fronte a un virus che il nostro sistema immune (forse, ma non siamo sicuri nemmeno di questo) non ha mai visto prima.