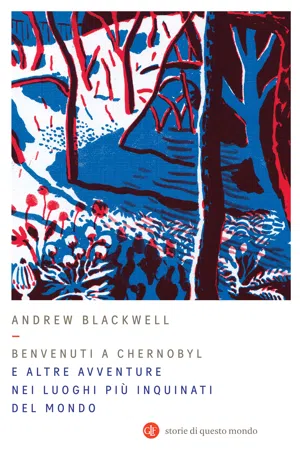1.
Benvenuti nella ridente Chernobyl.
Gite in un paese delle meraviglie radioattivo
È cominciato tutto su un treno. Da Vienna a Kiev, cullato su e giù nel Kiev Express. Aveva un certo fascino a metà tra Agatha Christie e Leonid Brežnev. I corridoi erano tappezzati da lunghe guide di tessuto orientale, le pareti degli scompartimenti avevano rivestimenti in finto legno e sedili rosso scuro che diventavano cuccette.
In realtà non si chiama Kiev Express. Se fosse davvero un espresso, non ci metterebbe trentasei ore. Anzi, questo viaggio non andrebbe proprio fatto in treno. Avevo preso il biglietto solo perché, per qualche strano motivo, mi ero messo in testa che Vienna e Kiev fossero vicine. Non lo sono.
Stavo andando a Chernobyl, in vacanza.
I treni sono fatti per leggere, e così mi ero portato due libri: Voices from Chernobyl, una raccolta di interviste a sopravvissuti, e Wormwood Forest, uno studio sugli effetti ambientali dell’incidente. Li raccomando entrambi, ma quando dico che i treni sono fatti per leggere non voglio dire di aver letto poi tanto. In realtà schiacciai una grandiosa serie di sonnellini, sbirciando di tanto in tanto nei libri.
Insieme a me, nello stesso scompartimento, viaggiava Max, un tipo grassoccio e sorridente sulla trentina. Max aveva una voce alta e stranamente formale; sembrava una specie di Charlie Brown cresciuto, se Charlie Brown fosse cresciuto in Unione Sovietica. Originario di Kiev, adesso faceva il programmatore in Australia. Mi inteneriva il suo modo di asserire cose ovvie. Per esempio, mi svegliavo da un sonnellino, mi scivolava per terra il libro, guardavo fuori dal finestrino e vedevo che ci eravamo fermati in una stazione.
«Ci siamo fermati», diceva a quel punto Max.
La prima notte traversammo la Slovacchia per tutta la sua lunghezza. Uno splendido crepuscolo si posò sulle ciminiere diroccate delle fabbriche abbandonate.
La mattina dopo raggiungemmo la frontiera ucraina ed entrammo barcollando in uno scalo merci ingombro di ogni cosa, fino a fermarci tra due enormi cric, più alti dei vagoni. Una squadra di operai scontrosi si mise a svitare e a martellare le ruote del treno, e presto i cric sollevarono tutto il nostro vagone, mentre i carrelli delle ruote rimanevano sotto di noi, sui binari.
Il fatto è che le ferrovie dell’ex Unione Sovietica non hanno lo stesso scartamento del resto dell’Europa. Così cambiavano le ruote al treno.
«Cambiano le ruote al treno», disse Max.
Nel pomeriggio eravamo già nel paesaggio alpino dei Carpazi in fiore, e Max si era incuriosito sui miei progetti. Decisi di non raccontargli che stavo intraprendendo un’impresa epica che sarebbe durata vari anni, per visitare i luoghi più inquinati del mondo. Gli dissi solo che ero diretto a Chernobyl.
Si illuminò in volto. Aveva delle storie da raccontare. Nella primavera del 1986, quando si seppe del disastro, aveva undici anni e viveva a Kiev. La gente cercò di far andare via dalla città i bambini prima possibile. Era quasi impossibile trovare dei biglietti, disse Max, ma in qualche modo i suoi lo misero su un treno diretto a sud-est, verso la Crimea. Nonostante la difficoltà di procurarsi i biglietti, il treno era quasi vuoto, e Max fece intuire che fosse stato il governo a creare quella situazione, per evitare che la gente lasciasse la città.
«Quando arrivammo», disse, «il treno fu circondato da soldati. Misurarono le radiazioni di tutti noi e dei bagagli, prima di permetterci di proseguire. Cercavano di evitare che la gente diffondesse la contaminazione».
Rimase lontano da Kiev tutta l’estate. I genitori gli raccontarono storie su come si viveva in città quei mesi. Le strade venivano lavate da cima a fondo ogni giorno. I fornai che prima lasciavano i prodotti sugli scaffali aperti adesso li avvolgevano nella plastica.
Max parlò della possibilità che in quella zona i casi di cancro fossero aumentati a causa di Chernobyl, e mi raccontò che sua moglie, anch’essa di Kiev, aveva dei disturbi alla tiroide, che lui attribuiva all’esposizione alle radiazioni.
«È stata proprio una fortuna che, grazie ai venti, a Kiev non siano arrivate più radiazioni», disse. Poi mi chiese con la sua voce garbata e asciutta: «E che cosa ne pensa dell’energia nucleare?».
Quella notte rimasi insonne nella cuccetta e immaginai – cosa possibile solo a un americano – che mi passasse a fianco, lì fuori, il grigiore post-sovietico, sentii il treno fremere mentre si faceva strada nell’aria greve che un impero lasciava dietro di sé. Nel libro sulle storie dei sopravvissuti a Chernobyl lessi il racconto della vedova di un vigile del fuoco. Erano sposati da poco quando il marito accorse all’incendio nel reattore. Fu tra i primi alla centrale e ricevette dosi letali di radiazioni: morì dopo due settimane di malattia raccapricciante.
Disperatamente innamorata, la moglie era entrata di nascosto in ospedale per accompagnarlo nel suo calvario, anche se il corpo stesso del marito era pericolosamente radioattivo.
«Non so di che cosa devo parlare», dice nel suo racconto. «Della morte o dell’amore? O sono la stessa cosa?».
* * *
Kiev è una splendida città, una vera Parigi dell’Est, una metropoli affascinante le cui foreste di ippocastani mettono in risalto le chiese antiche e gli edifici classici come gioielli su un cuscino di velluto verde increspato. Il trucco consiste nel venire d’estate, quando sul fiume Dnepr soffia una brezza tiepida e uscendo dai bar e dai caffè ti accoglie una serata mite. Si può passeggiare per la discesa Andriivs’kij, ricca di caffè e negozi, o esplorare le misteriose catacombe della Pečers’ka Lavra, con il suo serraglio di monaci morti. O ci si può immergere nella palpitante vita notturna del centro.
Io andai direttamente al museo di Chernobyl.
Qualsiasi museo dedicato a un disastro industriale locale è improntato a una singolare miscela di orrore e di orgoglio civico, e il museo di Chernobyl è sicuramente il migliore nel suo genere. È un luogo che mette insieme storia, commemorazione, riflessione, arte, religione e persino moda; è il frutto di un ethos curatoriale emerso come progenie mutante di varie estetiche diverse.
In una delle due sale principali del museo c’era un bizzarro ambiente che ricordava un tempio. Dai muri proveniva una riposante musica corale russa. Al centro dello spazio c’era una ricostruzione a grandezza naturale della superficie superiore del famigerato reattore. Sopra era sospesa una canoa ricavata da un tronco, stracolma di una sconcertante congerie di immagini religiose e pupazzetti di peluche. Cercai di capire il messaggio della sala, ma non ci riuscii. Tra le ombre indugiavano tute anticontaminazione vuote, disposte in atteggiamenti di sconcerto e tedio.
La seconda sala ospitava una raccolta completa di cimeli relativi a Chernobyl, nonché un’alta impalcatura di alluminio da cui erano sospesi manichini con addosso l’attrezzatura per ripulire i siti nucleari. Sembrava che volassero in formazione, come una squadra di insoliti supereroi. Il loro capo aveva le braccia alzate e indossava una tuta nera da vigile del fuoco con grandi righe bianche e uno zaino di metallo collegato a una maschera antigas. Attraverso la visiera di vetro dell’elmetto si intravedeva a stento lo sguardo freddo e commerciale di una testa femminile con lunghe sopracciglia e labbra di plastica rosse.
Sotto c’era un modello del reattore prima che si guastasse, in sezione trasversale. Mentre lo studiavo per capirne la struttura interna, due insegnanti in agguato vicino alla porta notarono il mio interesse. Avvicinandosi con i modi seccamente autoritari di due guardie, si affrettarono ad accendere il modellino allungando le mani su un pannello di controllo posto sulla base. Il reattore si accese di una luce calda e mostrò la normale circolazione dell’acqua nel nocciolo. Ma non andava ancora bene. Bofonchiando in ucraino, le due donne cominciarono ad accendere e spegnere l’interruttore, scuotendo e schiaffeggiando il piccolo pannello di controllo e accalorandosi sempre più. Alla fine diedero il colpetto giusto all’interruttore e il resto dei sistemi del reattore – condotte dell’acqua e del vapore, sistemi di raffreddamento e generatori di vapore – prese vita lampeggiando.
* * *
Per capire l’incidente di Chernobyl, è d’aiuto imparare qualcosa su come viene generata l’elettricità, e in particolare sull’energia nucleare, ma quel tanto che basta per non sbadigliare.
In generale, le centrali elettriche generano l’elettricità facendo ruotare delle turbine. Per averne un’idea pensate a una ruota per criceti, molto grande. Ogni turbina è collegata a un generatore, che fa ruotare un circuito attraverso il campo generato da un potente magnete, creando così elettricità come per magia. Poi i tecnici distribuiscono questa energia in giro per continenti interi, pieni di televisori e forni a microonde.
Il vecchio problema, quindi, è semplicemente come far ruotare tutte queste dannate turbine. Possiamo costruire una diga per raccogliere un enorme invaso d’acqua che poi facciamo scorrere nelle nostre turbine. Possiamo costruire pale eoliche con piccoli generatori alimentati dalla rotazione delle pale. Oppure possiamo far bollire tantissima acqua e costringere il vapore a passare ad alta pressione nella turbina.
Quest’ultimo metodo funziona egregiamente, ma serve un bel po’ di calore per produrre vapore a sufficienza. Dove trovarlo? Be’, possiamo bruciare carbone o gas naturale, o persino spazzatura, se vogliamo. Oppure possiamo inventarci una bella fissione nucleare.
Oh, la fissione. La fanno sembrare così complicata, ma l’idea di base la può capire anche un bambino. Saltiamo quasi tutta la fisica che c’è dietro: basta ammucchiare un’enorme quantità di uranio raffinato ed ecco il nocciolo del nostro reattore. Bisogna aggiungere della grafite all’uranio, per non far correre troppo i neutroni che emette.
Ci siamo? Perfetto. Una volta pronto il nocciolo, mettiamoci delle tubature per l’acqua che scorrendo ne disperde il calore, dopo di che facciamo qualche passo indietro e incrociamo le dita.
Alcuni degli atomi di uranio del nocciolo si dividono in due spontaneamente – sono fatti così, che volete – e in questo modo emettono calore e qualche neutrone. Non importa se non sapete che cosa sono i neutroni: basta ricordare che sono piccolissimi e che schizzano via come proiettili, urtano gli atomi di uranio nelle vicinanze e li dividono a loro volta. Così si libera ulteriore calore e ulteriori neutroni, che dividono altri atomi, e così via, e così via, e così via. L’immenso calore provocato da questa reazione a catena riscalda l’acqua, che diventa vapore, che fa girare le turbine a velocità incredibili, che azionano i generatori, che creano una quantità smodata di elettricità, che verrà usata per tenere qualche ufficio sgradevolmente freddo anche in piena estate.
Fin qui, tutto bene.
Il problema di questa reazione a catena è che, per la sua stessa natura, tende a diventare incontrollabile. Così, per tenere a bada gli istinti apocalittici del nostro reattore, faremo bene a infilare nel nocciolo delle barre fatte di boro o di afnio. (Ricordiamoci di prevedere degli spazi appositi quando impiliamo l’uranio.) Queste barre – chiamiamole barre di controllo – fanno da spugne, e assorbono tutti quei neutroni vivaci che sfrecciano in giro. Se le barre di controllo sono inserite per bene, otterremo... niente.
Il trucco, quindi, è di t...