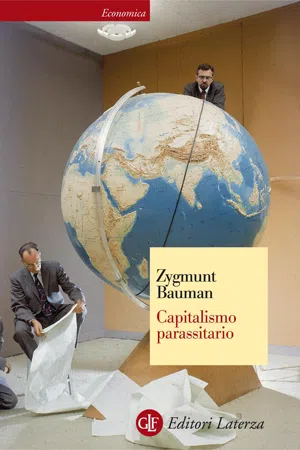La cultura dell’offerta
La cultura, nella sua fase liquido-moderna, è fatta per così dire a misura della libertà di scelta individuale (volutamente ricercata o subita come obbligo). È destinata a servire alle esigenze di questa libertà. A garantire che la scelta rimanga inevitabile: una necessità di vita e un dovere. E che la responsabilità, compagna inseparabile della libera scelta, rimanga là dove la condizione liquido-moderna le ha imposto di stare: a carico dell’individuo, ormai nominato amministratore unico della «politica della vita».
La cultura di oggi è fatta di offerte, non di norme. Come ha notato Pierre Bourdieu, la cultura vive di seduzione, non di regolamentazione; di pubbliche relazioni, non di controlli polizieschi; della creazione di nuovi bisogni/desideri/esigenze, non di coercizione. Questa nostra società è una società di consumatori e anche la cultura, come tutto il resto del mondo visto-e-vissuto dai consumatori, diventa un emporio di prodotti destinati al consumo, ciascuno dei quali si trova in concorrenza con gli altri per conquistare l’attenzione mutevole/vagante dei potenziali consumatori, nella speranza di riuscire ad attrarla e a trattenerla per poco più di un attimo fuggente. La strategia «giusta» (l’unica ragionevole?) è quella di abbandonare gli standard troppo rigidi, compiacersi nel non fare distinzioni, accontentare tutti i gusti senza privilegiarne uno, promuovere la saltuarietà e la «flessibilità» (nome politicamente corretto per indicare l’assenza di spina dorsale) ed esaltare l’instabilità e l’incoerenza; fare i pignoli, mostrarsi sorpresi e stringere i denti è vivamente sconsigliato. La redattrice di un settimanale di «tendenza» ha raccomandato una trasmissione della notte di San Silvestro del 2007 per la sua «vasta scelta di musica, in grado di soddisfare l’appetito di ognuno». «Il suo pregio», ha spiegato, «è la sua attrattiva universale, che consente di entrare e uscire a piacimento dal programma». Una qualità senza dubbio encomiabile e attraente in una società in cui le reti sostituiscono le strutture, e all’attività di «fissare» e «definire» è subentrato il gioco dell’attaccarsi e staccarsi, una serie di connessioni e disconnessioni senza fine.
La fase attuale della progressiva trasformazione dell’idea di «cultura» dalla sua forma originaria, d’ispirazione illuministica, alla sua reincarnazione liquido-moderna è stimolata e gestita dalle stesse forze che promuovono l’emancipazione dei mercati dai residui vincoli di natura non-economica: sociale, politica ed etica e così via. Per conquistarsi l’emancipazione l’economia liquido-moderna focalizzata sul consumatore fa leva sull’eccesso delle offerte, sul loro invecchiamento sempre più rapido e sul pronto dissolversi del loro potere di seduzione – il che, detto per inciso, fa di essa un’economia della prodigalità e dello spreco. Poiché non c’è modo di sapere in anticipo quale delle offerte risulterà abbastanza allettante da stimolare il desiderio di consumo, l’unico modo per verificarlo richiede tentativi ed errori costosi. La continua produzione di nuove offerte e il volume in ascesa costante di beni offerti sono necessari anche per mantenere elevata la velocità di circolazione dei beni, per rinfrescare costantemente il desiderio di sostituirli con beni «nuovi e migliorati» e per evitare che l’insoddisfazione dei consumatori su singoli prodotti si rapprenda in una disaffezione generale verso lo stile di vita consumistico in quanto tale.
Se il mondo popolato di consumatori somiglia ormai a uno di quei grandi magazzini in cui si vende «tutto ciò che ti occorre e che riesci a sognare», la cultura si sta trasformando in uno dei suoi reparti. Anche qui, come in altri reparti, gli scaffali sono stracolmi di merci e vengono riforniti quotidianamente, e le casse sono adornate dalla pubblicità delle nuove offerte, destinata a sparire ben presto con le attrattive che promuove. Sia le merci che i messaggi pubblicitari sono pensati per suscitare voglie e innescare desideri (per avere «il massimo impatto e un’obsolescenza istantanea», per citare la nota espressione di George Steiner). I commercianti e i pubblicitari che le promuovono confidano nel connubio tra il potere seduttivo delle offerte e i radicati istinti dei loro potenziali clienti a «essere un gradino sopra agli altri» e ad «avere una marcia in più».
Diversamente dall’era della costruzione delle nazioni, la cultura liquido-moderna non ha «persone» da «coltivare», ma clienti da sedurre. E, a differenza della cultura «solido-moderna» che l’ha preceduta, non punta più a finire il lavoro (quanto prima, tanto meglio). Il suo lavoro consiste anzi nel rendere permanente la propria sopravvivenza, temporizzando tutti gli aspetti dell’esistenza di coloro che erano affidati alla sua tutela, che rinascono ora come clienti.
La politica solido-moderna che consisteva nel fare i conti con la differenza, nell’assimilare alla cultura dominante, nel privare gli estranei della loro estraneità, sebbene auspicata da alcuni non è più sostenibile. Ma nemmeno le vecchie strategie di resistenza all’interazione e fusione tra culture hanno probabilità di funzionare, per quanto siano preferite da chi è affezionato alla rigida separazione e all’isolamento delle «comunità di appartenenza» (più precisamente, delle comunità-di-appartenenza-per-nascita).
«L’appartenenza», afferma Jean-Claude Kaufmann, è oggi «utilizzata principalmente come risorsa dell’ego». Kaufmann sconsiglia di pensare alle «collettività di appartenenza» necessariamente come «comunità integranti», e raccomanda piuttosto di concepirle come fenomeni che accompagnano il processo di individualizzazione, come una serie di stazioni di servizio o di motel lungo la strada che contrassegnano la traiettoria dell’io che si forma e riforma continuamente.
François de Singly fa giustamente notare che le teorizzazioni sulle identità di oggi farebbero bene ad abbandonare le metafore delle «radici» e dello «sradicamento» (e, potremmo aggiungere, il tropo ad esse correlato dell’«estirpazione»), che implicano un atto una tantum, definitivo e irreversibile di emancipazione individuale dalla tutela della comunità di nascita, e a sostituirle con le immagini del gettare e issare le ancore.
In effetti issare un’àncora, contrariamente allo «sradicare» e all’«estirpare», non ha niente di irrevocabile, tanto meno di definitivo. Le radici, quando vengono divelte dalla terra in cui si sono sviluppate, generalmente si disseccano e appassiscono, uccidendo la pianta che nutrivano, e se questa rifiorisse ciò avrebbe del miracoloso; al contrario, le ancore vengono issate solo nella speranza di poterle felicemente gettare altrove; e possono essere gettate con la stessa facilità in tanti porti, diversi e distanti tra loro. Inoltre, le radici disegnano e predeterminano la forma della pianta che si svilupperà da esse ed escludono la possibilità di ogni altra forma; le ancore, invece, sono soltanto strumenti ausiliari della nave e non ne definiscono caratteristiche e qualità. Il lasso di tempo che separa l’atto di gettare un’àncora da quello di issarla di nuovo non è che un episodio nella rotta della nave. La scelta del prossimo porto in cui gettare l’àncora dipenderà molto probabilmente dal tipo di carico che la nave trasporta in quel momento; un porto adatto a un tipo di carico potrebbe essere totalmente inadatto a un altro.
Tutto sommato, la metafora dell’àncora coglie ciò che sfugge alla metafora dello «sradicamento»: l’intreccio di continuità e discontinuità nella storia di tutte le identità contemporanee, o quanto meno di un loro numero crescente. Simili a navi che attraccano, frequentemente o saltuariamente, in diversi porti, i vari io in cerca di riconoscimento e di conferma della propria identità si sottopongono alla verifica e all’approvazione delle proprie credenziali nelle «comunità di riferimento» cui chiedono di essere ammessi nel corso del viaggio (che dura tutta la vita); e ogni «comunità di riferimento» definisce i requisiti sul tipo di documentazione da presentare. Tra i documenti da cui dipende l’approvazione vi sono di solito il registro della nave e/o il diario di bordo del comandante, e a ogni fermata il passato (sempre più appesantito dagli atti dei precedenti scali) viene nuovamente esaminato e valutato.
I.
La storia dell’istruzione ha conosciuto molti periodi critici durante i quali diveniva evidente che premesse e strategie collaudate e apparentemente affidabili non f...