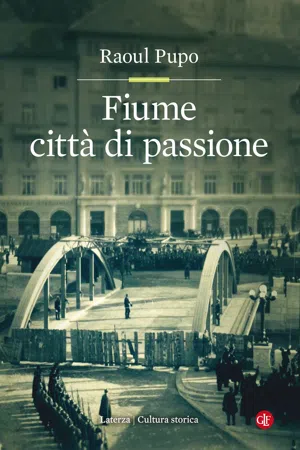1.
Il Corpo separato
1. Le radici
Che debba toccare proprio a Fiume diventar simbolo e pegno della «più Grande Italia» non è per D’Annunzio convinzione antica, anche se ha già avuto contatti con gli irredentisti fiumani: tant’è che il Vate, nel rivelare al mondo come sia ormai pronto lo spazio mistico per l’apparizione della nuova divinità della Patria, nel gennaio del 1919 ha pensato bene di rivolgersi non ai fiumani che pur ne attendono ansiosi l’avvento, ma agli italiani di Dalmazia, terra evocatrice delle glorie di Venezia che il poeta sogna da tempo di rinverdire1. Del resto, della città rintanata in fondo al golfo del Quarnaro fino ad un paio di anni prima ben pochi hanno sentito parlare. Ai tempi del patto di Londra il governo italiano non ha insistito per inserirla fra i territori da rivendicare a danno dell’Austria-Ungheria e ciò non per distrazione o ignavia, ma perché non ne ha sentito la necessità: né strategica, ché il controllo dell’Alto Adriatico verrebbe comunque assicurato dal possesso di Pola e della Dalmazia, mentre per converso la città sarebbe indifendibile per via di terra; né politica, posto che Fiume non rientra nel novero delle città simbolo dell’irredentismo italiano, a differenza di Trento, Trieste, Zara e financo Spalato.
Le ragioni della lontananza di Fiume dalla temperie risorgimentale stanno nei particolari approdi cui è pervenuta agli inizi del Novecento la sua plurisecolare storia, che a sua volta presenta una delle tante possibili varianti del modello comune delle città dell’Adriatico orientale. Infatti, dopo il collasso dell’Impero romano d’occidente, nel cui ambito è fiorita la civiltà urbana sulle sponde orientali adriatiche, e dopo l’ingresso delle genti slave che hanno ripopolato l’Illirico spingendosi fino alle porte della pianura padana, a partire dall’Alto Medioevo i centri costieri sono divenuti il luogo d’incontro – talvolta pacifico, altrimenti conflittuale – fra due mondi. Il mondo dell’entroterra, in fase di passaggio fra l’assetto tribale e quello feudale, dominato da stirpi germaniche, slave e magiare, cui assai più tardi si aggiungeranno gli ottomani, e nel quale l’urbanizzazione è assai rada. E il mondo del mare, antico elemento unificante delle riviere mediterranee, luogo degli scambi di merci, persone e idee, dove la latinità si è mantenuta nella lingua, nella cultura, nei rapporti di dominio della città sulla campagna e nella stessa numerosità dei centri urbani, simile a quella della penisola italica. Tutta l’area adriatica è divenuta quindi frontiera: ma questa non va intesa tanto come una sorta di muraglia cinese fra universi alternativi, secondo lo schema dello «scontro di civiltà», quanto piuttosto come un’ampia zona di sovrapposizione fra spazi culturali e linguistici, economie complementari e modelli istituzionali diversi, nonostante nel corso dei secoli non siano certo mancati i confini «duri», come quelli fra Venezia, gli Asburgo e l’Impero ottomano2.
Se gli ingredienti di quella mescolanza sono stati sostanzialmente i medesimi, dalle foci del Timavo fino alle bocche di Cattaro, gli esiti possono variare assai. Basta considerare due casi speculari. All’estremità meridionale della Dalmazia la città di Ragusa, che alcuni ritengono la quinta repubblica marinara italiana ed altri il luogo storico di un’originale simbiosi slavo-romanza3, sperimenta una crescente diffusione dell’idioma slavo anche all’interno del patriziato di origine latina, fino a che nel XIV secolo il dialetto croato diviene lingua corrente della popolazione e della sua classe dirigente, peraltro bilingue e strettamente connessa alle forme di civiltà elaborate nella penisola italica. All’estremità settentrionale dell’Adriatico, invece, Fiume segue la traiettoria inversa. Centro urbano di origine incerta, vagamente attestato solo dopo il Mille e con un plurilinguismo confermato da nomi e toponimi, vede progressivamente rafforzarsi la componente romanza grazie ai contatti marittimi sempre più intensi con l’Istria e l’Italia. Così, fra Tre e Quattrocento sembra che la popolazione abbia in prevalenza parlato un dialetto veneto, nel quale ad esempio viene redatto un «calmiere del pesce»4; il clero secolare sa poco di latino e nell’uso liturgico ricorre in genere al veteroslavo ecclesiastico, ma l’inventario del tesoro del duomo è scritto in italiano; all’interno della classe dirigente prevalgono nettamente i nomi slavi, ma agli inizi del XVI secolo la proporzione si inverte: 93 nomi italiani contro 57 croati ed alla fine del secolo questi ultimi scompariranno quasi del tutto5.
Ciò non vuol dire che le diversità linguistiche abbiano giocato, fino all’incombere della contemporaneità, un ruolo decisivo nei processi di identificazione collettiva, perché altri, per lunghissimo tempo, sono stati i marcatori identitari prevalenti. Ad esempio, la differenza religiosa, assai rilevante in un’area in cui si confrontano cattolici, ortodossi e musulmani. Oppure, la fedeltà dinastica e, più ancora nelle città d’impronta italica, quel municipalismo che in epoca medievale è stato all’origine di rivalità feroci e guerre sanguinose, come quelle fra Venezia e le città costiere istriane e dalmate. Appena nel XIX secolo la questione della lingua assumerà la funzione di stimolo e coagulo per una ridefinizione identitaria in nome della nuova idea di nazione, ma l’eredità municipalista non si dissolverà affatto in un baleno di fronte all’astro nascente. Al contrario, in tutta l’area giuliano-dalmata l’autonomismo di matrice municipale conserverà la sua vitalità sino allo scoppio della Grande Guerra, entrando con modalità e ritmi diversi in dialogo con il nascente principio nazionale, e continuerà anche successivamente a sopravvivere sottotraccia, con repentini affioramenti, fino al secondo dopoguerra. A Fiume, in particolare, come avremo modo di vedere più distesamente, l’autonomismo costituirà lo strumento duraturo di legittimazione politica del patriziato locale, diventerà il cardine dell’identità cittadina, uscirà vittorioso dal confronto con il nazionalismo dannunziano, capitolerà solo di fronte alla violenza fascista sostenuta dal governo italiano, per venir infine distrutto, mediante la strage e la dispersione dei suoi aderenti, dalla strategia del terrore applicata dal regime comunista jugoslavo dopo il 1945.
A dire il vero, nonostante l’ideologia autonomista si fondi sul mito delle antiche libertà civiche, Fiume non nasce come libero comune ma quale dominio di feudatari germanici: dapprima i signori di Duino, poi i Walsee, infine gli Asburgo, che raccolgono l’eredità di tutti gli altri. Nondimeno, la «Terra di san Vito», come viene usualmente chiamata nelle fonti medievali, gode di amplissime forme di autogoverno, come del resto è usuale per le realtà territoriali dell’epoca.
A Fiume, quindi, per secoli i cittadini si amministrano da soli, applicando gli statuti che essi stessi si sono dati. Di quegli statuti possediamo solo una versione assai tarda, del 1530, che però probabilmente rispecchia consuetudini più antiche6. Al centro del sistema sta un Consiglio formato da un numero ristretto di membri nominati a vita ed integrati per cooptazione, segno dell’esistenza di un’oligarchia chiusa a base originariamente patrimoniale – e segnatamente commerciale – che però si trasformerà rapidamente in un patriziato tenacemente impegnato a difendere quell’autonomia cittadina che sancisce anche la sua egemonia sociale. Ci riesce con alterna fortuna. Secondo lo statuto cinquecentesco, Fiume, che non appartiene a nessuna provincia (Land) dell’Impero ma viene considerata territorio immediato della Corona (Kronland), presta regolarmente atto di sottomissione direttamente al sovrano o ad un suo delegato. Nella prima metà del Settecento, però, i tentativi di razionalizzazione della composita monarchia asburgica compiuti dagli imperatori Carlo VI e, soprattutto, Maria Teresa rischiano di intaccare gravemente il medievale sistema di autogoverno municipale, inserendo anche Fiume nella nuova Provincia mercantile del Litorale, facente capo a Trieste, città sulla quale il governo di Vienna ha evidentemente deciso di puntare come centro propulsivo di una nuova politica adriatica.
Il 21 luglio 1718 il trattato di Passarowitz ha segnato la fine delle secolari ostilità fra l’Impero asburgico e quello ottomano. Nel 1683 per l’ultima volta i turchi si sono scagliati all’attacco delle mura di Vienna; trentacinque anni dopo devono rinunciare anche a Belgrado ed ogni minaccia ottomana svanisce dal cuore dell’Europa. Anche le guerre di religione che nel secolo precedente hanno portato allo stremo la compagine degli Asburgo sono ormai un ricordo ed esaurita si è pure quella conflittualità con Venezia che per secoli ha insanguinato l’area istriana. Ma agli inizi del Settecento tutto ciò è ormai passato e dunque la corte imperiale può finalmente dedicarsi ad un’impresa assai più proficua: far quattrini. Uno dei sistemi più efficaci, in un’epoca in cui la rivoluzione industriale non si è ancora fatta vedere, consiste nel tuffare le mani nel gran fiume di ricchezze che lambisce le coste europee, dalle Indie verso l’Europa. Ci sono già riusciti spagnoli, portoghesi, olandesi, inglesi e francesi: è ben ora quindi che ci provino anche gli austriaci, tanto più che al grande stato danubiano gli sbocchi sui mari giusti non mancano di certo, anche se un oss...