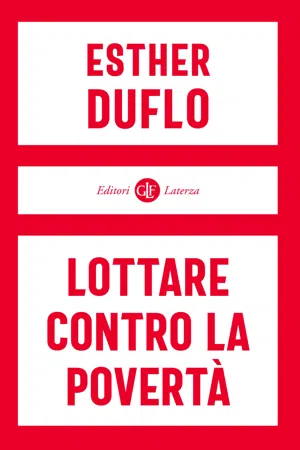Lottare contro la povertà
[Lezione inaugurale del Collège de France n. 202, pronunciata giovedì 8 gennaio 2009.]
Nel 2005 1,4 miliardi di persone vivevano con meno di un dollaro al giorno; ogni anno, almeno 27 milioni di bambini non ricevono le vaccinazioni essenziali, 526.000 donne perdono la vita durante il parto e più di 6,5 milioni di bambini muoiono prima di compiere un anno; più della metà dei bambini scolarizzati in India non è in grado di leggere un testo lungo un paragrafo.
Davanti all’ampiezza, la complessità e lo sgomento che provocano situazioni del genere, si sarebbe tentati di arrendersi o di proporre soluzioni radicali, di promettere la fine della povertà. Con questa cattedra, Saperi contro povertà, vorrei proporvi una terza via, ambiziosa ma consapevole dei suoi limiti. Noi non deteniamo il segreto della fine della povertà: tuttavia, è possibile lottare meglio contro i mali che genera. Il sapere ha un suo ruolo in questo sforzo: deve aiutarci a proporre delle soluzioni e a valutarne l’adeguatezza.
Mi dedicherò a mostrare il ruolo che l’economia può svolgere nella lotta contro la povertà, presentando il metodo sperimentale nel campo dell’economia dello sviluppo. Esso privilegia la sperimentazione creativa: parte dal principio che è possibile migliorare la politica economica e sociale tentando dei nuovi approcci e ricavando insegnamenti dai loro successi e insuccessi. Le politiche di contrasto alla povertà sono esaminate con il rigore delle sperimentazioni cliniche: idee nuove e vecchie soluzioni vengono valutate sul campo, per individuare quali politiche siano efficaci e quali no. In questo modo, arriviamo a comprendere meglio i processi di fondo all’origine del persistere della povertà. Scienza e lotta contro la povertà si rinforzano così vicendevolmente.
1. Sradicare la povertà
Il dibattito sullo sviluppo a volte sconfina nella caricatura. Per alcuni, come ad esempio Jeffrey Sachs, direttore dell’Earth Institute alla Columbia University e consigliere speciale delle Nazioni Unite, autore di un libro intitolato La fine della povertà, la povertà potrebbe essere eliminata nel giro di vent’anni se i paesi ricchi si mettessero d’accordo per investire denaro a sufficienza per aiutare i paesi poveri (in particolare se gli aiuti esteri passassero, in volumi annui, dai 65 miliardi di dollari del 2002 a 195 miliardi nel 2015). Secondo Sachs, infatti, i paesi poveri sono prigionieri di una «trappola della povertà», dovuta nello specifico a clima, svantaggi geografici e malattie. Azioni mirate (sovvenzioni per i concimi, microcredito, zanzariere, scuole gratuite ecc.) li metterebbero nelle condizioni di liberarsi da questa trappola.
Per altri, come William Easterly, che combatte le tesi di Jeffrey Sachs dall’altra estremità della Grande Mela, la New York University, gli aiuti economici non possono risolvere il problema. Al contrario, gli effetti deleteri di questi ultimi (corruzione, dirottamento delle priorità dello Stato ecc.) superano di gran lunga quelli positivi. Nel suo libro I disastri dell’uomo bianco, Easterly denuncia l’industria degli aiuti allo sviluppo, un colossale fallimento che sopravvive solo per gli interessi della lobby che lo sostiene. Ma se è pessimista sull’efficacia degli aiuti, in fondo è un ottimista. Anche lui, infatti, pensa che la povertà possa essere eliminata, grazie a una crescita economica sostenuta: la Cina e l’India hanno portato molti più benefici ai loro cittadini con anni di crescita rapida che con gli aiuti allo sviluppo. William Easterly osserva giustamente che la crescita economica è un segreto quasi impenetrabile. L’India, che oggi viene incensata, negli anni Ottanta era il fanalino di coda del pianeta. Il Brasile, invece, ha percorso il cammino inverso. In generale, i tassi di crescita variano notevolmente da un periodo all’altro. Ma Easterly propone una soluzione al problema: libertà, democrazia e mercato. Facendo riferimento a Hayek e a Friedman, spiega che il libero gioco delle forze del mercato e della concorrenza consente alle risposte più appropriate di emergere, assicurando la prosperità di tutti nel lungo periodo. Ogni tentativo di forzare questo processo serve solo ad aumentare il rischio che esca dai binari.
Jeffrey Sachs e William Easterly non sono i soli ad avere scoperto il segreto della fine della povertà. Il «Consenso di Copenaghen» (un consenso autodichiarato), animato da Bjørn Lomborg, si è attribuito il compito di valutare le soluzioni ai problemi del mondo: la versione del suo rapporto dedicata ai non addetti ai lavori millanta di aver stabilito «Come spendere 50 miliardi per un mondo migliore». Paul Collier, un economista dell’Università di Oxford, propone, nel suo libro L’ultimo miliardo, una serie di raccomandazioni precise, fra cui l’uso combinato della forza e di aiuti umanitari più o meno imposti negli Stati allo sbando.
Questi esperti si dividono lo spazio pubblico e spesso litigano aspramente fra loro. Tuttavia, hanno molte cose in comune. Innanzitutto il fatto di rivendicare una legittimità scientifica. Così, per valutare i vari modi per spendere 50 miliardi, Bjørn Lomborg ha riunito a Copenaghen una serie di economisti, fra cui cinque premi Nobel. In secondo luogo, i loro argomenti poggiano su analisi statistiche, spesso basate su confronti tra paesi. Infine, le loro soluzioni non ammettono né il dubbio né la complessità.
Questa tendenza alla polarizzazione del dibattito accessibile al grande pubblico nel campo delle scienze umane non è sorprendente. Il dibattito politico non contempla sfumature. Per sopravvivere nello spazio pubblico, un discorso su un problema che suscita emozioni forti come la povertà deve inevitabilmente proporre un piano d’azione e una linea chiara. Ma trattandosi di una discussione su problemi di cui i cittadini dei paesi ricchi non hanno esperienza diretta, deve anche assumere le sembianze di un dibattito legittimo fra esperti. L’aspettativa di un dibattito «scientifico» e «razionale», ma senza sfumature (e preferibilmente polemico) è dunque forte.
Polarizzare e semplificare il discorso scientifico, però, è dannoso. Ignorare la complessità conduce a un impoverimento del lavoro di ricerca. Si potrebbe rispondere che la comunità scientifica commetterebbe un grave errore se evitasse di prendere di petto le grandi domande con il pretesto che non è in grado di fornire risposte perfette. È altresì opinione generale che quando il problema è grande debbano essere grandi anche le soluzioni: a mali estremi, estremi rimedi. Ed è più importante proporre rimedi estremi plausibili che dedicarsi a dimostrare nel dettaglio e in modo irrefutabile la validità di un’argomentazione.
Per individuare tali estremi rimedi, questi esperti utilizzano tutti la stessa banca dati, che mette insieme, per un gran numero di paesi, informazioni sul Pil, la popolazione, il livello di istruzione e tante altre variabili, dalle istituzioni alle guerre civili, passando per la latitudine e l’incidenza della malaria. Partendo da questi dati, tentano di mettere a punto un modello statistico che consenta di spiegare il livello di ricchezza o la crescita di un paese. Così, William Easterly dimostra che i paesi che ricevono più aiuti non crescono più rapidamente degli altri, contraddicendo un precedente articolo di Craig Burnside e David Dollar, due economisti della Banca mondiale i quali mostravano, al contrario, che gli aiuti erano associati a una crescita forte se il paese era dotato di istituzioni solide. Jeffrey Sachs osserva invece che i paesi dove l’incidenza della malaria è forte crescono più lentamente. Daron Acemoğlu e Simon Johnson obiettano che i paesi che hanno registrato il più forte incremento dell’aspettativa di vita grazie ai progressi scientifici intervenuti dopo la seconda guerra mondiale non sono per questo diventati più ricchi.
Da dove si originano queste contraddizioni? Dal fatto che è sempl...