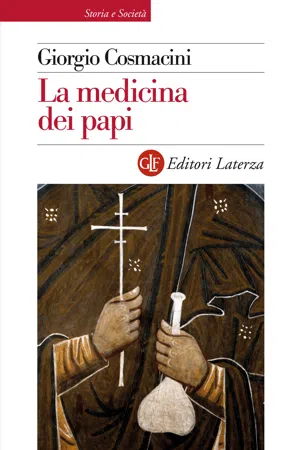XVI.
Della vita umana.
Paolo VI e la bioetica,
prima e dopo di lui
Al pontefice di estrazione nobiliare, Pacelli, e a quello di estrazione contadina, Roncalli, quasi a mediare fra i due pure per nascita, succede un papa di estrazione borghese, Paolo VI, cardinale Giovanni Battista Montini (1897-1978), bresciano, figlio di Giorgio Montini, esponente del Movimento sociale cattolico e deputato al parlamento per tre legislature.
Eletto il 21 giugno 1963, il nuovo papa assume il nome paolino in onore e memoria di Paolo V (cardinale Camillo Borghese), il pontefice amante delle fontane di Roma e l’«apostolo delle genti» promotore dell’espansione missionaria in America, Asia e Africa. I suoi anni di regno (1605-1621) erano stati il «periodo d’oro dei poveri» anche per il sostegno da lui dato all’Ordine dei Ministri degli Infermi, fondato nel 1591, per l’assistenza ai malati, da Camillo de Lellis (1550-1614).
La figura di Paolo VI che emerge dai tre lustri del suo pontificato, concluso il 6 agosto 1978, è quella di un papa intenzionato a confermare la continuità del lascito giovanneo, riassunto nell’impegno di «comprendere gli erranti più che condannare gli errori» e riaffermato da Giovanni XXIII in punto di morte con l’invito a «servire l’uomo in quanto tale, e non soltanto i cattolici».
Dalla costituzione Gaudium et spes, «Gaudio e speranza», che nel 1965 conclude il Concilio Vaticano II voluto da papa Giovanni, a parte le riforme liturgiche (tra cui la messa non più in latino), viene rilanciato il ruolo del laicato e affermato il principio della libertà religiosa quale punto d’incontro con i «fratelli separati» delle altre confessioni cristiane (protestanti e ortodossi). A tale ecumenismo religioso, per ora non esteso ad altre confessioni, Paolo VI aggiunge la ricerca di un equilibrio fra innovazione e tradizione, da un lato operando la scelta preferenziale di una «andata verso i poveri», dall’altro irrigidendo la posizione della Chiesa verso forme inusuali di radicalismo innovatore (tra cui la «teologia della liberazione» e la presenza dei «preti operai»).
Del meditato e cauto progressismo di Paolo VI fa fede l’enciclica Populorum progressio emanata il 26 marzo 1967, la quale bolla l’«imperialismo internazionale del denaro». Di una tale «tirannia evidente e prolungata» le tentazioni da respingere sono
il profitto come motivo essenziale del progresso economico, la concorrenza come legge suprema dell’economia, la proprietà privata dei mezzi di produzione come un diritto assoluto, senza limiti né obblighi sociali.
Queste affermazioni, sottoscrivibili in pieno non solo da democristiani di sinistra ma anche da uomini di sinistra non democristiani (o dagli appartenenti alla categoria unificante dei «catto-comunisti»), sono controbilanciate nella medesima enciclica dalle parole con cui il papa denuncia il fatto «che talvolta può imporsi una mistica esagerata del lavoro» che reca con sé il pericolo di una «insurrezione rivoluzionaria».
Una siffatta rivoluzione
è fonte di nuove ingiustizie, introduce nuovi squilibri e provoca nuove rovine. Non si può combattere un male reale a prezzo di un male più grande.
I mezzi per guarire dal male reale e per evitare l’eventuale male maggiore, nonché per trasformare lo sviluppo dell’economia e della tecnica in un progresso non fittizio ma vero, sono riposti nelle mani dell’uomo sorrette da quelle del «suo Creatore»:
la tecnocrazia di domani può essere fonte di mali non meno temibili che il liberalismo di ieri. Economia e tecnica non hanno senso che in rapporto all’uomo che esse devono servire. E l’uomo non è veramente uomo che nella misura in cui, padrone delle proprie azioni e giudice del loro valore, diventa egli stesso autore del proprio progresso.
Gli sviluppi della tecnologia, cioè della scienza applicata alla tecnica, iniziati in Italia nel periodo del cosiddetto «miracolo economico», hanno avuto un’accelerazione progressiva culminante nella «rivoluzione tecnologica» e coinvolgente sempre più, anche sotto l’aspetto morale, l’uomo che ne è l’autore e il fruitore, al tempo stesso l’utilizzatore e l’artefice.
In biologia e medicina, la tecnologia rivoluzionaria ha o dovrebbe avere come fine non solo o non tanto l’aumento di produttività delle tecniche, quanto, o soprattutto, il miglioramento delle risposte ai bisogni e ai diritti. Perciò la cultura di supporto è o dovrebbe essere più ampia della sola scienza applicata, ampliandosi alla valutazione dei problemi etici che spontaneamente nascono dalle applicazioni medesime, tra le quali, al primo posto, quelle implicanti la «vita umana».
Humanae vitae è la specificazione tematica dell’enciclica emanata da Paolo VI il 25 luglio 1968. Essa ha per argomento «la propagazione della vita secondo l’ordine naturale e cristiano». Più specificatamente, oggetto dell’intervento papale è la «regolazione della natalità» conformata alla «dottrina fondata sulla legge naturale illuminata e arricchita dalla Rivelazione divina».
Il dettato pontificio dà per scontato che la parola rivelata sia coessenziale al linguaggio parlato dalla scienza e dalla tecnica. Esso muove dalla constatazione che «col recente evolversi della società si sono prodotti mutamenti che la Chiesa non può ignorare»: anzitutto lo «sviluppo demografico», con «la popolazione mondiale in crescita più rapida delle risorse a disposizione»; poi il «difficile sostentamento di un numero elevato di figli» da parte di molte famiglie indigenti; infine i cambiamenti mentali e comportamentali relativi alla «persona della donna», al «matrimonio» e agli «atti coniugali in relazione con questo». Si tratta di mutazioni sulle quali il «magistero della Chiesa» è chiamato a «nuova approfondita riflessione» per quanto concerne sia i «principi dottrinali», sia le «direttive pastorali».
Il «problema della natalità» è affrontato nell’accezione «non solo naturale e terrena, ma anche sovrannaturale ed eterna». Culla del matrimonio, che è un contratto umano ma soprattutto un sacramento divino, è l’amore coniugale consacrato da Dio, che è «Amore e Padre». Una «paternità responsabile» (e ovviamente una responsabile maternità) è tale solo se conforme alla «intenzione creatrice di Dio, che si manifesta nell’insegnamento costante della Chiesa» basato sulla inscindibilità del duplice aspetto dell’«unione» e della «procreazione».
Unione è l’atto sessuale che nel talamo coniugale unisce l’uomo e la donna per procreare. La sessualità, per usare una dizione obsoleta, è intesa ad prolificandum, finalizzata soltanto in subordine ad extinguendum fomitem concupiscientiae. La dottrina non ammette che il fine primario sia posposto a quello subordinato mediante il ricorso a «vie illecite» in quanto «infeconde».
Illeciti sono i mezzi e i metodi impiegati per il controllo preventivo della natalità che non ottemperano all’hic non peccatur. Sono tali, anche se la prosa dell’enciclica non ne fa specifica menzione, forse non il coitus interruptus, ma certamente il «profilattico» e la «pillola anticoncezionale» (realizzata negli anni Cinquanta dal biologo ed endocrinologo Gregory Pincus e già di largo consumo negli anni Sessanta). Sono pratiche che fanno «perdere il rispetto della donna», ridotta a «semplice strumento di godimento egoistico».
A fronte di questa illiceità, l’enciclica papale «della vita umana» sottolinea la «liceità del ricorso ai periodi infecondi» della donna (secondo il metodo Ogino-Knaus) e la necessità di «creare un ambiente favorevole alla castità».
Ma ben altro è l’obiettivo d’importanza «vitale». In un periodo nel quale si legifera sul divorzio e si dibatte sull’aborto, l’obiettivo principale è quello di
escludere come via lecita per la regolazione delle nascite l’interruzione del processo generativo già iniziato, e soprattutto l’aborto direttamente voluto anche se per ragioni terapeutiche.
Viene da qui l’«incoraggiamento agli uomini di scienza» affinché i loro «studi cerchino di chiarire più a fondo le diverse condizioni che favoriscono una onesta regolazione della procreazione umana».
Ancora da qui viene l’accorata perorazione rivolta, come sollecita direttiva pastorale, «ai medici e al personale sanitario»: «li abbiamo in altissima stima», dice il papa, esortandoli affinché
nell’esercizio della loro professione, stando a cuore le superiori esigenze della loro vocazione cristiana, perseverino nel promuovere le soluzioni ispirate alla fede e alla retta ragione.
Dalla Chiesa viene così aperta la strada che porta all’obiezione di coscienza nei confronti di una legge dello Stato. Per lo Stato, la sessualità femminile trae un riconoscimento vigoroso dalla dichiarazione con cui, il 16 marzo 1971, la Corte costituzionale sancisce l’illegittimità dell’articolo 553, previsto da un Codice penale promulgato nell’era fascista, secondo il quale, in un contesto ideologico per cui «il numero è potenza» sotto l’aspetto demografico, la contraccezione doveva essere considerata un reato. Ma se la Chiesa continua a considerarla un peccato mortale, lo Stato democratico cessa di colpevolizzare e punire chi la pratica. L’abrogazione della norma rappresenta una delle prime vittorie del movimento femminista, che si batte per l’emancipazione della donna, per un «rispetto» diverso da quello menzionato nell’enciclica e per una diversa concezione della libertà personale.
Per ciò che riguarda la sessualità maschile, va rilevato che l’«ambiente favorevole alla castità» raccomandato nell’enciclica è contraddetto ed eluso dalla pratica onanistica adolescenziale e giovanile, che permane diffusa (9 maschi su 10) nonostante la taccia, accreditata da non poca parte del clero nel ministero del confessionale, che essa sia non solo un vizio peccaminoso, ma un guasto della salute fisica che depaupera il cervello.
Tra caute aperture a spiragli di modernità, nell’enciclica sono gelosamente custoditi – e come potrebbe essere altrimenti? – principi dottrinali che ribadiscono in gran parte gli enunciati della Casti connubii di trentotto anni prima. La loro riproposizione sul finire degli anni Sessanta trae motivazione dal clima «sessantottino» in cui, tramontando valori e disvalori del passato, la donna rivendica una piena autonomia decisionale su tutto ciò che attiene al suo corpo, fertilità, sessualità e riproduzione comprese.
L’enciclica montiniana fa scalpore. La parola del papa è il reagente che fa virare l’opinione pubblica in due poli opposti: da un lato i favorevoli e gli entusiasti, dall’altro i contrari e gli indignati. Lo stesso mondo cattolico è diviso al suo interno: alti prelati e dotti teologi si dividono tra sostenitori e ipercritici, questi ultimi assertori dell’inattualità e inadeguatezza di un dettato che concepisce la corporeità come essenza del corpo spiritualizzato anziché come sostanza di un corpo fatto di carne. È un dettato da cui trapelano una ritrosia per la libertà della scienza e una incapacità a comprendere che i movimenti e sommovimenti dell’impresa scientifica possono tradursi in progressi per la vita umana anche al di fuori degli schemi precostituiti.
La Humanae vitae viene ad apparire come espressione di un magistero ecclesiastico che non solo interviene sulla morale dottrinale ed evangelica, ma pretende d’intervenire pure sulla morale naturale in tutti i suoi aspetti, anche in quelli che la scienza e la tecnica suggeriscono di modificare nella prospettiva di un miglioramento terreno della vita umana.
Come per papa Roncalli, così per papa Montini la storiografia ama indugiare su altri caratteri del suo pontificato: l’abolizione, nel 1966 (dopo quattro secoli), dell’Indice dei libri proibiti; le trasvolate del papa viator, visitatore apostolico dei cinque continenti; il temperamento del papa cunctato...