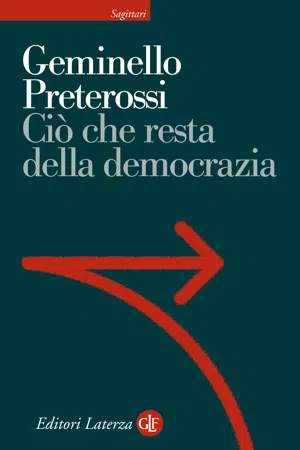
- 208 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Ciò che resta della democrazia
Informazioni su questo libro
Derive oligarchiche, delegittimazione dei partiti, scollamento tra istituzioni e popolo, dominio dei poteri economici. Perché proprio quando la democrazia sembra diventata ovvia, la partecipazione deperisce e il potere reale diventa sempre più opaco e indiscutibile? Può rinascere un'energia politica nuova e dissidente che rompa il conformismo del discorso pubblico dominante, rilanciando la sovranità democratica e la dimensione sociale dei diritti, oggi gravemente minacciate?
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Ciò che resta della democrazia di Geminello Preterossi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Filosofia e Filosofia politica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
FilosofiaCategoria
Filosofia politica1.
Democrazia infondata?
1. Promessa democratica e nichilismo
Una delle ipotesi teoriche in campo per spiegare le crescenti incertezze della democrazia punta non sulla riduzione dello scarto tra modello e realtà della democrazia medesima, sui suoi limiti o difetti contingenti, e perciò superabili, ma sulla sua costitutiva “infondatezza” (che condividerebbe, in definitiva, con il mondo e il pensiero moderni in quanto tali)1. Una posizione, si badi, che non è propria solo di forze e correnti antimoderne e reazionarie, nostalgiche dell’ordine gerarchico e organico, ma che sta sullo sfondo, più in generale, della koinè post-moderna la quale, sul fronte opposto ma simmetrico, nega nichilisticamente tanto la “sostanza democratica” quanto i suoi “soggetti”. In ogni caso, la domanda non può essere elusa, anche da un punto di vista razionalista critico: davvero la democrazia è strutturalmente “infondata”? In che senso il relativismo della democrazia pluralista è compatibile con i principi e i diritti fondamentali del costituzionalismo? Quali sono le risorse di senso della democrazia e come possono essere riprodotte? Esiste un “contenuto minimo” dell’ordine democratico? E quanto può essere “minimo”?
L’istanza di fondazione, per come viene presentata da molti critici del nichilismo (che tendono a identificarlo erroneamente con il relativismo2), cozzerebbe con le caratteristiche peculiari della democrazia moderna (artificialista, pluralista, procedurale, relativista, ecc.). La conseguenza implicita o esplicita di tali chiavi di lettura è che la democrazia, in quanto prodotto eminente della modernità, nella misura in cui, paradossalmente, si “fonda” sulla negazione del “vero” fondamento (quello “assoluto”), sia condannata a essere “nichilistica”3. In realtà, le cose non stanno in modo così semplificato. E la prima mossa da compiere per comprendere il rapporto complesso tra forma e legittimazione democratiche, vuoto e pieno nell’artificio politico-giuridico, è quella di evitare una lettura riduzionista e dimezzata del Moderno. È vero, come abbiamo già evidenziato, che la democrazia può essere intesa come il compimento non solo delle istanze di partecipazione e inclusione sociale poste già a partire dalla Rivoluzione francese, ma del senso originario implicito nell’artificialismo politico-giuridico. Come l’effetto, insomma, della sostituzione della voluntas alla veritas. Ma questo passaggio si impone in virtù di una ratio, fondata sul soggetto. Ed è sulla tenuta di questa idea di ragione non sostanziale e oggettiva, ma artificiale e soggettiva, che si fonda la possibilità di sottrarre la svolta volontarista all’irrazionalismo. La modernità si riempie di contenuti, ma sono contenuti “prodotti” (cioè pensati, argomentati, sentiti, voluti, contesi). Non è chiaro in che senso la “produzione” di contenuto etico-politico – che si nutre di scelte e impegni normativi – ne determinerebbe l’irrimediabile “svalutazione”.
Mi pare che sia possibile individuare tre possibili strade per interpretare il rapporto tra democrazia, diritto moderno e nichilismo, e la crisi che ne risulterebbe: la prima sostiene che la modernità giuridica, e la democrazia con essa, sia in un certo senso sì essenzialmente nichilistica, ma che ciò sia inevitabile e in fondo anche positivo. Il nichilismo è precisamente la risorsa sulla quale contare e di cui fare un elemento di forza della democrazia medesima (e in generale di ogni ordine laicizzato)4. Secondo questa posizione, sarebbe possibile un nichilismo attivo, cioè assunto consapevolmente, che fa dello svuotamento/svalutazione di senso un fattore produttivo di scelta e assunzione di responsabilità. Il nichilismo giuridico non va quindi rigettato (sarebbe velleitario), ma ne deve essere riconosciuta la paradossale legittimità. L’approdo della razionalità giuridica, in ragione della volontà di potenza che presuppone, può essere solo minimalista e formale5. Ma si apre qui un interrogativo che mette in discussione questa soluzione apparentemente radicale, che sembrerebbe risolvere il problema del nichilismo assumendolo, facendolo proprio: scelta qualsiasi, oppure scelta per una precisa eredità normativa (ad esempio per i principi costituzionali, la fioritura delle soggettività, la tutela del lavoro come fattore di umanizzazione)?6 Se la decisione fondamentale delle democrazie costituzionali non può essere una decisione purchessia, pena la perdita del loro profilo, ma una decisione “umanistica” (per quanto immotivabile in ultima istanza dal punto di vista di un “assoluto” religioso o metafisico), si tratterà comunque di una scelta ancorata a un “qualcosa” (un sistema di credenze, un orizzonte etico-politico, una visione storica e antropologica), il cui contenuto sia in grado di “valere” per noi ed essere argomentato/comunicato in generale. Ma se universalismo, costituzionalismo, umanesimo, ecc. sono catturati dalla generale “svalutazione”, come sarà possibile questa “decisione per” e il suo ancoraggio? È come dire che bisogna fingere di credere – sulla base di una decisione infondata e infondabile – nella legittimità di un portato culturale che non avrebbe in sé un plusvalore tale da giustificare il suo nesso intrinseco con la forma di vita democratica. Un “gesto” di pura decisione a favore dell’umanesimo e del razionalismo: ma siffatta democrazia “nietzscheana” è solo una brillante aporia. Se il nichilismo vige e va preso sul serio, se il Moderno non è altro che questo, il deposito di legittimità della democrazia costituzionale si riduce inevitabilmente, così come la possibilità che vi siano soggetti disposti a difenderla e a rilanciarla perché “credono” in essa e nelle potenzialità di vita attiva che offre. Salvo pensare che il nichilismo stesso sia preda della dinamica di svalutazione che descrive, magari perché catturato dal gioco “liberale” dello scambio infinito che tutto ridimensiona: però questo sarebbe proprio il trionfo del “nulla” come mezzo e fine, cioè di un nichilismo passivo che escluderebbe anche lo spazio di autonomia e attività del decisionismo democratico.
La tesi opposta (ma per certi aspetti speculare) a quella del nichilismo attivo, che nella svalutazione di valori e idoli vede un fattore positivo, anche se ambivalente, di liberazione (dalle false illusioni), assume che la modernità sia in sé nichilistica e che a tale sua “costituzione” siano integralmente imputabili, quali suoi effetti sistemici, la crisi antropologica, la decadenza etica, la perdita dell’orientamento ai fini – in definitiva l’antiumanesimo – che monopolizzerebbero il presente. Credendo di liberare l’uomo perseguendo il progetto paradossale di un’autorità dal basso, come sovranità degli individui, il mondo moderno ha minato la possibilità stessa di una vera auctoritas, consegnando l’umanità al servaggio più insidioso, quello imposto dal combinato tecnoscienza-capitalismo finanziario, inaffrontabile perché neutro, opaco, spersonalizzato, e oltretutto sostenuto da un’ideologia individualistica e narcisistica di finta liberazione7, che colonizza l’immaginario sociale servendosi anche del linguaggio dei diritti. Tale chiave di lettura trova una delle sue prime messinscene di successo in Dialettica dell’illuminismo, opera fondamentalmente inattendibile ma che grazie alla sua brillante e un po’ furba ambiguità ha esercitato un notevole influsso anche su correnti culturali molto distanti da quelle francofortesi (ad esempio nel cattolicesimo conservatore8).
C’è però una terza via per affrontare il tema dei fondamenti di legittimità della democrazia e del suo nesso con l’eredità moderna, e a nostro avviso è questa che bisogna percorrere, anche se più complessa e impegnativa. La premessa è che la modernità non sia affatto riducibile al nichilismo: si tratta di un’interpretazione caricaturale, funzionale a obiettivi polemici. Forzare il quadro della storia politica e culturale dell’età moderna, dei suoi concetti politici, delle sue dottrine filosofiche e giuridiche, nel letto di Procuste del nichilismo significa compiere un’operazione di violenza concettuale, fuorviante tanto dal punto di vista storico quanto da quello teorico. Anche gli aspetti che sono interpretabili in questo senso (volontarismo, decisionismo), che pur ci sono, vanno collocati in un contesto ermeneutico più complesso e infatti generano effetti ambivalenti, non univoci. Si tratta di cogliere la verità parziale del nichilismo senza farne un assoluto immediato, collocandolo entro il processo complessivo del Moderno. Ciò che viene nominato con il termine nichilismo (decisione che fa, o suppone di fare, tabula rasa della tradizione), è un fattore di scarto e accelerazione dinamica, ma non è tutto il processo.
La democrazia, esito della politica moderna, non è un regime nichilistico, pur non potendo (ma soprattutto non dovendo) contare su un fondamento “assoluto”. Quei critici del nichilismo che tendono a contrapporre rigidamente fondazione antropologica, personalismo, umanesimo integrale, o addirittura teologia della politica, quali presupposti necessari perché non si dia nichilismo, da una parte, e scientismo, tecnocrazia, mercificazione, indifferentismo etico, quali esiti necessari della compromissione della libertà moderna con l’individualismo radicale, dall’altra, si precostituiscono, per così dire, la vittoria, costruendosi un oggetto polemico di comodo perché mette insieme troppe cose diverse, semplificandole e riducendole ad unum. In questo senso, nichilismo giuridico e neogiusnaturalismo sono speculari e funzionali l’uno all’altro. Il rischio è di fraintendere il concetto di libertà e il suo carattere artificiale, rinaturalizzandola nell’illusione di preservarne l’èthos. Il presupposto di tale fraintendimento è che la volontà, cardine della soggettività libera, sarebbe destinata a rivelarsi inevitabilmente “volontà di potenza”. È invece possibile una via di sottrazione al nichilismo, che non accetta quelle interpretazioni che riducono la libertà a volontà di nulla (o a nulla che vuole se stesso), con il soggetto catturato dall’autofinalità del mezzo e quindi senza fini, se non l’incremento del mezzo medesimo (un soggetto “trasceso” paradossalmente dall’immanenza del meccanismo che alimenta). E che, di conseguenza, non implica la contrapposizione a tale “narrativa” di un nuovo sostanzialismo antropologico (che al fondo si rivela onto-teologico). La volontà attraverso cui si costruisce la democrazia moderna vive non nel solipsismo del soggetto-atomo, ma in dimensioni collettive, e mira a concretizzare idee che motivano all’azione sociale in virtù dei loro contenuti. Quell’energia politica che, soprattutto in alcune manifestazioni (conflitti sul potere e lotte per i diritti, assunzione di scelte di rottura), appare come “esistenziale”, “decisionistica” perché ha dalla sua la forza dell’invenzione politica che rompe la quiete organica della ripetizione sociale “senza alternative”, non è mera, casuale contingenza, ma ha sempre delle radici profonde, un “processo” che la prepara e ne rende possibile l’emersione. Inoltre, se nelle tendenze del turbocapitalismo e della finanza sregolata è in effetti ravvisabile un rischio nichilistico (il circuito autoreferenziale denaro-potere che si impone sulle scelte politiche sui fini proprie della democrazia9), ciò non è frutto di un destino (metafisico, antropologico, storico), ma di scelte precise, di battaglie non ingaggiate, di subalternità ideologiche e sconfitte introiettate.
L’impianto complessivo di questo lavoro si colloca nel solco di questa via alternativa. Cercherò di far emergere, attraverso il riferimento a una serie di autori diversi, persino opposti, ma le cui analisi sono connesse ed evidenziano tanto le risorse quanto le aporie della democrazia moderna (da Habermas a Böckenförde, da Schmitt a Blumenberg, ma tenendo sempre sullo sfondo la lezione dei classici del “politico” moderno, da Hobbes a Hegel), la legittimità di questa terza via, benché appaia a volte come un sentiero stretto e tortuoso.
2. Il doppio lato delle costituzioni novecentesche
Con le costituzioni democ...
Indice dei contenuti
- Introduzione. Lo spaesamento del presente
- 1. Democrazia infondata?
- 2. Ritorno allo Stato (sociale)
- 3. Alle radici del normativo
- 4. Genealogia della spoliticizzazione
- 5. Soggetto e sovranità
- 6. Costruire il popolo
- 7. L’origine politica dei diritti
- Conclusioni. Ripoliticizzare la democrazia