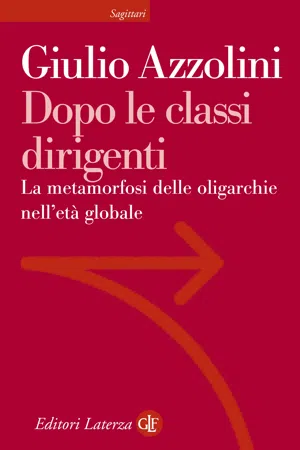IV.
La potenza democratica
delle élites politiche
Che cos’è successo al versante pubblico, e segnatamente politico, di quelle che una volta erano le classi dirigenti? Se la loro componente privata, e in particolar modo imprenditoriale, ha assunto la natura dei gruppi di interesse, qual è stata la declinazione politica del fatto oligarchico? E quale sarebbe, per una prospettiva apertamente democratica, la versione auspicabile di tale “regola”? Vale la pena chiederselo, perché spesso si incorre nella sensazione che i gruppi chiamati élites non siano che meri «giri di potere», impegnati semplicemente a ruotare attorno ai posti di comando.
1. Le nuove figure dell’oligarchia pubblica
Piuttosto che al «ritorno delle élites», oggi pare di assistere alla loro «implosione». Nell’età globale sono altre le figure dell’oligarchia pubblica: i capi politici e i tecnici. Figure, queste, non necessariamente alternative alle élites propriamente intese, ma nient’affatto sovrapponibili ad esse. Come mostrato nel primo capitolo, la nozione di élite non contrastava solo l’ipotesi di una effettiva partecipazione delle masse alle decisioni politiche, ma anche l’ipotesi che queste ultime fossero appannaggio esclusivo di quello che oggi si suole chiamare “l’uomo solo al comando”. La storia ha imboccato, invece, una strada diversa, e si è ricominciato diffusamente a parlare di «democrazia del leader». Ma dietro questa formula felicemente sintetica aleggia lo spettro di un secondo attore, impersonato dai tecnici, che sembra in qualche modo includere, se non superare, l’orizzonte degli stessi leader politici. Ed ecco che si è iniziato a diagnosticare l’avvento di una democrazia senza leader autentici, nella quale «gli stessi governi sono largamente ridotti alla condizione di “amministratori” locali del potere delle oligarchie della finanza e dell’industria collocate al vertice del mercato mondiale».
Capi e tecnici: da una parte il potere visibile e ostentato, dall’altra il potere invisibile e nascosto; da un lato lo storytelling dello «yes, we can!», dall’altro lo stato di necessità in cui «there is no alternative». Quale che sia il tratto decisivo, si propaga comunque «l’impressione che tutto sia visibile ma, allo stesso tempo, la certezza che i poteri che ci determinano sono sempre più invisibili, meno identificabili». Perché il fatto che la scena sia occupata dai prìncipi democratici e che il retroscena sia il regno dei tecnici incrina una delle promesse dell’assetto democratico moderno: la trasparenza nell’esercizio del pubblico potere.
1.1. I capi
Le democrazie contemporanee sono caratterizzate da un protagonismo dei capi politici che non ha precedenti nella storia recente. Il nuovo millennio si è aperto all’insegna dei leader: su di loro, e non sui parlamenti né sui partiti che li animano, poggia il legame sempre più fragile e sottile tra la cittadinanza e le istituzioni rappresentative. I capi odierni insistono nel proclamare come “pienamente democratico” quel legame, guardandosi bene dal pronunciare parole oltraggiose nei confronti della democrazia e tantomeno, ovviamente, del popolo che la sostiene; ciò che la retorica dei capi lamenta è piuttosto una lentezza delle procedure deliberative, una farraginosità che non tiene il ritmo con il “tempo reale” dell’età globale.
Ma come si manifesta questo processo di ascesa dei capi a principali incarnazioni del fatto oligarchico? Si può forse tentare una fenomenologia di quell’eterogenesi dei fini, chiamata ora «bonapartismo democratico», ora «cesarismo democratico», ora «principato democratico»? A diversi interpreti il fenomeno è parso indicare un modello di democrazia ben identificabile o prefigurare, se non altro, uno stadio di sviluppo delle democrazie occidentali. Ma giova innanzitutto distinguere due aspetti: uno istituzionale, l’altro mediatico. Le due dinamiche sono intrecciate, ma vanno tenute distinte: da un lato, si è assistito a una progressiva presidenzializzazione dei sistemi politici; dall’altro, a una spiccata personalizzazione del processo e dell’ambiente politici. E il risultato di questa duplice dinamica è che contano sempre di più non solo i governi rispetto ai parlamenti, ma anche i singoli capi rispetto ai loro stessi partiti.
Nel secondo dopoguerra e per circa trent’anni, le cose erano andate diversamente. In Europa erano stati i parlamenti a rappresentare il luogo della sovranità popolare. Come ricordato nel secondo capitolo, nella tradizione moderna del pensiero politico europeo il governo è per lo più concepito nei termini di un organo esecutivo della volontà popolare, espressa dalla legge statui-
ta nelle assemblee elettive. Il governo è teoricamente al servizio dell’applicazione della legge, subordinato alla decisione politica dei parlamenti. Ma la logica istituzionale rimarrebbe muta, qualora non si prestasse attenzione ai soggetti che la concretizzano. E nell’Europa sopravvissuta agli orrori dei totalitarismi, in cui presidenzializzazione e personalizzazione erano percepite come condizioni illegittime e pericolose, come rischi da scongiurare, sono stati i partiti di massa a confrontarsi nelle competizioni elettorali e a coinvolgere variamente i cittadini nelle istituzioni.
Mentre l’Europa viveva la grande fase dei partiti, però, negli Stati Uniti era già avviata la presidenzializzazione di un sistema politico destinato a sperimentare anche una forte ondata di personalizzazione. Al di là dell’Atlantico la tendenza presidenzialistica aveva preso corpo con il New Deal, quando, per la prima volta in un regime democratico, si assisteva a un processo di rafforzamento del potere governativo in chiave monocratica nei confronti degli altri attori istituzionali. Con un ritardo di trent’anni, anche l’Europa comincerà a conferire sempre più poteri e maggiore autonomia decisionale, non solo all’esecutivo nel suo complesso, ma al primo ministro in modo specifico. In tutte le principali democrazie, dunque, il governo e, in particolare, il capo del governo si sganciano sempre più dai partiti di riferimento.
La presidenzializzazione delle democrazie parlamentari caratterizza l’ultimo quarto del Novecento e non è che la premessa per la successiva personalizzazione del processo e dell’ambiente politici. Un fenomeno, questo, che negli anni Ottanta ha riguardato, con accenti diversi, l’una e l’altra sponda dell’Atlantico. Da Margaret Thatcher nel Regno Unito a Ronald Reagan negli Stati Uniti a Helmut Kohl in Germania, si sono moltiplicati i capi intenti a presidenzializzare le istituzioni e a personalizzare i loro stessi partiti, invertendo così una parabola che per decenni si era sviluppata in direzione contraria. La personalizzazione si è espressa innanzitutto nelle campagne elettorali, laddove il confronto tra candidati-presidenti lascia in secondo piano le formazioni politiche avverse. L’ascesa dei leader è direttamente proporzionale al declino dei partiti, che non sono più al centro della competizione elettorale, né sono più in grado di suscitare l’identificazione di una volta con i cittadini. E il risultato è che all’impersonalità burocratica subentra la personalizzazione del comando, al punto che, negli Stati Uniti come in Europa, sono i leader a connotare l’identità dei partiti e non viceversa.
Ma qui bisogna stare attenti, perché la personalizzazione non ha riguardato soltanto il leader-presidente, bensì anche i notabili. Allo sgretolamento degli apparati di partito non si è accompagnato solo un processo di «macro-personalizzazione», ma pure una capillare dinamica di «micro-personalizzazione», fatta di reti interpersonali intessute attorno a quelli che Mauro Calise ha felicemente ribattezzato come «micro-notabili» locali. Insomma, condizione imprescindibile per un pieno successo dei partiti sembra la presenza di un leader forte e riconosciuto, certo, ma anche di molti capi altrettanto forti e stimati a livello locale.
...