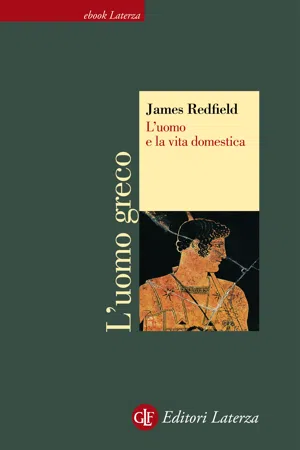L’uomo e la vita domestica
Fonti: la presenza di un’assenza
Uno degli insegnamenti che Arnaldo Momigliano ci ha lasciato è che la storia non riguarda le fonti. La storia è un’interpretazione di quella realtà di cui le fonti sono «segni indicativi o frammenti». Ovviamente noi muoviamo da un esame delle fonti, ma cerchiamo di guardare attraverso di esse alla realtà che rappresentano o che volta a volta non riescono a rappresentare, travisano e persino dissimulano. L’indicazione di Momigliano è particolarmente significativa rispetto al nostro argomento, perché i Greci dell’età classica non ci hanno lasciato quasi nessuna notizia sulla loro vita domestica.
In primo luogo, disponiamo per questo periodo di testimonianze non formali molto scarse – mi riferisco a fonti d’informazione come lettere personali, documenti commerciali, materiali d’archivio, deposizioni rese in procedimenti giudiziari. Non ci mancano invece le rappresentazioni formali: immagini modellate e dipinte, descrizioni letterarie, resoconti storici, analisi filosofiche, discorsi pubblici tramandati come modelli di retorica. Incontriamo i Greci, per così dire, col vestito della domenica: non li cogliamo di sorpresa, ma essi ci appaiono come scelsero di raffigurarsi. Inoltre in questi casi, con poche eccezioni, si tratta di rappresentazioni della vita pubblica. La storia, una volta acquisita la sua forma canonica con Tucidide, si interessò quasi esclusivamente della politica e della guerra. La tradizione filosofica da Pitagora in poi (con l’importante eccezione di Aristotele) ha guardato con ostilità alla «sfera domestica», campo di emozionalità fluttuante, di tendenze antisociali e di basse motivazioni. È più probabile che siano morali le azioni inerenti la vita pubblica, dal momento che, essendo visibili, sono soggette al giudizio del pubblico.
La vita pubblica si svolge in un pubblico spazio. Questa regola ha un singolare riflesso in quella forma artistica che rappresentava al pubblico di Atene l’esperienza privata e le relazioni domestiche, vale a dire il dramma. Sia nella tragedia che nella commedia la scena è ambientata all’aperto, nella strada o in un luogo del genere. I personaggi escono dalla casa – o dal suo equivalente (la tenda di Aiace, la caverna del Ciclope) – e non di rado forniscono qualche spiegazione sul motivo per cui sono usciti a esporre i loro segreti propositi o a lamentarsi dei loro privati dispiaceri. La rappresentazione, in altri termini, rappresenta se stessa come rivelazione di qualcosa che è normalmente nascosto. Questo ci aiuta a capire perché nel dramma le relazioni domestiche siano generalmente rappresentate nella loro anormalità, come interrotte o in crisi. In quanto rappresentazione della vita domestica il dramma è anche una sorta di scandalo.
Nel dramma molti dei personaggi sono femminili. Nella vita di tutti i giorni era motivo di merito per una donna ateniese (come osserva il Pericle di Tucidide) che non si sapesse nulla sul suo conto; le donne che appaiono sulla scena sono in qualche modo screditate o in pericolo già dal momento in cui il pubblico le vede, per il fatto stesso che può vederle. Ciò che normalmente è nascosto non può che essere fuor di luogo quando è rivelato.
I Greci del periodo classico non produssero quel genere di narrativa naturalistica che è una così ricca testimonianza di vita domestica per i tempi moderni. Possiamo senza dubbio dedurre certe cose dalle rappresentazioni di cui disponiamo, ma è come assistere a una commedia, in cui ogni tanto una porta si apre e appare un messaggero, o si affaccia un personaggio a dirci qualcosa di ciò che accade in quel chiuso mondo invisibile. Sulla base di questi accenni e di questi frammenti è possibile fornire una descrizione della vita domestica dell’antica Grecia, ed infatti ciò è stato fatto; il presente saggio adotta tuttavia un diverso modo di procedere. Vuol essere una ricerca sull’idea della «sfera domestica» presso i Greci (soprattutto per quanto se ne può ricavare dai miti e dai riti) e, in modo più specifico, sulla collocazione di tale idea entro l’ideologia della città-Stato. La selezione messa in atto da un popolo nel rappresentare se stesso può dirci molto, tanto per ciò che nasconde che per ciò che rivela.
La soppressione della «sfera domestica»
Cominciamo con un’assenza ben nota ma sconcertante: i Greci dell’età classica non ci hanno lasciato alcuna storia d’amore. L’intreccio che ci è più familiare, quello che si sviluppa quando «uno-incontra-una» e finisce con un «vissero-felici-e contenti», non trova posto nella letteratura greca prima del Dyskolos di Menandro, composto nel 316 a.C., sette anni dopo la morte di Alessandro il Grande. Naturalmente è possibile che alcune opere andate perdute – l’Andromeda di Euripide, ad esempio – seguissero quello schema, e non mancano alcune eccezioni in tal senso nelle opere che ci sono pervenute e che per lo più riguardano gli dei; nella nona Pitica di Pindaro, ad esempio, troviamo Apollo che corteggia la ninfa Cirene; e Omero allude alle avventure prematrimoniali di Zeus ed Era, «allora che d’amore la prima volta s’unirono / entrando nel letto, dei cari parenti all’oscuro» (Iliade, XIV, 295 sg., trad. Calzecchi Onesti). Resta valida tuttavia la regola generale, e ciò è tanto più sorprendente in quanto (a differenza della narrativa di tipo naturalistico) le storie d’amore sono diffuse in tutto il mondo e sono alla base di classici diversi tra loro quanto La storia del principe Genji, o il Sakuntala. E ancora, le storie d’amore costituiscono una parte importante del patrimonio comune delle fiabe popolari indoeuropee, sia che si tratti della storia del figlio ultimogenito che conquista la bella principessa sia che si narri della fanciulla sfortunata tratta in salvo dal suo splendido cavaliere.
Anche i Greci naturalmente raccontavano favole del genere, per esempio come Giasone conquistasse Medea, o Pelope ottenesse Ippodamia, ma nel periodo classico queste non erano propriamente storie d’amore. Pindaro, ad esempio, racconta sia la storia di Pelope che quella di Giasone. Nella prima Olimpica Pelope è certamente un pretendente, ma non lo vediamo corteggiare Ippodamia, che è piuttosto il premio per chi batte suo padre Enomao. Giasone, nella quarta Pitica, ammalia e seduce Medea, che non è peraltro il premio cercato, quanto lo strumento attraverso cui egli porta a termine un’impresa che gli restituirà il suo patrimonio.
In altri termini Giasone non è in cerca di una sposa ma della sua propria eredità. La successione è l’aspetto della vita familiare di cui si preoccupa la narrativa classica. Nell’Antigone, ad esempio, Emone e Antigone sono una coppia di fidanzati – l’amore di lui per la ragazza costituisce il «punto di crisi» dell’intreccio tragico –, ma il tragediografo non li mette mai insieme sul palcoscenico: Antigone diventa piuttosto il motivo del conflitto tra Emone e suo padre. Clitennestra uccide un marito e ne sposa un altro, ma la sua tragedia sta nel rapporto con Oreste, che deve uccidere la madre per rivendicare i suoi diritti sul regno del padre. C’è quindi Edipo: i suoi guai cominciano dall’infanzia, quando suo padre tenta di ucciderlo, e continuano quando – per caso – egli recupera il suo patrimonio uccidendo il padre e diventando il marito di sua madre. I problemi sorgono quando un genitore cerca di impedire il giusto succedersi delle generazioni. Allo stesso modo la contesa tra Pelope ed Enomao diventa omicida, perché Enomao non voleva consentire al matrimonio di sua figlia e per questo sfidava tutti i pretendenti a una corsa di carri. Faceva partire per primo lo sfidante, poi lo raggiungeva con i suoi magnifici cavalli e lo pugnalava alla schiena. In questo modo aveva ucciso dodici giovani. Il tredicesimo, Pelope, riuscì (in modi diversi a seconda delle versioni) a uccidere Enomao e conquistò Ippodamia.
In una versione Enomao voleva sposare egli stesso Ippodamia, e questo tema incestuoso si può considerare latente in tutte le versioni: sposare la propria figlia è come uccidere il proprio figlio, un rifiuto di «mollare», di lasciar posto alla generazione successiva.
Gli dei, essendo immortali, non hanno questo problema, o piuttosto, proprio perché immortali, hanno il problema inverso. La Teogonia di Esiodo racconta estesamente come i due maggiori tra gli dei, Urano e Crono, tentassero invano, ognuno a sua volta, di impedire la propria successione; Zeus, terzo in linea discendente, rimise ordine nel cosmo. Ci riuscì divorando, piuttosto che sposando, Metis, sua prima moglie. Dalla testa di Zeus nacque così Atena – che era in tutto devota a lui, in quanto padre e madre insieme –, mentre fu evitata la nascita di un figlio che avrebbe potuto essere migliore di suo pad...