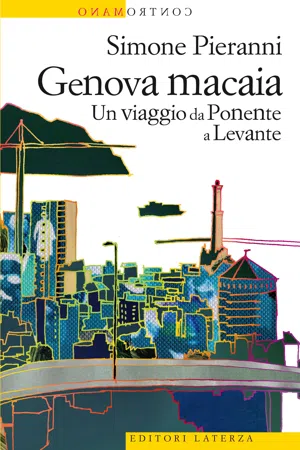
- 160 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Genova è un modo di essere.Genova è un alto e un basso continuo, è un infinito salire e scendere. È un continuo racchiudere, restringere, contenere. Genova è megalomane, con questa storia del centro storico e della macaia. Genova nasconde, bara e inganna. Apparentemente schiva e sulle sue, sotto sotto pensa sempre a tenersi aperta una possibilità di fuga.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Genova macaia di Simone Pieranni in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Media & Performing Arts e Theatre History & Criticism. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Media & Performing ArtsCategoria
Theatre History & CriticismVoce di Genova #1
La madre di mio padre
Se certe storie non sono vissute, meglio farsele raccontare. Ed eccomi qua. Sono nata talmente tanti anni fa da aver dimenticato la data. Sono stata operaia, bottegaia, madre. Sono tua nonna: ho vissuto di straforo la Resistenza e più da protagonista «i fatti del 1960»: quella Genova che forse oggi per te è la migliore. Quella che in fondo ricordano tutti con grande affetto e rispetto. Sei cresciuto con me, ti dicevo che avevi gli occhi sulla punta delle dita, perché sembrava volessi sempre toccare tutto. Prima gli oggetti, quando eri piccolo. Poi perfino i concetti, quando sei diventato più grande. Mentre ti preparavo i ravioli, eri sempre lì a provare a prenderne di crudi. Mentre provavo a raccontarti la mia Genova, tu già pensavi di avere idee migliori. E io ti dicevo: «Belin, hai il pedigree di tuo nonno». E tu ridevi, che tuo nonno non l’hai mai conosciuto. E solo quello che non si conosce diventa davvero interessante.
A dire il vero il nostro tempo non ha avuto grandi misteri: è passato condito da quotidianità, dilaniato da vicende di ogni giorno, risoluzione di tanti e piccoli, talvolta grandi, problemi, senza che ci fosse veramente mai la possibilità di fermarsi un attimo e pensare a cosa affidarsi. La prima parola che mi viene in mente pensando alla Genova che tu non hai conosciuto è «acciaio». Quando Genova è diventata capitale dell’acciaio, io ero nel pieno della mia gioventù: mi sentivo forte, non ero certo intimorita dalla storia, anzi, ero rinvigorita da quello che avevamo scampato, una guerra, belin, e speravo che la vita mi potesse regalare un avanzo di esistenza di cui andare fiera. Mi viene in mente l’acciaio perché io, sarta provetta, mi ritrovai catapultata a pressarlo in fabbrica. Mi ritrovai a distribuire volantini alle 5 del mattino, a interessarmi anche di quello che succedeva intorno, a leggere anche, a scoprire le scrittrici donne! Poi come in fabbrica c’ero entrata, così ne sono uscita, risvegliandomi tra gli scaffali di una latteria. Meno fatica e più noia, diciamo.
Nel frattempo da Certosa, dove sono nata, periferia ovest di Genova a pochi passi da Bolzaneto, mi ero spostata a Cornigliano per finire poi a Rivarolo, di nuovo vicino a Bolzaneto. Ho avuto un marito più vecchio di vent’anni, poi sono arrivati due figli, poi sono rimasta vedova, poi da sola, poi ho conosciuto Piero e ho seppellito anche lui. A Cornigliano, senza saperlo, lavorando in fabbrica, contribuendo alla Genova industriale, ho visto sfiorire il sogno di un luogo che sperava di diventare non dico Capri, ma almeno Rimini. Cornigliano poteva essere un bel posto di mare: è finito con le acciaierie che l’hanno colorato di grigio. E per chi è venuto dopo e aveva sprescia, quella fretta di fare, di inandiare, come tuo zio F., non era certo un bel posto dove immaginarsi il futuro. Lo dico perché ogni volta che si ricorda, si sottolinea sempre che i propri tempi sono migliori, quando non i migliori. No, non è così. Per dire che il castello Raggio, questo Miramare genovese nella Cornigliano marittima e turistica io non l’ho mai visto. Quella zona fu spianata e ne venne fuori cosa? Il mio destino e quello di parte di questa famiglia: Saic, Società anonima acciaierie Cornigliano, poi Ilva, poi Italsider, o forse il contrario, ma che importa. Tutto questo per dire che, alla fine, posso affermare che la nostra è stata una famiglia piccolo borghese, come si diceva un tempo. Nel cuore della normalità. E alla fine forse, in qualche modo, non dico mica in tutto e per tutto, proprio questo status di moderato benessere è quanto ti ha permesso di studiare dai preti. Vedi? Comincio a mitizzare, a rendere indelebile un’epoca. Diciamocelo, noi abbiamo fatto molte cose giuste e poi quanti anni fa? In ogni caso, è bene ricordare da dove arrivi: contadini, operai, operai cantieristici, operai dell’acciaio, bottegai, piccolo borghesi.
Ho conosciuto Piero nel 1960. Era il gennaio del 1960. L’ho incontrato in via Balbi. Via Balbi, via Garibaldi, quanto marmo, quanto lusso! Le vie più belle di Genova. Per i visitatori dell’epoca Genova era la città del marmo, era dappertutto: si diceva che lo usassero perfino per i pavimenti dei bagni pubblici. Il marmo rappresenta bene la parte nobile di questa città, ma forse ne sanno di più ad Albaro, sulle «alte». Noi, noi comuni mortali, all’epoca facevamo la nostra vita da cani – e quello lo sapevo bene per prima io. Altro che boom, io mi ricordo gli anni Cinquanta come anni difficili. Esattamente come dopo, a dire il vero. All’epoca lavoravo a Cornigliano. Brasatura elettrica, ho ancora gli incubi: lavoravamo talmente tanto che a volte facevamo dieci ore di fila. E poi uscivamo, e chi abitava vicino alla fabbrica l’acciaieria se la ritrovava in casa: dalle finestre entrava di tutto, nell’aria c’era questa fuliggine nera, la puzza era insopportabile, quasi come l’impianto di Busalla.
Ci ritrovavamo la polvere sotto le unghie, mentre stendevamo di fronte al mare, grigio pece, nero morte. Le mollette ammuffivano, i vestiti crepavano di puzza che in confronto entrare in un bar era andare alle Hawaii. E nessuno ha mica mai detto niente, perché i lavoratori dovranno pure mangiare, bere, divertirsi, comprare. Di sera avevo talmente male agli occhi, da quanto mi bruciavano, che ci mettevo sopra delle patate fredde. Le lasciavo in frigo apposta la sera prima, chissà se è mai stato giusto. A me però il male agli occhi passava. E guardavo le mie mani, le mie povere mani, che, quando ho preso il negozio, ho finalmente ricominciato a curarmi, nonostante i segni dell’ago ancora sulle dita, perché il ditale lo mettevo solo ogni tanto, mentre sul divano ascoltavo la radio e ripensavo alle presse, al rumore, alle chiacchiere da giovani donne sull’autobus. E badavo ai miei due figli.
Sono entrata all’Italsider nel 1956 per merito di don Gino. Era di Voltaggio come me – venivamo dalle colline, dalla campagna – e aveva capito che per un’orfana già vedova e con due figli non c’era altra soluzione che un piccolo aiuto, smuovendo un po’ di amicizie, sfruttando qualche buon gancio, cosa vuoi farci. Don Gino aveva contatti importanti nella Curia e così fui assunta nel posto dove venivano presi per lo più cattolici, l’Italsider. Neanche vent’anni dopo capirono il grave errore di assumere tutti quei figli di un prete. Funzionava così, non me ne sono pentita, avevo bisogno di lavorare. E poi io don Gino lo conoscevo, ma chi frequentavo era don Prospero. Pregavo e bestemmiavo, l’ho fatto fino alla fine dei miei giorni. Nelle preghiere e nelle bestemmie l’obiettivo era quasi sempre lo stesso: ero sempre preoccupata per uno dei miei figli, tuo zio F., quel pelandrone. A volte penso che quasi tutte le mie preoccupazioni siano state per lui perché la mia vita, che in fondo è stata normale, ha sempre visto F. come una sorta di contraddizione. La verità è che avevo paura per lui. Mi chiedevo sempre in che guaio si fosse cacciato. Mi chiedevo continuamente dove avessi sbagliato con lui.
Nel 1983 ho avuto la fortuna di trovare un negozietto – una latteria – praticamente regalata. Ma negli anni Cinquanta ancora ci girava il belino e mica poco. La fortuna dov’era? Era nell’acciaiera? Avevo Piero come compagno, arrivato quasi per caso, quando avevo cominciato a prendere le misure alla solitudine. Poteva essere nell’acciaieria la mia vita, quando scoprii che Piero, di lì a poco, avrei dovuto seppellirlo? C’era Odoacre – all’epoca c’erano questi nomi genovesi: Rodolfo, Paride, Arnaldo – che, quando venne fuori che il Msi doveva fare il congresso proprio a Genova, se n’era uscito con una delle sue frasi a effetto: «ce lo mettono nel culo e vogliono che siamo felici». Eravamo disinibiti ma ancora sgreussi, grezzi. Per quello, però, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. La storia la sai, la sanno anche i sassi. Nel 1960, a un certo punto, tutti avevano cominciato a dire che quelli dell’Msi volevano fare il loro congresso, non ricordo neanche quale, a Genova, al teatro Margherita. Un affronto, «belin, ma siamo matti», dicevamo tutti. C’era un po’ di agitazione e sinceramente io mi ricordo una gran voglia di menare le mani, specie dei più giovani. È che ’sta cosa finiva per infuocare un tizzone già bello bollente. In più ho questo ricordo: quando ci ritrovavamo nella sede del sindacato, tutti parlavano di questi studenti giapponesi che protestavano contro l’America, tutti parlavano di questi giapponesi che facevano il «Serpentone», perché la televisione non faceva che trasmettere le immagini dal Giappone. Mi ricordo questi ragazzi e ragazze chiari, perché il bianco e nero della televisione dava una patina di luminosità a quelle immagini. E il suono che perveniva era attutito. Va detto che in quegli anni c’erano scioperi in continuazione, perché tutta quella forza che era arrivata dalla Liberazione sembrava essere finita nella delusione. C’era questo clima di disimpegno nei confronti della città, non so come altro dirlo. I giornali genovesi di allora parlavano di «ridimensionamento» di Genova e tutto sommato accusavano il governo centrale, Roma, di aver fatto favori a tutti dopo la guerra, tranne che a Genova. Non so quale finanziamento importante doveva essere fatto al porto e invece niente. Questo cominciò a pesare, piano piano. La sensazione era che Genova era stata umiliata. «Qualsiasi cosa invece che Genova», si lamentavano sempre i genovesi. «Genova sta sul belino a Roma», pensavano tutti. Abbiamo questa percezione da sempre, che poi è il mugugno no? La sensazione di aver subìto un continuo tartassamento, un adattamento a un mondo che all’epoca ci sembrava impossibile potesse cascarci addosso. E invece nel 1960 noi – ma soprattutto quelli più giovani – vedevano le proprie dita sfiorare tutto. Ma in mano non rimaneva mai niente. E Genova cambiava, c’erano delle strade che tu non hai mai visto, palazzi nuovi, e poi c’erano le industrie, l’Iri, c’era la Chiesa, c’era la Democrazia Cristiana, poi sono arrivati i socialisti. E tutti hanno costruito dappertutto. Insomma, la faccio breve: questa storia del congresso del Movimento sociale a Genova parve subito una provocazione. Io il fascismo me lo ricordavo e così tanti come me. E i fascisti tornavano a Genova. L’unica città che si era liberata da sola. L’unica città che aveva cacciato i tedeschi sminando il porto e salvando un’intera popolazione dall’esplosione. La prima città a imporre ai tedeschi la resa, senza condizioni. Ci rendiamo conto? Io ancora adesso, mentre ci penso e ti affido queste parole, ho i brividi.
Pensavo: chi saprà capire quale incredibile affronto è questo? Risultato: migliaia di persone in piazza, scontri furibondi con la polizia e congresso spostato. Genova aveva vinto, ma quella battaglia aveva lasciato molte ferite aperte. Intanto nei mesi successivi ci furono altre proteste contro il governo, che era di Tambroni, e alla fine, dai e dai, il governo è caduto.
Quei giorni del 1960 hanno lasciato anche un ricordo nitido, pulito: tutti ricordano quei fatti e tutti ne sono, in fondo, orgogliosi. Tanto che ogni tanto si riparla dello «spirito del 1960» o qualcuno invoca «i ragazzi con le magliette a strisce», perché all’epoca andavano di moda e tanti giovani le avevano. Che poi, belin, ’sta storia delle magliette a strisce è talmente semplice: è che a Genova i grandi magazzini avevano cominciato a venderle a prezzi bassissimi, mi pare a 300 lire. E noi eravamo misci, senza una lira, e praticamente ce le compravamo tutti. Quindi il 30 giugno del 1960, quando ci furono gli scontri, molti dei giovani in piazza indossavano proprio quella maglietta a strisce. E insieme ai giovani c’erano anche tante donne, me compresa.
Ripensando a quei giorni, secondo me – alla fin fine – ciò che convinse tutti che l’idea del congresso fascista a Genova era una belinata fu la notizia secondo la quale il 1° luglio a Genova ci sarebbe stato Basile. Fu quello che fece scattare la molla: anche Anpi e Pci a quel punto si decisero che bisognava essere più forti e fermi nella condanna. Questo non significava che quelli, c’era perfino Piero, fossero d’accordo con chi poi avrebbe fatto tutto quel casino. Ma significava che il messaggio era chiaro: può succedere di tutto. Carlo Emanuele Basile per noi genovesi voleva dire la Casa dello Studente, l’inferno dove erano state torturate così tante persone. Non so, è come per te oggi dire Bolzaneto. Erano quelle cose che tutti sapevano e tutti, sotto sotto, finivano per ringraziare di non esserci mai finiti. Perché la sensazione è che poteva capitare a chiunque di essere torturato alla Casa dello Studente. Non serviva essere politicizzato, bastava essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. Poteva capitare a chiunque di essere preso e portato lì. Da quei fatti la Casa dello Studente divenne, anche dopo, sinonimo di fascismo, tortura, sofferenza. Un buco nero, quasi, qualcosa da ricordare con fastidio e lacrime. Io me la ricordo bene la Casa dello Studente, ricordo bene di avertici portato qualche volta e averti raccontato cosa è successo lì dentro. Sono convinta che tu, che all’epoca eri piccolo, abbia ascoltato i miei discorsi di allora quasi con fastidio. Quando si è giovani non si è interessati al passato. E so che ora stai pensando, «ma guarda che storia incredibile e io non me la sono mai fatta raccontare per bene». Ci sono dei rimedi alle trasmissioni fallite, anche quelle umane, come vedi. Ti raccontavo sempre l’esempio di Camilla Salvago Raggi, una scrittrice che era pure parente di una nostra amica di Voltaggio. Aveva scritto un racconto nel quale descriveva quanto fosse poco interessata, da piccola, ai racconti straordinari del nonno, diplomatico a Pechino durante la rivolta dei Boxer. Solo anni dopo recupererà quei racconti e ne farà addirittura un libro. È sempre così, cercavo di dirti allora: le cose vicine appaiono più scontate, ma non per questo sono meno importanti.
All’epoca tutti noi conoscevamo bene cosa significasse anche solo nominarla la Casa dello Studente. Ognuno di noi aveva avuto un parente o un amico intrappolato e alle prese con torture, urla, menomazioni, danni umani irreparabili. Quelle torture sono rimaste torture nella storia, come altre. Non serve una sentenza per la memoria popolare.
Alla Casa dello Studente, proprio lì in corso Gastaldi, sono successe cose atroci. Uno dei massimi responsabili di quanto è accaduto nella Casa dello Studente fu proprio il prefetto fascista di allora, Basile. Chi era Basile? Ricordo un esempio che all’epoca veniva riportato in ogni discussione. Un manifesto affisso in tutta Genova il 1° marzo 1944 recitava: «Uomo avvisato mezzo salvato. Sia che incrociate le braccia per poche ore, sia che disertiate il lavoro, in tutti e due i casi un certo numero di voi sarà sorteggiato e inviato in Germania, non dove il lavoratore è trattato alla medesima stregua del lavoratore di quella Nazione a noi alleata, ma nei campi di concentramento nell’estremo Nord a meditare sul danno arrecato». L’autore di questo manifesto è Carlo Emanuele Basile, già prefetto di Genova.
Noi scoprimmo questa cosa del congresso e di Basile a maggio. I giornali cominciarono a parlarne ai primi di giugno. C’erano dei compagni che arrivavano a riunioni o incontri con questi giornali fascisti: era l’unico modo per avere informazioni di prima mano. Quasi non ci credevamo, come era possibile!?
Tornando a Basile: nel maggio del 1945 cominciò il suo processo per quanto aveva combinato durante il fascismo a Genova. Sono andata alla Berio – alla biblioteca pubblica di Genova – a guardarmi i giornali dell’epoca. Non so se l’ho fatto per te o per me. Si legge che «L’alta corte di giustizia è riunita per processare Carlo Emanuele Basile, già prefetto di Genova. In doppiopetto grigio, camicia bianca abbottonata al colletto, senza cravatta, rasato, rilassato in piedi nel gabbione, fa un mezzo sorriso al fotografo. Non sembra preoccupato, eppure rischia la pena di morte. È accusato della deportazione di migliaia di lavoratori genovesi dell’Ansaldo in Germania, nonché della morte di undici detenuti fucilati dopo una serie di attentati dei Gap in Liguria. È accusato anche della fucilazione di ottantuno detenuti politici da parte di Carlo Castagna, operaio. Lo si accusa anche dei morti fucilati al Turchino, San Martino Forte Ratti. Il pubblico ministero chiede la fucilazione alla schiena». Basile è stato amnistiato e poi assolto nel 1951.
Ti sembra strano questo racconto? Di me hai il ricordo dell’anziana nonna che ti cuciva le magliette del Genoa. A volte urlavi «Ecco, guarda!» quando alla tv passavano le immagini delle partite del Genoa. Volevi che vedessi che tipo di maglietta avevano i calciatori per farla uguale. Ma io non facevo mai in tempo a cambiarmi gli occhiali, che già trasmettevano altre immagini. E allora me le disegnavi su dei foglietti e io te le facevo uguali. Poi un giorno affrontammo il problema dello sponsor: dovevamo scriverlo o no? Decidemmo di no. Ricordo che mi avevi detto: «Conta la maglia», e io mi chiedevo dove avevi preso quell’espressione, forse da tuo nonno materno che ricordo come grande appassionato di stadio. Di certo non poteva avertela suggerita tuo padre, sempre poco interessato al calcio. Quando stavi da me andavamo a comprare insieme le figurine, volevi solo quelle dei calciatori. Poi uscivi, stavi lì sulla strada tutto il giorno a giocare. Alle 4 del pomeriggio ti preparavo dei panini burro e zucchero, o sale e olio. Se tornavi prima dell’ora di cena, c’era sempre qualcosa che non andava: una zuffa, una lite, un problema. Un giorno eri arrivato tutto sporco di sangue: per prendere un pallone finito in uno scolo vicino a casa, avevi provato a scavalcare il filo spinato e c’eri rimasto appeso. Per la prima volta eri stato in pronto soccorso: ti avevano dato i punti ed eri rimasto da me tutta la notte. C’era la Coppa del Mondo, era estate, eri così felice. Altre volte venivano a trovarmi vecchie amiche, e in genovese cominciavamo a parlare di ricordi. Io provavo sempre a chiedere informazioni su tuo zio, su F. Io vivevo quasi sola in casa e nella mia via, alcune mie amiche avevano una vita sociale più movimentata e speravo sempre potessero raccontarmi qualcosa. Sapevo che F. era stato via, una sorta di esiliato da Genova. E io ho sempre pensato che l’esilio sia pericoloso, perché mischia rancore e tabù, risentimenti e idealizzazioni. E così con le mie amiche, mentre tu facevi i compiti o smaniavi per uscire a giocare, andavamo sul sicuro: sui ricordi.
Anche con Piero giocavamo a ricordare. Lui mi raccontava la sua Resistenza e io quei racconti li ripetevo tra me e me di sera, mentre i miei due figli dormivano. Di Piero – di cui ti ho sempre parlato poco – ho il ricordo di un uomo indaffaratissimo, che improvvisamente mi parve dimagrire troppo in fretta. Fu incredibile conoscere un uomo proprio nel momento del suo declino fisico. Hai idea di cosa significhi? Spero per te di no. Significa med...
Indice dei contenuti
- Ritorno
- Genova Bolzaneto
- Voce di Genova #1 La madre di mio padre
- Genova Ovest
- Voce di Genova #2F., il fratello di mio padre
- Pegli
- Il centro
- Voce di Genova #3 Il Ghedda
- Il Porto
- Genova Est
- Testa di gatto
- Voce di Genova #4 Mio padre
- Nota dell’autore