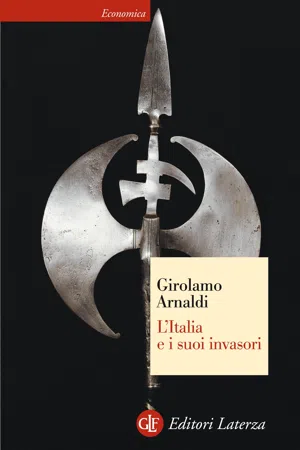
- 226 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
L'Italia e i suoi invasori
Informazioni su questo libro
Che felice sorpresa! Un grande storico, noto nel mondo degli studiosi come uno dei maggiori eruditi di storia medievale, ha pubblicato un libro di divulgazione, eccezionale per qualità e interesse. Un libro non solo leggibile ma attraente, che al tempo stesso informa e induce a riflettere. Jacques Le GoffDa Odoacre agli Alleati, la storia di un paese da sempre terra di conquista e di incontro fra culture, ma anche dotato di un'identità profonda e sostanziale, acquisita e maturata nel corso dei secoli.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a L'Italia e i suoi invasori di Girolamo Arnaldi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia dell'Europa medievale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
StoriaCategoria
Storia dell'Europa medievaleIV. Nell’impero di Carlomagno e al riparo delle mura
Chiamato in aiuto da papa Adriano I (772-795), che nell’inverno 772-773 solo con la minaccia di una scomunica aveva sventato il proposito di re Desiderio di marciare su Roma, Carlo, re dei franchi (768-814), dopo avere invano tentato di convincere per via diplomatica Desiderio a desistere dalle sue mire sul Patrimonio di san Pietro, mosse verso l’Italia con il suo esercito nell’estate del 773. Attraversate le Alpi per il colle del Moncenisio, infranse la resistenza dei longobardi nel fondovalle, alle Chiuse di S. Michele, e andò a porre l’assedio a Pavia, capitale del regno dall’inizio del secolo, che capitolò nel giugno 774. Invece di annettere al regno dei franchi il regno dei vinti, com’era stato costume fino allora, si intitolò re dei franchi e dei longobardi. Fu realizzata così la prima unione del medioevo di due corone nella stessa persona1.
Per la sua tradizione guerriera il regno longobardo era il solo che, in teoria, avrebbe potuto tenere testa a quello dei franchi. La sua effettiva liquidazione, nonostante la ulteriore parvenza di vita che Carlo volle assicurargli dandogli nel 781 un re proprio, nella persona del suo secondogenito Pipino, ha segnato una svolta nella storia d’Italia, il cui corso, se il regno pavese non si fosse disfatto come neve al sole, sarebbe stato certamente diverso. È quanto lamenta Niccolò Machiavelli, che ne addossa l’intera responsabilità al papato. Ma sembra non tenere nel debito conto, proprio lui che certo non trascurava i rapporti di forza, che anche i longobardi ebbero una parte non indifferente di responsabilità nell’accaduto, venendo meno alla fama militare che ancora li circondava nel momento della prova decisiva che il destino aveva loro riservato, come se lo sforzo di incivilimento che avevano compiuto avesse intaccato le loro originarie virtù di popolo guerriero.
Conseguito il risultato che si era ripromesso, Carlo con i suoi riattraversò le Alpi per fare ritorno in patria. I franchi, dunque, non possono essere ritenuti degli invasori nel senso in cui lo erano stati, due secoli prima, i longobardi.
Fra il 1820 e il 1822, quando in Italia si sarebbe cominciato a discutere seriamente, anche se ancora sottovoce, di indipendenza, di unità e di libertà, Alessandro Manzoni scrisse una tragedia, l’Adelchi, che ha come protagonista il figlio dello spodestato re dei longobardi, un antieroe rinunciatario che rifiuta la logica del potere.
Al cattolico Manzoni premeva di presentare il papa, che aveva sollecitato l’intervento di Carlomagno, come il difensore dei diritti civili e nazionali degli italiani, tenuti in schiavitù dai longobardi fino alla fine. Non voleva però con questo accreditare l’idea che la liberazione, per gli italiani, potesse nuovamente venire dall’intervento di altri stranieri e, perciò, si diede cura di fare presente che anche allora, proprio perché a risolvere la questione longobarda erano intervenuti dal di fuori i franchi, tale soluzione si era rivelata tutt’altro che indolore. Sarebbe stato infatti da ingenui pensare che costoro, come compenso per la benemerita azione che erano venuti a compiere in Italia su richiesta di papa Adriano I, si fossero accontentati di «rivolger le sorti», cioè di mutare il destino avverso, e di «por fine al dolor» di un popolo straniero, com’era per essi l’italiano. Ben diverso era il «premio [da essi] sperato», e non esitarono ad aggiudicarselo:
Udite! Quei forti che tengono il campo,
che ai vostri tiranni precludon lo scampo,
son giunti da lunge, per aspri sentier [...].
Han carca la fronte de’ pesti cimieri,
han poste le selle sui bruni corsieri,
volaron sul ponte che cupo sonò [...].
E il premio sperato, promesso a quei forti,
sarebbe, o delusi, rivolger le sorti,
d’un volgo straniero por fine al dolor? [...].
Il forte si mesce col vinto nemico,
col novo signore rimane l’antico;
l’un popolo e l’altro sul collo vi sta.
Dividono i servi, dividon gli armenti;
si posano insieme sui campi cruenti
d’un volgo disperso che nome non ha2.
Anche i franchi, dunque, dei veri e propri invasori, contrariamente a ciò che abbiamo detto? Lo furono certo nel senso che la loro spedizione provocò sul momento le devastazioni e le sofferenze che si accompagnano di norma alle invasioni e, più tardi, la rivolta, nel 776, dei longobardi del nord-est venne repressa da Carlo in persona, non senza avere prima emanato un provvedimento per risarcire i danneggiati delle perdite subite. Ma c’è anche dell’altro. Se non al seguito di Carlomagno, certamente negli anni successivi alla sua spedizione del 773, furono molti gli aristocratici, i chierici, i monaci franchi, bavari, alemanni, burgundi, che vennero a cercare, e trovarono, la loro fortuna nel regno carolingio d’Italia, ottenendo contee, vescovati, abbazie con il loro appannaggio di cospicue rendite fondiarie ed entrando così in concorrenza con i propri omologhi, di ascendenza longobarda, vuoi romana, per dare poi vita al ceto dirigente plurietnico che avrebbe presieduto nei secoli a venire alle sorti del paese. I nuovi venuti non persero comunque mai di vista i membri, o rami, delle loro famiglie, che, non essendosi mossi dai rispettivi paesi d’origine, finirono col rappresentare altrettanti punti di riferimento e di appoggio, in patria, per i congiunti emigrati. È però improbabile che, quando, nell’878, il vescovo di Brescia Antonio, franco-orientale d’origine, in una lettera a Salomone II, vescovo di Costanza, scriveva: «noi, abitanti d’Italia, o piuttosto inquilini»3, interpretasse davvero il sentimento di tutti quelli come lui.
Per di più i nuovi venuti facilitarono se non, addirittura, promossero la diffusione nelle terre del regno cisalpino di un tipo di regime agrario, la curtis o signoria rurale, che era in auge oltralpe. Esso prevedeva la divisione in due aree, non necessariamente eguali, del possesso fondiario. L’una (pars dominica) a conduzione diretta, ch’era coltivata, in parte, da servi alloggiati e nutriti dal signore e, in parte, con le giornate lavorative (le corvées), dovute, in un numero limitato oppure a discrezione del signore medesimo, dai servi (perché sempre servi erano!), accasati sui lotti di terreno (mansi), che venivano loro concessi a tempo indeterminato, fornivano loro di che sostentarsi e formavano l’altra parte del possesso stesso, chiamata massaricium. Alla maggiore costrizione ma anche sicurezza di vita dei servi non casati corrispondeva l’aleatorietà dell’esistenza dei servi casati, che erano esposti all’incertezza dei raccolti, ma godevano in compenso di una certa autonomia.
Si tratta di una di quelle forme di razionalizzazione dei processi produttivi, nelle quali i vantaggi conseguiti dal padrone sul piano economico hanno spesso una contropartita nel peggioramento della condizione dei sottoposti. Anche se il fatto che, per designare la loro condizione, si sia continuato a usare il termine servus, che anticamente significava «schiavo», non consente di equiparare automaticamente il servus medievale e quello antico. Per designare il corrispondente medievale di quest’ultimo, si fece infatti ricorso già da allora al neologismo sclavus (da «slavo», poiché tale era l’origine etnica di molti dei nuovi schiavi), mentre la condizione del servus medievale viene tuttora spesso definita con le ambigue nozioni di semilibertà e di semischiavitù, che riflettono la difficoltà estrema di darne una definizione precisa.
Il tipo di regime agrario di cui abbiamo dato sommariamente conto, è uno dei «modi di produzione» precapitalistici contemplati dall’analisi marxista, che lo qualifica come «modo di produzione feudale». Ma, se è vero che la signoria rurale è il regime agrario tipico dell’età feudale, è anche vero che se ne trovano tracce significative addirittura nella tarda antichità e, soprattutto, che esso sopravvisse largamente alla fine dell’età feudale medesima. Tanto che l’11 agosto 1789 l’Assemblea Nazionale, confermando con un decreto definitivo una deliberazione adottata la notte del 4, «distrugge interamente il regime feudale», distinguendo con cura fra i diritti sulle persone, che vengono soppressi, e quelli patrimoniali, che vengono dichiarati riscattabili. Così facendo, l’Assemblea non aboliva il «regime feudale», che, come tale, era finito da un pezzo, bensì la «signoria rurale». Lo dimostra chiaramente la stessa distinzione, introdotta nel decreto di abolizione, fra i diritti sulle persone (sui servi) e i diritti patrimoniali (le rendite fondiarie). Contrariamente, dunque, a ciò che ritenevano gli uomini dell’89 e, poi, Marx ed Engels, la signoria rurale è cosa affatto diversa dalle istituzioni feudali, anche se, per così dire, coabitò a lungo con esse4. Se abbiamo aperto questa parentesi è solo perché nei bagagli di Carlomagno, diretto in Italia, viaggiava, oltre al modello della signoria rurale, anche quello originario delle istituzioni feudali, ignote, salvo qualche spunto che sembrava andare nella stessa direzione, ai longobardi.
A scanso di equivoci, va però subito detto che l’estensione al regno d’Italia carolingio dell’uso per cui un senior (un signore, se non il sovrano medesimo) concedeva a un suo fedele una terra in beneficio, cioè senza una contropartita in denaro, ma con l’impegno a prestargli servizi altamente qualificati, come erano, per lo più, il «consiglio» e, soprattutto, il servizio militare a cavallo, non segna in nessun modo l’inizio dell’età feudale, che si ebbe solo – e in Italia con tratti atipici rispetto al resto dell’Europa ex carolingia – almeno due secoli dopo. Ciò sarebbe avvenuto quando, disgregatosi con la fine dell’impero carolingio l’ordinamento pubblico, che, pur con tutti i rivolgimenti e stravolgimenti intervenuti nel frattempo, era sopravvissuto al tramonto del mondo antico, la diffusione delle istituzioni feudali fu non il solo, ma il più caratteristico e il più caratterizzante dei ritrovati che consentirono la riaggregazione della società su basi interamente nuove.
Con i maestri di palazzo carolingi, mentre ancora regnava la dinastia merovingia, e poi sotto i re della nuova dinastia, si assistette nel regno franco al sempre più costante accoppiamento di due pratiche che, nell’età precedente, si erano affermate l...
Indice dei contenuti
- Premessa
- I. Dal «sacco di Roma» a Odoacre, «re delle genti»
- II. Ostrogoti, romani d’Italia e romani d’Oriente
- III. I longobardi fra guerra e pace e le origini del dominio temporale dei papi e di Venezia
- IV. Nell’impero di Carlomagno e al riparo delle mura
- V. Tedeschi a Legnano, normanni nel Mezzogiorno e in Sicilia
- VI. La meteora Federico II e gli amari «ceci» dei francesi in Sicilia
- VII. Il gesso di Carlo VIII e la lancia del Fieramosca
- VIII. Milano e Napoli nell’impero castigliano
- IX. Gli austriaci e il regno Lombardo-Veneto
- X. Una pseudoconquista e una vera liberazione