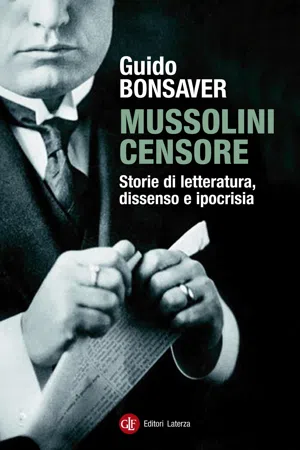1. L’opposizione da sopprimere
Una volta al governo, Mussolini si preoccupò di creare le condizioni per una progressiva fascistizzazione della cultura italiana. Nel campo editoriale non erano tanto i libri a dargli pensiero quanto la stampa periodica. Non a caso, l’Ufficio stampa del ministero dell’Interno fu rapidamente posto sotto la direzione di un suo fedelissimo, Cesare Rossi e, per assicurargli completa libertà di manovra, nell’agosto 1923, venne spostato sotto il diretto controllo del Duce e due anni dopo ribattezzato Ufficio stampa del Capo del governo. Come sappiamo, Mussolini si servì di Cesare Rossi per agire entro e oltre la legalità. Il rapimento e l’uccisione del deputato socialista Giacomo Matteotti fu l’episodio più violento e più avventato di questa deriva criminale, tanto che il governo stesso vacillò e Rossi si dette alla macchia portando con sé faldoni di documenti con i quali ricattare Mussolini se questi avesse deciso di fare di lui un capro espiatorio. Tuttavia, passata la crisi dell’estate 1924, come sappiamo, il governo non cadde; anzi, Mussolini riuscì a volgere la crisi a suo favore spingendo l’Italia verso la dittatura. Da qui l’introduzione delle nefaste «leggi fascistissime» con le quali il governo impose il bavaglio all’opposizione politica nonché ai mezzi d’informazione. Non fu però una rivoluzione come lo squadrismo avrebbe desiderato. O, meglio, non fu solo attraverso la violenza squadristica che Mussolini raggiunse i propri obiettivi. Onde evitare una presunta degenerazione del dibattito politico, il governo promulgò una serie di leggi che fornivano poteri draconiani ai prefetti, dando loro la possibilità di arrestare cittadini e sospendere attività a monte del coinvolgimento della magistratura. La facilità con cui Vittorio Emanuele III firmò tali decreti e l’efficienza con cui i prefetti assolsero i propri compiti sono di per sé segno evidente dell’ampio consenso su cui il giovane presidente del Consiglio Benito Mussolini poteva già contare. Con il Testo unico di pubblica sicurezza, introdotto nel novembre 1926, lo svuotamento dei diritti democratici nell’Italia liberale fu pressoché completo.
In un telegramma circolare a tutti i prefetti del Regno d’Italia, spedito il 5 gennaio 1927 e diffuso pubblicamente attraverso la stampa, Mussolini mise in chiaro che cosa si aspettasse da loro. Fu una delle prime occasioni in cui utilizzò l’espressione «Prefetti fascisti», e in quel ruolo li invitò a farsi «tutela dell’ordine morale» e a «prendere tutte le iniziative che tornino di decoro al regime, o ne aumentino la forza e il prestigio, tanto nell’ordine sociale, così come in quello intellettuale». Più interessante ancora una lettera riservata di qualche mese più tardi. In questo caso Mussolini tenne a ribadire la sua intenzione di tenere sotto il proprio controllo ogni attività censoria. Ordinò infatti ai prefetti di «non assumere iniziativa alcuna di divieti o di sequestri giornalistici senza la mia personale preventiva autorizzazione che giungerà esclusivamente per mezzo del Capo Ufficio stampa del governo»1.
Un esempio della collaborazione tra Mussolini e le prefetture italiane ci viene da Torino. Come si diceva in apertura, Mussolini non riteneva i libri uno strumento particolarmente pericoloso. A capo di una tra le nazioni con il tasso più alto d’analfabetismo dell’Europa occidentale, egli sapeva benissimo che l’editoria si rivolgeva a un pubblico elitario, ben distante dalle masse che lui mirava a guidare e istruire. Detto questo, vi erano casi eccezionali cui era d’obbligo occuparsi. Uno di questi riguardò una delle figure più potenti e carismatiche dell’opposizione al fascismo: un giovane intellettuale torinese di nome Piero Gobetti.
Nel 1922, a soli ventun anni, Gobetti poteva già considerarsi una voce ascoltata e temuta dell’antifascismo. Alla rivista «La Rivoluzione Liberale», fondata nel gennaio di quell’anno, Gobetti aveva fatto seguire la creazione di una casa editrice, la Piero Gobetti editore, con la quale contava di chiamare a raccolta le voci più lucide e più intransigenti dell’antifascismo. Maestri delle generazioni precedenti, come Luigi Einaudi, Giuseppe Prezzolini e Gaetano Salvemini, così come giovani intellettuali del calibro di Natalino Sapegno, Giovanni Ansaldo, Santino Caramella, Manlio Brosio e Augusto Monti, risposero alla chiamata. Si consideri inoltre la collaborazione di Gobetti nella veste di critico teatrale all’«Ordine Nuovo» di Antonio Gramsci, segno della sua attenzione verso il movimento comunista con il quale condivideva l’opinione che ormai solo un’insurrezione popolare avrebbe potuto frenare lo scivolamento dell’Italia verso la dittatura fascista.
I toni violenti della critica di Gobetti al fascismo e il sarcasmo tagliente con il quale si riferiva a Mussolini rinvigorirono dopo la Marcia su Roma. Nel suo tentativo di mettere a nudo le radici più violente e illiberali del movimento, Gobetti osò sfidare apertamente la violenza squadristica. Esortò i propri compagni a considerarsi una sorta di futura «compagnia della morte», li incitò a prepararsi all’inevitabile persecuzione, e ai fascisti richiese pubblicamente «le frustate perché qualcuno si svegli, chiediamo il boia perché si possa veder chiaro»2. Purtroppo non dovette attendere a lungo.
Già durante i primi mesi al potere, un telegramma al prefetto di Torino, inviato il 6 febbraio 1923, non lascia dubbi sulle intenzioni di Mussolini, neopresidente del Consiglio, di utilizzare ogni mezzo legale a sua disposizione:
Ordinole perquisire immediatamente redazione amministrazione giornale «RIVOLUZIONE LIBERALE» sequestrando schedari abbonati corrispondenza libri amministrativi. Contemporaneamente procederà arresto nominato Pietro Gobetti e redattori provvedendo a denunciarlo autorità giudiziaria per intelligenza coi comunisti sovversivi. Attendo risultato operazione telegraficamente. Massima energia e durezza.
La sera stessa il prefetto Enrico Palmieri rispondeva con un telegramma in cui confermava il fermo di Gobetti. A favore delle forze dell’ordine giocò il fatto che Gobetti fosse appena rientrato dalla luna di miele con la sua giovane compagna Ada. In quello stesso telegramma, il prefetto chiese a Mussolini che da Roma gli venissero trasmesse le prove delle menzionate attività illegali di Gobetti così da poter iniziare le procedure processuali. Tali prove non dovettero giungere, o così almeno è lecito ipotizzare vista la mancanza di documentazione e il fatto certo che il giorno dopo Gobetti fu rilasciato e gli fu permesso di tornare alle sue consuete attività.
Un mese dopo nasceva la Piero Gobetti editore. Già si è menzionato il calibro delle collaborazioni alla rivista; lo stesso si può dire dei volumi, recanti firme prestigiose come quelle, in politica, di Giovanni Amendola, Francesco Nitti e don Luigi Sturzo, mentre sul versante letterario basterà ricordare la pubblicazione di Ossi di seppia del giovane Eugenio Montale, opera che in poco tempo diverrà icona della resistenza alla retorica fascista; in campo artistico ricordiamo il saggio monografico di Gobetti stesso su Felice Casorati, pittore e amico dell’editore (a Casorati si deve il carismatico logo della casa editrice formato dal motto in greco antico «Cosa ho a che fare io con gli schiavi?»). Altrettanto utile sarà citare brevemente un dato quantitativo e simbolico della febbrile vitalità di Gobetti: in due anni e mezzo la sua casa editrice diede alle stampe quasi cento volumi.
Da Roma, Mussolini continuò a seguire con attenzione lo svilupparsi di questo vivace polo antifascista. Un secondo telegramma, inviato l’8 marzo 1923, ordinò un nuovo arresto di Gobetti. Ancora una volta Mussolini sfoggiò toni bellicosi ma con poca sostanza nelle accuse:
Giornale «Rivoluzione Liberale» è stato uno dei nemici più perfidi sebbene innocui attuale governo. Tutte le canaglie espulse vita politica italiana vi sono date convegno. Ultimo numero si auspicava avvento Trotsky. Trascorsi i cinque giorni dal fermo regolamentare Ella, qualora altro non risulti, può provvedere scarcerazione Gobetti. Farà copia lettere documenti che possono interessarmi punto vista politico3.
Non v’è dubbio che Mussolini temesse la capacità di Gobetti di catalizzare l’opposizione al fascismo nei circoli intellettuali italiani. Il tono del telegramma tradisce inoltre la sua intenzione di piegare gli strumenti dello Stato ai propri fini politici. Due settimane dopo, il prefetto Palmieri informò Mussolini che Gobetti era stato interrogato e che gli uffici della casa editrice erano stati perquisiti. La mancata detenzione era ancora una volta segno dell’assenza di appigli legali con i quali giustificarla. Il 28 marzo, il Duce tornò alla carica invitando a mantenere costante la pressione su Gobetti: «Non perda d’occhio elementi sedicente rivoluzione liberale renda loro vita difficile dal momento che insistono loro obliquo imbecille atteggiamento». Il prefetto torinese chiaramente non ardì chiedere il motivo per cui l’operato di Gobetti fosse da ritenersi «obliquo» e «imbecille» ma sappiamo che non agì sino al mese di maggio.
È utile a questo punto ricordare che se gli archivi ci permettono di ricostruire la corrispondenza tra Mussolini e le prefetture d’Italia, ben più arduo è farsi un quadro completo dei molti casi in cui il Duce sollevò la cornetta e comunicò direttamente con i propri interlocutori. Forse fu una telefonata a provocare l’ennesimo intervento della polizia con il quale si arrivò all’arresto di Gobetti il 29 maggio 1923. Nei giorni successivi due parlamentari dell’opposizione misero all’ordine del giorno un’interrogazione alla quale il viceministro degli Interni, Aldo Finzi, rispose dicendo che l’arresto era legato alla collaborazione di Gobetti con una rivista resa da poco illegale, l’«Ordine Nuovo» di Gramsci. Ancora una volta all’arresto non seguì una condanna e Gobetti poté tornare al suo lavoro.
Gli sforzi per difendere gli spazi sempre più ristretti dell’opposizione antifascista s’intensificarono nei giorni delle elezioni politiche dell’aprile 1924. La vittoria schiacciante del fascismo, ipotecata dalla cinica riforma elettorale dell’anno prima, non rese Mussolini magnanimo nei confronti dei suoi oppositori. Al contrario. Non più di una settimana dopo le elezioni, egli tornò a occuparsi di Gobetti con l’ennesimo telegramma istigatorio al prefetto di Torino: «Richiamo energicamente attenzione V.S. su linguaggio provocatorio giornale Rivoluzione Liberale». Anche in questa occasione, gli uffici della casa editrice Gobetti furono prontamente perquisiti e pile di documenti e corrispondenza sequestrate e inviate in copia a Mussolini. Due mesi dopo, questi ritornò alla carica con un telegramma il cui testo si addice più a un capobanda che a un primo ministro in colloquio con un proprio funzionario: ordinò di «vigilare per rendere nuovamente difficile vita questo insulso oppositore governo e fascismo». Quarantott’ore dopo, l’ultimo numero della «Rivoluzione Liberale» fu sequestrato ancora in bozze, gli uffici perquisiti, e questa volta il bottino di documenti e corrispondenze venne inviato direttamente a Roma, al capo del governo. Non a caso, nei giorni successivi Gobetti se ne lamentò nella sua corrispondenza con l’amico, e come lui veemente antifascista, Emilio Lussu, dicendo che il contenuto di una sua lettera sequestratagli durante la perquisizione ordinata dalla prefettura era finito nelle mani di Cesare Rossi, il quale l’aveva usato per attaccarlo sulla pagine del «Popolo d’Italia». Il passo della lettera a Lussu contiene una dettagliata descrizione dell’operazione di polizia che vale la pena citare ampiamente:
Lunedì mattina, 9 giugno, alle ore 9.30, un commissario di prefettura si presentava da me senza regolare mandato dell’autorità giudiziaria e procedeva con alcuni agenti a una perquisizione delle mie lettere e dei documenti esistenti nel mio ufficio, che è anche mia abitazione. Mancando un regolare mandato, non si può nemmeno determinare con esattezza ufficiale quale fosse l’oggetto della perquisizione. Ma le domande degli agenti insistettero, anzi si limitarono a questi punti: a) ragioni del mio recente viaggio in Sicilia; b) rapporti miei con uomini di organizzazioni democratiche e liberali; c) se e come la mia azione tendesse alla organizzazione delle forze liberali di opposizione; d) ragioni del mio viaggio in Francia. Infatti, mi furono sequestrate lettere di Nitti e di Amendola, appunti del mio viaggio in Sicilia e mi venne asportato il passaporto. E vennero pure prese lettere di amici di provincia non noti, soltanto per il fatto che discutevano le eventualità di un’organizzazione liberale antifascista.
Tutto questo prova a sufficienza che l’atto della prefettura di Torino era diretto contro di me per la mia azione di oppositore al governo e per tutta la giornata di lunedì tale motivazione infatti fu mantenuta. Il commissario mi dichiarava bonariamente: – È ormai da un anno che le facciamo più visite; dunque veniamo a vedere cosa sta facendo! – Come la cosa più naturale di questo mondo!4
Quando la crisi Matteotti accelerò il processo di soffocamento del diritto di opinione e di parola degli italiani, Gobetti fu ancora una volta tra i più preveggenti. Nel luglio 1924, nei giorni successivi alla decisione di Mussolini di utilizzare i due decreti (già firmati dal sovrano l’anno prima) che davano ai prefetti il potere di sospendere senza preavviso qualsiasi attività editoriale, Gobetti scrisse un articolo in cui suggeriva di passare da una tattica di aperta provocazione a una di resistenza più discreta, che proprio per questo era in grado di offrire maggiori probabilità di sopravvivenza5. Segno di questo cambiamento di strategia fu la creazione di un periodico letterario che avrebbe dovuto coesistere con «La Rivoluzione Liberale». Si tratta del «Baretti», il cui primo numero uscì nel novembre di quell’anno. Come ricorda uno dei redattori, Mario Fubini, una certa quantità di autocensura veniva dosata intenzionalmente. Fu una strategia frustrante ma vincente sul piano culturale, se si considera che «Il Baretti» non fu mai né censurato né sequestrato dalle autorità nonostante la sua chiara repulsione verso la retorica nazionalistica degli ambienti letterari vicini al fascismo.
Sul piano politico, tuttavia, la situazione continuò a degenerare. Il 5 settembre 1924 Gobetti fu bersaglio di quelle violenze tante volte minacciategli. Il pretesto fu un suo commento, apparso sulla «Rivo...