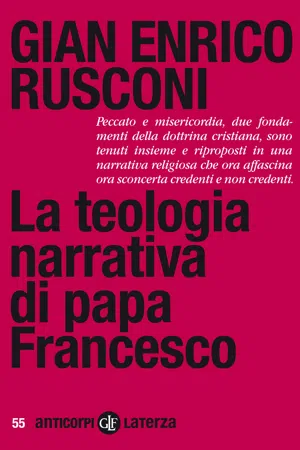1.
Una nuova ermeneutica religiosa
Papa Francesco è un uomo religioso dotato di una grande potenza mediatica, con la quale tenta di scuotere una chiesa e una società che reagisce più sorpresa che convinta. Ha dinanzi un’opinione pubblica che simpatizza con lui, ma che rimane religiosamente inerte e reticente ai suoi appelli di solidarietà sociale per gli emarginati, i migranti e tutti «gli scarti» della società. L’opinione pubblica ascolta compunta le sue appassionate esortazioni etico-politiche contro la povertà, lo sfruttamento, il sistema economico e finanziario, chiamato senz’altro capitalistico, ma sembra sensibile soprattutto agli argomenti attinenti i rapporti interpersonali, coniugali e in generale sessuali. I temi della «gioia dell’amore» (legati alla esortazione apostolica Amoris laetitia) hanno fatto presa sulle persone ma hanno creato un clima che irrita parecchi uomini di chiesa, che intravedono il pericolo di comportamenti «lassisti», troppo permissivi. Da qui a sospettare o a denunciare Bergoglio di posizioni dottrinali confuse, inadeguate se non erronee, il passo è breve. La questione è seria e tocca la sostanza stessa dell’ermeneutica religiosa bergogliana.
L’idea diffusa che papa Francesco sia «forte» nella comunicazione e «debole» nella dottrina – che produce effetti ambigui e un conflitto tra pastorale e teologia –, è un equivoco. La sua infatti non è semplicemente la promozione di innovazioni pastorali ma è una nuova ermeneutica religiosa, centrata sull’evocazione onnipresente e onnicomprensiva della misericordia di Dio. Insistente, anzi costantemente complementare, è il motivo «siamo tutti peccatori», ma sempre perdonati e perdonabili.
Peccato e misericordia, due fondamenti della dottrina cristiana, sono tenuti insieme e riproposti in una narrativa religiosa che ora affascina ora sconcerta credenti e non credenti. È un racconto attualizzato del dato rivelato, cristiano e biblico, presentato come una storia che continua, ed è privilegiato rispetto a una analisi teologica sistematica. «Teologia narrativa» significa reinvenzione semantica, espressività emotiva accompagnata da flessibilità concettuale, che porta a un linguaggio ricco di metafore, congruente con le parabole evangeliche. «Comprendere le metafore aiuta a rendere il pensiero agile, intuitivo, flessibile, acuto. Chi ha immaginazione non si irrigidisce, ha il senso dell’umorismo, gode sempre della dolcezza della misericordia e della libertà interiore» (così Francesco al Collegio della «Civiltà Cattolica» il 9 febbraio 2017). Non da ultimo, questo stile espressivo è in sintonia con la logica della comunicazione mediatica.
In questa suggestiva ottica metaforica non mancano affermazioni paradossali. «A me piace pensare che l’Onnipotente ha una cattiva memoria. Una volta che ti perdona, si dimentica. Perché è felice di perdonare. Per me questo basta. Come per la donna adultera del Vangelo ‘che ha molto amato’. ‘Perché Lui ha molto amato’. Tutto il cristianesimo è qui» (in una intervista all’«Avvenire» del 17 novembre 2016).
Da questi assunti discendono le decisioni pastorali innovatrici, quali l’apertura ai divorziati risposati per l’eventuale accesso all’eucaristia e l’opportunità per chi ha commesso (o facilitato) il grave peccato di aborto di essere assolto da un normale confessore. Nel caso della possibilità dell’eucaristia ai divorziati risposati, i critici del papa denunciano (neppure troppo sottovoce) il virtuale abbandono del principio della indissolubilità del matrimonio, mentre di fronte alla assoluzione dell’aborto qualcuno provocatoriamente afferma: «speriamo adesso che Bergoglio non banalizzi il peccato dell’aborto» – a dispetto delle esplicite dichiarazioni del pontefice.
Per contrasto non mancano gli entusiasti, laici compresi, che parlano senz’altro di «rivoluzione» di Francesco. Senza indagarne la natura e soprattutto senza interrogarsi sul dove essa porterà.
D’altro lato le malevolenze e le accuse di «eresia teologica» da parte degli avversari di Bergoglio non offrono convincenti controargomentazioni, salvo il mantenimento della lettera della dottrina tradizionale. È lecito chiedersi se la sotterranea, tenace ostilità di una parte della gerarchia, timorosa di affrontare processi incontrollabili di insicurezza pastorale e dottrinale, si rende conto dell’insostenibilità di molte norme e formule dottrinali tradizionali, che vengono sistematicamente trasgredite.
Così all’interno della chiesa il confronto e il conflitto – che papa Francesco ha evocato come cura all’ipocrisia e alla maldicenza – rimane in bilico tra corrida e comunione (Alberto Melloni). Ma sarebbe scorretto e banale ridurre questa dinamica a forme di opportunismo dottrinale o di carriera. La flessibilità semantica e dottrinale libera energie ma crea anche incertezze, produce schiette adesioni accanto a prudenti perplessità. La posta in gioco è enorme.
A una semplice lettura immediata dei discorsi di papa Bergoglio – quale lui stesso vorrebbe – la centralità data all’incondizionata «misericordia» di Dio e al «primato della grazia» lascia indeterminati o non-detti altri motivi religiosi tradizionalmente fondamentali come il castigo, la punizione e l’espiazione del peccato. Il 12 marzo 2017, parlando ai fedeli della parrocchia di Santa Maddalena di Canossa (come ci riferisce «L’Osservatore Romano» del 14 marzo) papa Francesco ha detto: «Gesù si è annientato per salvarci! E per usare una parola troppo forte, forse una delle parole più forti del Nuovo Testamento, una parola che usa Paolo: si è fatto peccato (cfr. 2 Cor 5, 21). Il peccato è la cosa più brutta; il peccato è l’offesa a Dio, lo schiaffo a Dio, è dire a Dio: ‘Tu non mi importi, io preferisco questo...’. E Gesù si è fatto peccato, si è annientato, si è abbassato fino a lì...».
Queste efficaci parole sottacciono tuttavia quanto è evidentemente sottinteso nella dottrina, cioè che l’autoannientamento di Gesù era la riparazione all’offesa (allo «schiaffo») originariamente fatta a Dio dai progenitori con il loro peccato di disobbedienza. Ma nelle parole di Francesco non c’è l’idea della riparazione come risposta all’«ira di Dio», concetto che è (stato) un motivo costante di tensione interna alla dottrina tradizionale. Rimane quindi indeterminata anche l’idea della necessaria espiazione commisurata ai peccati commessi attualmente. La teologia narrativa di Francesco si muove su un altro livello: «l’Onnipotente ha una cattiva memoria», quando perdona. Tutto questo non è un problema di dottrina astratta, perché riguarda da vicino, ad esempio, la decisione sull’accesso all’eucarestia per i divorziati risposati che vivono (secondo la dottrina) in una condizione attuale di peccato.
Bergoglio discorsivamente usa il termine «peccato» per indicare ogni atteggiamento e comportamento umano negativo, cattivo, quasi a sintetizzare in esso tutto ciò che è male nel mondo. Ma, a ben vedere, anche nel linguaggio corrente il termine «peccato» è usato in una versione secolarizzata, come sinonimo di un comportamento sbagliato, deplorevole, negativo. Il «peccato originale» diventa allora semplicemente il mito per spiegare l’inevitabilità dell’errare umano. Questa è la ragione per cui i non credenti non sono disturbati dal fatto che Bergoglio chiami «peccato» la malvagità del comportamento umano e sociale come tale. Così, quando parla di peccato, sembra farsi capire da tutti, credenti e non credenti. Quello però che non è (più) detto e resta dottrinalmente congelato è il dogma religioso del male inteso come effetto inevitabile del «peccato originale». In questo modo uno dei punti qualificanti della dottrina tradizionale rimane nel vago.
Tutto questo è significativo? Quali effetti avrà questa ermeneutica bergogliana, soprattutto davanti all’intensità con cui Francesco racconta la storia biblica della creazione e della «caduta» dei progenitori, dunque del peccato originale? Il papa dedica un’attenzione tutta speciale al rapporto di coppia tra Adamo ed Eva, arrivando a dire che il loro amore, «icona» dell’amore tra l’uomo e la donna, è «il capolavoro della creazione». Si tratta molto di più di un’iperbole per sottolineare la raccomandazione alla fedeltà coniugale come comando divino; è una modalità narrativa che dà alla vicenda «originaria» o «mitica» dell’Eden una dimensione intimamente ed emotivamente coinvolgente, ma che nello stesso tempo, impercettibilmente, sposta il fuoco della narrazione dalla fatale disobbedienza del comando divino e dalle sue inesorabili e inaudite conseguenze (compreso in prospettiva il sacrificio del Figlio) a un atteggiamento di premurosa preoccupazione di Dio di sistemare tutto, grazie alla sua incondizionata misericordia. Non c’è traccia dell’«ira di Dio» che è (stato) un motivo costante di tensione interna nella dottrina tradizionale.
«Il nostro Dio si è fatto uomo per poter piangere», ha esclamato papa Bergoglio con una delle sue battute sorprendenti. Si intuisce che cosa vuol dire. Ma nessuno sembra avere ancora gli strumenti filosofici o teologici adeguati per dare a una battuta così antropomorfica una forma dottrinale convincente, anche in sintonia con quella che alcuni teologi professionali definiscono «teologia della sofferenza di Dio».
Prima di affrontare questa problematica chiediamoci quali sono i tratti caratterizzanti dell’ermeneutica bergogliana nel suo complesso, sostenuta da una pervasiva presenza mediatica (soprattutto nel nostro paese). Quali potranno essere le conseguenze non solo nella chiesa ma nella società in generale e italiana in particolare che è in bilico tra un’approssimativa secolarizzazione e un sottile condizionamento delle sue radici cristiane.
Il pubblico al quale il pontefice si rivolge è innanzitutto «il popolo di Dio», il popolo fedele della chiesa, i semplici fedeli delle parrocchie e delle associazioni cattoliche, per i quali ha sempre parole impegnative, affettuose, spesso però anche severe. Ma non meno importanti sono i cattolici nominali, che sono ormai la grande maggioranza della popolazione e possiedono una cultura religiosa residua, inerziale. In essa i concetti fondamentali della religione cristiana quali creazione, peccato originale, redenzione, salvezza rimangono indicazioni vaghe. Bergoglio intende riattivarle tramite una «teologia narrativa» che riattualizza i fatti biblici ed evangelici presentandoli come se fossero eventi del quotidiano di oggi. Non solo essi diventano eventi immediatamente comprensibili e condivisibili, ma rispondono alla sensibilità contemporanea – al di fuori di ogni preoccupazione filologica o dogmatica. Adamo ed Eva nell’Eden sono descritti senz’altro come una normale coppia di marito e moglie di oggi. Con questo approccio, molti cristiani analfabeti di ritorno quanto a nozioni religiose, sembrano di nuovo in ascolto. Ma che cosa apprendono esattamente?
La problematica della famiglia, dell’amore coniugale e in generale dei rapporti interpersonali ruotanti sul sesso è diventata come non mai la preoccupazione centrale della chiesa. Anche polemicamente. Si pensi alla ossessiva denuncia della «teoria del gender» che, presentata senz’altro come distruttrice del matrimonio e della famiglia, è diventata un facile obiettivo polemico di distrazione, su cui si imbastiscono campagne pubblicistiche. Ma dentro alla problematica della famiglia acquista rilievo crescente la posizione e il ruolo della donna nella società e nella chiesa – con toni spesso enfatici ma sempre attenti ai limiti intrinseci, dichiarati insuperabili, che negano ogni ruolo ministeriale della donna nella chiesa. Su questo Bergoglio rimane elusivamente cauto anche quando – senza risparmiarsi qualche battuta cattiva sui teologi – invita tutti, gerarchia e fedeli, al «discernimento» che deve spingere ad assumere coraggiose e rischiose forme di responsabilità di fede, di prassi pastorale e di impegno senza formalismi dottrinali.
Cercherò di affrontare le questioni accennate come un laico che prende sul serio i contenuti delle credenze religiose delle donne e degli uomini che dicono di avere fede (comunque la intendano). Come un laico che analizza il discorso teologico e la sua evoluzione quali fattori culturalmente e politicamente significativi per capire il nostro tempo. L’ateo militante o l’agnostico intransigente che considera il racconto biblico nient’altro che un mito inconsistente e il dibattito dottrinale bimillenario che ne è seguito come una faccenda interna alla chiesa (se non addirittura un imbroglio clericale) non saranno interessati a quanto sto dicendo. Ma questo lavoro non intende essere un banco di prova delle convinzioni personali e neppure prendere partito per chi si schiera pro o contro papa Francesco. Vuole solo capire criticamente quello che sta accadendo.
La narrazione biblica o il mito biblico (nel senso che cercherò di spiegare) interessano nella misura in cui ci fanno capire la qualità culturale, politica e mediatica del travaglio di quella che – in Italia innanzitutto – continua ad essere una religione-di-chiesa, una religione cioè strettamente condizionata nelle sue formulazioni ed espressioni dall’istituzione-chiesa. Per il resto, proprio nel nostro paese molti laici (comunque si autodefiniscano) sono spiazzati, affascinati se non addirittura sedotti da Francesco. Dietro a questo atteggiamento si cela in realtà la fragilità della laicità italiana oggi, venuta a nudo dopo la scomparsa delle grandi ideologie su cui poggiava sino a ieri il convenzionale confronto/scontro «tra laici e cattolici».
Da parte sua, l’atteggiamento di Francesco verso la laicità è denso di ambiguità. Personalmente si dichiara schiettamente amico di tutti i laici, pur mostrando predilezione per quelli che contano mediaticamente. Ma in cuor suo Bergoglio è convinto che la laicità e/o il laicismo, per non parlare dell’ateismo, siano un retaggio di un vecchio illuminismo. Li ritiene tutti – senza preoccuparsi molto di differenziarli – un esito deplorevole della secolarizzazione, che per lui non è affatto sinonimo della «età matura dell’uomo» – come lo era per Dietrich Bonhoeffer. Questo è il limite più profondo di Bergoglio.
Detto questo, non c’è dubbio che l’attività del pontefice abbia un’ampia dimensione pubblica politica che vale come un surrogato di religione civile. Questo concetto è estraneo al linguaggio del papa che, formatosi nella «teologia del popolo» di matrice sudamericana, la riadatta – con successo – alle dimensioni mondiali in cui si muove il pontificato romano. Per questo può concludere il suo discorso all’Europa (6 maggio 2016) dicendo: «sogno un nuovo umanesimo europeo». Così come viene formulato, «il sogno» bergogliano è condivisibile anche dall’ateo e dal laico che hanno sentimenti solidali a favore dei profughi e dei migranti, contro la povertà e l’emarginazione sociale, nella incessante denuncia dello sfruttamento sociale e nella promozione di un’«ecologia integrale». Nel finale del suo intervento il pontefice non menziona esplicitamente i valori religiosi che sono fortemente presenti nelle sue considerazioni, ma li lascia sottesi. Qualcosa di analogo avviene nel commento pubblico in occasione della nomina di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti. Il pontefice sottolinea i pericoli del populismo e degli autoproclamati salvatori, anche se si mantiene prudente nel giudizio diretto sul neopresidente americano.
Sin dalle prime settimane del suo pontificato, papa Francesco si è trovato esposto all’obiezione, o più benevolmente alla preoccupazione, che il suo approccio e il suo interesse eminentemente pastorali mettessero in difficoltà la dottrina della chiesa su alcuni punti sensibili, con effetti imprevedibili. Questa preoccupazione è emersa apertamente nei sinodi sulla famiglia che si sono conclusi con l’esortazione papale Amoris laetitia (marzo 2016), che non ha tranquillizzato per niente i suoi critici. Anzi, è diventata il baricentro del dissenso al suo pontificato, che viene puntigliosamente registrato da personalità religiose e laiche.
Le questioni solo apparentemente marginali dei credenti divorziati risposati e il mutato atteggiamento verso l’omosessualità non sono dettagli che si possono affrontare e risolvere in termini meramente pastorali. Neppure l’approccio «misericordioso» verso il peccato d’aborto. Mettono sotto pressione il quadro tradizionale di riferimento alla dottrina (l’indi...