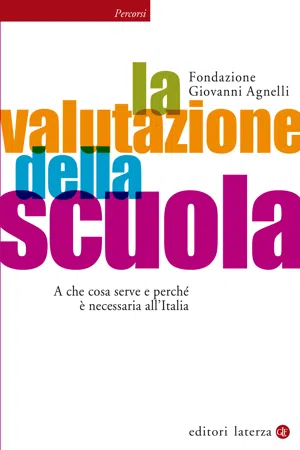VII. La valutazione in Italia: dalle sperimentazioni al Regolamento
1. Perché tante sperimentazioni?
Nella scuola italiana, valutazione fa rima con sperimentazione. Questo è stato senz’altro vero nei quindici anni intercorsi tra il varo dell’autonomia scolastica, alla fine del secolo scorso, e l’approvazione nel marzo 2013 del Regolamento che istituisce e disciplina il Sistema nazionale di valutazione. Per quali motivi, al fine di valutare gli insegnanti o i dirigenti scolastici, o ancora le scuole, si è in genere scelta la strada delle sperimentazioni?1 E ancora: quali sono le conseguenze di tale scelta?
Sul versante dei motivi, sappiamo che nel mondo della scuola la valutazione continua a incutere timori. In un contesto poco favorevole, una procedura valutativa risulta maggiormente gradita, o perlomeno ha minore probabilità di essere osteggiata, se viene presentata sotto forma di esperimento.
Un secondo motivo di ricorso alle sperimentazioni va ricercato nel fatto che la valutazione è per sua natura un’operazione complessa. Come dimostrano le esperienze internazionali (cfr. in proposito i capitoli II e III), non esiste una formula unica di valutazione degli attori e delle istituzioni scolastiche, universalmente riconosciuta: vi sono invece numerosi approcci diversi, ognuno con propri pregi e difetti. L’esigenza di adattare gli strumenti alle peculiarità della scuola italiana ha indotto i decisori a intraprendere percorsi sperimentali tali da consentire l’adozione in corso d’opera di modifiche anche importanti al disegno valutativo.
Un altro motivo che ha favorito l’approccio sperimentale va ricercato nella carenza di risorse. Con circa 8.600 istituzioni scolastiche statali e quasi altrettanti dirigenti, circa 800mila insegnanti e 8 milioni di studenti – ai quali va aggiunto il settore delle scuole paritarie, che sono frequentate da altri 400mila studenti dalle primarie alle superiori –, il sistema italiano ha una dimensione complessiva simile a quella del Regno Unito, che tuttavia spende annualmente oltre 200 milioni di euro per la funzione valutativa e ispettiva. In tempi di tagli e di spending review le risorse disponibili per la valutazione della scuola italiana sono state però nettamente inferiori (e temiamo destinate a rimanere tali): la scelta di intervenire su perimetri ridotti – alcune province, oppure qualche centinaio di scuole – ha così rappresentato una soluzione di compromesso.
Si consideri, infine, che l’annuncio di un progetto sperimentale è sinora riuscito a soddisfare la comprensibile esigenza dei decisori di rispondere attivamente alle diverse forme di pressione verso la valutazione, siano esse state esercitate dal Parlamento, dall’Unione Europea o da una parte dell’opinione pubblica.
Alle spiegazioni qui evocate andrebbe forse aggiunta un’ulteriore considerazione: nella maggioranza delle sperimentazioni valutative dell’ultimo decennio, alla ricchezza della comunicazione iniziale ha generalmente fatto seguito una povertà di rendicontazione. Lo scarso interesse nei confronti di un serio bilancio sugli strumenti valutativi adottati – in parte dettato dal fatto che al termine della sperimentazione coloro che l’avevano promossa, membri del governo e del Parlamento o figure apicali del ministero, avevano nel frattempo cambiato ruolo – costringe ogni volta a ripartire da zero, con una nuova sperimentazione2.
Immediatamente, però, saltano agli occhi alcune conseguenze negative che derivano da questo sistematico ricorso alle sperimentazioni in campo valutativo. La prima è che a essere valutati sperimentalmente finiscono per essere sempre e soltanto gli insegnanti, i dirigenti o le scuole che rispondono a determinati criteri di selezione, il più importante dei quali sembra essere quello della disponibilità a essere valutati. Risulta quindi complicato o persino improprio generalizzare i risultati di un progetto ai soggetti che per qualsiasi motivo non hanno voluto o potuto prendervi parte.
Inoltre, il carattere sperimentale si associa necessariamente a una percezione di provvisorietà dell’operazione: poiché è improbabile che incentivi transitori riescano a indurre sostanziali modifiche nei comportamenti degli attori scolastici, ad esempio nelle strategie didattiche dei docenti, è presumibile che una sperimentazione una tantum produca, a parità di incentivi, effetti meno pronunciati o persino diversi da quelli che si avrebbero in presenza di un sistema di valutazione stabile.
Queste considerazioni segnalano alcuni limiti dei reiterati tentativi di valutazione. Per contro, vi è un risvolto apprezzabile, ossia la loro capacità di mantenere vivo il dibattito nazionale sul tema, promuovendo la diffusione di una cultura della valutazione in un ambiente fino a ieri poco permeabile.
2. Genesi delle sperimentazioni promosse dal ministro Gelmini
2.1. Istituzione e mandato del Comitato tecnico-scientifico. Il 25 giugno 2008 il neonato governo Berlusconi IV emana un decreto contenente Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Tra queste vi sono le basi normative per i «tagli» (87mila docenti e 43mila Ata), la responsabilità dei quali verrà assegnata al ministro Mariastella Gelmini, da poche settimane arrivata al vertice di viale Trastevere, sebbene non vada trascurato il ruolo del ministro dell’Economia Giulio Tremonti, per certi versi ancora più determinato a perseguirli col massimo rigore. Benché non si occupi direttamente di attività valutative, quel provvedimento aprirà una pagina importante per la valutazione in ambito scolastico: un suo comma prevede infatti che il 30% delle risorse risparmiate grazie alle nuove disposizioni in materia di organizzazione scolastica sia utilizzato per «incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola» (art. 64, comma 9)3. Per chi sia interessato ai ricorsi storici, si può notare che è lo stesso meccanismo di finanziamento che era previsto per retribuire i vincitori del «concorsone» di Berlinguer.
Le cifre in ballo sono rilevanti: nel primo anno di applicazione della legge la somma attesa per la valorizzazione e lo sviluppo professionale del personale scolastico ammonta a circa 140 milioni di euro, destinata a crescere fino a 490 nell’anno successivo4. Per stabilirne i criteri di assegnazione il Miur istituisce un Comitato tecnico-scientifico internazionale (di seguito Cts) per l’elaborazione delle linee strategiche relative alla costruzione di un sistema nazionale di valutazione5.
Obiettivo del Cts è disegnare un meccanismo di assegnazione di premi ai docenti: per farlo, emerge subito l’esigenza di dar vita a un sistema di valutazione, sulla cui base assegnare i premi in modo non arbitrario, anche alla luce della necessità di dar corso nel mondo della scuola alla riforma Brunetta (cfr. i relativi paragrafi nel capitolo VI). La riforma prevede che tutti i dipendenti pubblici siano assoggettati a una forma annuale di valutazione sulla base della loro performance. Per le caratteristiche peculiari della professione docente e per la difficoltà di definire una buona performance in ambito scolastico, gli insegnanti – ma non i dirigenti scolastici e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario – sono stati inizialmente esclusi dall’immediata applicazione della riforma. Al Cts viene quindi richiesto di costruire un meccanismo valutativo e premiale per i docenti, secondo lo spirito della riforma del pubblico impiego.
Sin dalle riunioni iniziali, tenutesi nel primo semestre del 2010, maturano nel Cts due convinzioni. La prima è che il sistema premiale debba avere carattere nazionale e non regionale, nonostante all’epoca fosse ancora viva l’idea di una devoluzione del controllo delle scuole alle Regioni, come previsto dal nuovo Titolo V della Costituzione (si veda anche il Rapporto sulla scuola in Italia 2010 della Fondazione Agnelli). La seconda è che una condizione necessaria per erogare premi sia di disporre di un sistema di valutazione sull’operato di scuole e docenti improntato al principio della comparabilità: lo suggeriscono la ricerca e anche la conoscenza di esperienze internazionali. In assenza di un fondamento di comparabilità, l’assegnazione dei premi sarebbe inevitabilmente arbitraria oppure guidata da criteri di natura amministrativa, che mal si prestano a giudicare il lavoro degli insegnanti.
Il disegno del sistema di valutazione abbozzato dal Cts è quello comunemente noto come «delle tre gambe», destinato a essere ripreso dal Regolamento sul Snv in materia di istruzione e formazione del 2013: si compone dell’Invalsi, l’ente designato alla conduzione delle rilevazioni standardizzate degli apprendimenti degli studenti; di un corpo autonomo e indipendente di ispettori, specializzati nelle visite alle scuole; e dell’Indire6, incaricato di coadiuvare le singole scuole a valle della valutazione in senso stretto, ferma restando la possibilità per ciascuna scuola autonoma di avvalersi degli strumenti formativi e di consulenza che ritiene più appropriati.
2.2. La scelta obbligata delle due sperimentazioni. Mentre il Cts è impegnato in discussioni sulla più opportuna architettura del sistema nazionale di valutazione, si verificano due fatti nuovi: dapprima, nell’ambito delle misure urgenti di stabilizzazione finanziaria, vengono congelati gli scatti di anzianità per tutto il pubblico impiego, compresa la scuola; in seguito, di fronte alle manifestazioni di protesta, il governo decide di usare per il ripristino degli scatti di anzianità per il personale scolastico proprio quelle risorse derivanti dai tagli inizialmente destinate alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera. Dei 351 milioni disponibili7, 320 vengono così dirottati al «recupero dell’utilità dell’anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali del personale docente, educativo ed ATA»8. Per le attività che il Cts sta progettando rimangono, dunque, soltanto 31 milioni di euro: pur sempre una cifra notevole, ma ovviamente insufficiente a dar vita a un sistema nazionale di valutazione e di valorizzazione della professione docente. Per cui, ancora una volta, la scelta di affidarsi a sperimentazioni dal perimetro ristretto diventa praticamente obbligata.
L’altro problema è che nell’ambito del Cts si sono nel frattempo consolidati due filoni contrapposti di pensiero: uno che intende orientare la sperimentazione verso la valutazione dei singoli docenti, nello specifico spirito «meritocratico» della riforma Brunetta; l’altro che – comunque mantenendo l’elemento meritocratico e premiale implicito nel mandato della sperimentazione – ritiene invece opportuno concentrarsi sulla valutazione delle istituzioni scolastiche, considerata più centrale al fine della costruzione di un sistema nazionale di valutazione e del superamento delle criticità della scuola italiana. Come abbiamo avuto modo di vedere nei capitoli precedenti, quella dei singoli docenti e quella delle istituzioni scolastiche sono due dimensioni della valutazione profondamente diverse per logica, per strumenti utilizzati e utilizzabili, diversi gradi di affidabilità e soprattutto per le finalità perseguite in termini diagnostico-formativi e organizzativi, come pure sul versante dell’attribuzione degli incentivi. Non stupisce dunque che, alla luce dei diversi orientamenti iniziali, le successive riunioni del Cts finiscano per accentuare una netta polarizzazione tra i due approcci valutativi proposti.
Il gruppo che propende per la valutazione dei docenti, anche alla luce delle difficoltà di misurazione del contributo offerto dal singolo docente agli apprendimenti degli studenti (cfr. Scheda. Il valore aggiunto e l’identificazione dei meriti individuali e collettivi e il par. 2.1 del capit...