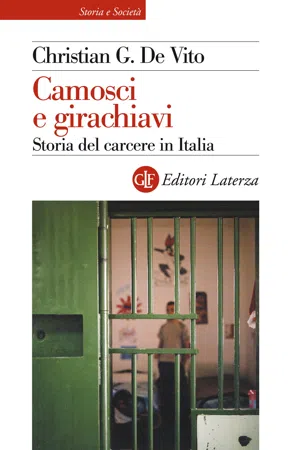III. Rivolte, riforme, repressione
Il carcere sottosopra
Le foto scattate da padre Ruggero, cappellano de Le Nuove, non lasciano dubbi1: è come se un uragano fosse passato nelle sezioni travolgendo l’ordine carcerario. I cancelli delle celle erano aperti, le pesanti porte di legno scardinate, i lucchetti rotti e gettati sul pavimento. I muri, anneriti dal fumo dei materassi bruciati, erano coperti di slogan contro la «giustizia di merda». Uno di essi ricordava che «il Capitale ha mille facce: le caserme, la famiglia, la scuola, la chiesa» e, naturalmente, il carcere. Altri simboli del potere penitenziario erano stati distrutti durante quella rivolta dell’aprile del 1969: l’ufficio matricola, il casellario, i macchinari ai quali i detenuti lavoravano otto ore per una mercede di 350 lire al giorno.
Da Le Nuove la protesta si diffuse al carcere genovese di Marassi. Gli slogan principali: riforma dei codici, rispetto dell’uomo. In serata, 2000 tra poliziotti e carabinieri circondarono l’istituto penitenziario milanese di San Vittore2. Dai tetti altissimi sui quali precariamente si muovevano, sopra le file di finestre sbarrate delle celle, i detenuti tiravano tegole e qualsiasi oggetto a loro disposizione, sostenuti dai giovanissimi reclusi che dal prospiciente istituto penitenziario minorile lanciavano piatti e bicchieri. I reparti «celeri» accorsi da tutto il Nord Italia risposero con sventagliate di mitra, colpi di pistola, lacrimogeni. Dopo quindici ore, entrati nelle sezioni e liberati gli agenti presi in ostaggio, ebbero ragione dei ribelli. La battaglia era cominciata3.
Quando ancora gli scontri impazzavano a Torino e Milano, un’eco giunse dal Sud, da quel carcere giudiziario di Bari con oltre 500 detenuti, sovraffollato e privo dei minimi requisiti igienici4. Il 15 aprile i reclusi forzarono i cancelli di tutto il corridoio centrale, appiccarono il fuoco alle lavorazioni e salirono sui tetti dopo aver forato il solaio. Ben presto, la distanza geografica tra Nord e Sud venne colmata, e in decine di carceri, in tutta la penisola e nelle isole, migliaia di reclusi protestarono. «In solidarietà con i rivoltosi di Torino e Milano»5 scesero in lotta i detenuti di Reggio Emilia, Bologna e Ancona, del piccolo istituto di Fermo, del giudiziario fiorentino e della casa di lavoro all’aperto di Capraia. Alla fine del mese anche il direttore delle carceri giudiziarie di Ferrara fu costretto a prendere atto del «clima di contestazione, che, purtroppo, ha contagiato, ormai, anche gli Istituti di pena»6.
Si diffusero dunque a macchia d’olio le proteste, si diffusero le rivendicazioni alla base di esse. In parte erano le stesse già avanzate nel giugno 1968 nel corso delle rivolte de Le Nuove, di San Vittore, di Poggioreale e dell’Ucciardone. I detenuti erano «stufi che ci si prometta sempre riforma del codice ed una essenziale riforma carceraria che ci ridia dignità»7. Ora volevano lottare direttamente per affermare quella dignità, per cambiare i codici, le leggi, i regolamenti penitenziari e, insieme, per un aumento delle ore di passeggio e dei colloqui, per una maggiore pulizia delle celle, per un servizio sanitario decente e contro gli abusi degli agenti di custodia.
Le mura di cinta, la censura, i cancelli, i delatori, i buglioli, le celle di isolamento, le sbarre: ecco la materia prima di cui erano fatte le proteste dei detenuti. Spontanea o organizzata, ogni mobilitazione dei reclusi era condannata a porre al centro la materialità del carcere. Era per forza di cose una «rivolta, al livello dei corpi, contro il corpo stesso della prigione», come scrisse in quegli anni Michel Foucault in una delle prime pagine del suo Sorvegliare e punire8.
Quando i reclusi cessarono ogni resistenza e scesero dai tetti, dentro San Vittore vennero incolonnati e fatti passare tra due ali di poliziotti e guardie carcerarie che presero a percuoterli con manganelli, calci, pugni, cinghie, perfino catene9. Giunti così all’ufficio matricola, vennero ammanettati a gruppi di cinque e caricati su camion militari. Quanti erano diretti in Sardegna vennero ammassati nelle stive delle navi, poi, una volta giunti a destinazione, denudati, perquisiti ovunque, intimiditi con discorsi minacciosi, furono nuovamente picchiati dagli agenti locali e infine abbandonati per giorni nelle celle di punizione.
Di fronte alle proteste l’attitudine prevalente delle autorità penitenziarie fu quella repressiva. Il tentativo fu quello di isolare il mondo carcerario dall’esterno. Nella tarda serata del 15 aprile 1969 un telegramma del ministro di Grazia e Giustizia, Antonio Gava, disponeva l’«assoluto divieto rilascio qualsiasi dichiarazione stampa et ogni altro organo informazione da parte personale civile et militare dipendente questa amministrazione»10. Circa una settimana più tardi un consigliere della Direzione generale comunicava all’ispettore distrettuale di Firenze che «i Parlamentari non possono indagare in merito ai recenti episodi di indisciplina»: qualora si fossero presentati all’ingresso delle carceri sarebbero stati «ricevuti coi riguardi dovuti al loro altissimo rango», ma avrebbero avuto diritto solo ai chiarimenti «che non riguardano le attuali agitazioni nelle carceri»11.
Negli istituti penitenziari così isolati, i trasferimenti punitivi divennero una pratica di massa, attuati contro decine, talvolta anche centinaia di detenuti per volta12. Da Torino, Milano e Genova i «sobillatori» venivano mandati nelle carceri «dure» di Volterra, Pianosa e Porto Azzurro, o ancora più lontano, nelle carceri meridionali. Da lì, se tentavano di dar vita a nuove proteste, venivano ulteriormente allontanati. Modalità sempre più abusata di repressione, i trasferimenti disciplinari determinarono però un effetto ambiguo. Fu principalmente attraverso essi, infatti, che la protesta si diffuse, con i protagonisti delle grandi rivolte che entravano in contatto con i reclusi degli altri istituti penitenziari, riferivano di persona le esperienze fatte, diffondevano le parole d’ordine del movimento in via di formazione.
A preoccupare i direttori carcerari non era solo l’«insostenibile clima di tensione» prodotto dall’arrivo di quegli «elementi turbolenti e sobillatori»13. Ogni ondata di trasferimenti portava anche squilibri crescenti nel già precario assetto dell’organizzazione penitenziaria, rendendo di fatto ancor più visibili i problemi che le proteste denunciavano. Per far fronte a quella oggettiva situazione di ingestibilità del carcere alcune direzioni finirono per recepire parte delle richieste avanzate dai detenuti. Scesi nuovamente in lotta tra il dicembre del 1969 e il gennaio dell’anno successivo, i reclusi ottennero così, a seconda del carcere, di fare la doccia più frequentemente, di assistere per tre volte alla settimana agli spettacoli televisivi, di prolungare il tempo del «passeggio», di tenere in cella i fornelli da campeggio o l’aumento degli organici dei lavoranti preposti alle pulizie.
Concessioni più generali vennero fatte a livello centrale14. Con due circolari emanate nel periodo giugno-luglio 1969 venne disposto un relativo miglioramento del vitto e si prese atto dell’incostituzionalità di alcuni articoli del regolamento penitenziario contrastanti con la libertà di culto. Già nel maggio 1969 una circolare dispose inoltre la costituzione in ogni stabilimento di una rappresentanza di detenuti per il controllo delle somministrazioni vittuarie, sia pure sorteggiata e non eletta come chiedevano i reclusi. Era un primo passo importante per l’affermazione delle istanze più propriamente politiche del movimento dei detenuti. Con la successiva circolare ministeriale del 14 febbraio 1970 il governo consentì la circolazione in carcere della stampa politica e delle varie associazioni operanti nel paese, purché legalmente riconosciute.
Il movimento dei detenuti si mostrava capace di agitare le acque della palude carceraria. Si trattava ora di vedere se e come sarebbe riuscito a dare seguito a quelle proteste e quali obiettivi avrebbe potuto raggiungere.
I dannati della terra
A circa vent’anni dalle grandi rivolte del dopoguerra i detenuti tornavano a far sentire la loro voce. Se non era cambiata più di tanto l’istituzione carceraria, come i reclusi stessi denunciavano, si erano trasformate tuttavia profondamente sia la composizione della popolazione detenuta che la società esterna.
Le proteste del dopoguerra avevano rappresentato il prolungamento di una rivolta contro le condizioni materiali di vita in carcere, rese ancora più dure dalla congiuntura bellica e post-bellica: un sommovimento veemente, ma incapace di assicurarsi un’autonomia che gli consentisse di avere continuità. All’esterno, inoltre, esse non avevano trovato alcuna sponda politica e le stesse forze di sinistra avevano contribuito a isolarle e reprimerle agitando la bandiera di un fantomatico pericolo fascista.
Adesso invece, alla fine degli anni Sessanta, a una popolazione detenuta ridisegnata dal «miracolo economico» corrispondeva un processo di sensibilizzazione attorno alla questione carceraria in alcuni settori dell’altrettanto mutato mondo esterno. Il movimento dei detenuti si sviluppava dentro il quadro più generale della contestazione che dal mondo studentesco e operaio tracimò verso il complesso della società e delle istituzioni statuali. La «lunga durata» di quel movimento contestativo fu la precondizione di ogni mobilitazione sociale specifica degli anni successivi, compresa quella dei reclusi.
La frattura politica, culturale, sociale del Sessantotto non fu indolore per i suoi protagonisti. A Valle Giulia ci furono centinaia di feriti e molti arresti tra gli studenti. Quindici giorni dopo le camionette della polizia si riempirono di nuovo per trasportare in questura e poi i...