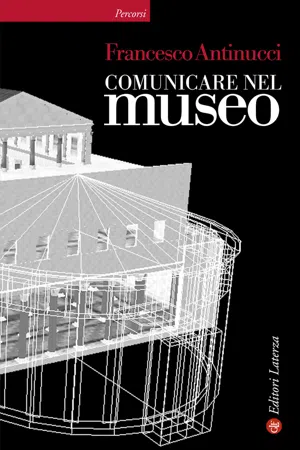II. La struttura concettuale del museo e la sua origine
Il circuito comunicativo dell’opera d’arte
Ritorniamo alla situazione iniziale. Abbiamo detto che comunicare significa: «qualcuno comunica qualcosa a qualcun altro», e nel seguito dell’esposizione abbiamo visto in che modo questo avvenga: il qualcuno costruisce ed emette un segno in base ad un codice e a un contesto che condivide con il qualcun altro – il destinatario della sua comunicazione – che permettono ad esso di interpretarlo, e cioè di ricavare il qualcosa.
Le opere d’arte, in quanto segni, funzionano esattamente in questo modo.
Basterà considerare un qualunque caso prototipico della tipologia più varia per rendersene facilmente conto: una pala d’altare (ad esempio, la pala d’altare di Tiziano nella chiesa di Santa Maria dei Frari a Venezia), le tele o gli affreschi di una cappella commemorativa (ad esempio, la cappella Contarelli con le tele di Caravaggio su san Matteo nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma), il soffitto dipinto di una chiesa (ad esempio, quello illusionisticamente «sfondato» della chiesa del Gesù a Roma, con la raffigurazione del Trionfo del Nome di Gesù del Baciccia) o di una sala privata (ad esempio, quello del salone di Palazzo Barberini con il Trionfo della Divina Provvidenza di Pietro da Cortona, al cui centro è raffigurata l’«apoteosi» delle api, simbolo dei Barberini), un ritratto individuale (ad esempio, il ritratto del viceammiraglio Michiel Adriaensz de Ruyter, di Ferdinand Bol, al Rijksmuseum di Amsterdam) o collettivo (ad esempio, la famosissima cosiddetta Ronda di notte, in realtà il ritratto della compagnia di milizia cittadina del capitano Frans Banning Cocq di Rembrandt, al Rijksmuseum di Amsterdam), e così via.
L’unico elemento notevole nel caso delle opere d’arte è che spesso il qualcosa da dire non è ideato dall’autore del segno, ma da qualcun altro (il cosiddetto «committente», o un suo «ideologo»). Ma ciò non cambia in nulla il funzionamento del circuito comunicativo; anzi, contribuisce semmai a rendere ancora più preciso ed esplicito il messaggio, dato che il committente deve comunicarlo all’autore (nel caso, ad esempio, del soffitto Barberini il messaggio fu ideato dal letterato Francesco Bracciolini e se ne può leggere una formulazione scritta da Girolamo Teti nel volume Aedes Barberinae ad Quirinalem: «Il trionfare della Divina Provvidenza e il compiersi dei suoi fini sotto il pontificato di Urbano VIII»). In questa situazione, infatti, l’autore ha un ben preciso risultato da ottenere: è specificato il messaggio e sono specificati i suoi destinatari (l’audience) direttamente o indirettamente (per esempio, ricavandolo dalla frequentazione del luogo di destinazione dell’opera). È su questa base che egli sceglierà il codice da utilizzare (che però, salvo momenti di rottura e trasformazione, è normalmente dato), ma, soprattutto, determinerà il contesto del segno.
L’opera d’arte e il contesto enciclopedico, deittico, anaforico
È la nozione di contesto a tutto campo, così come l’abbiamo articolata precedentemente, che si applica a questo caso, anche se ciò può non sembrare immediatamente evidente. Vi sono ovviamente al primo posto presupposizioni di tipo enciclopedico, il cui livello è fondamentalmente determinato dalla natura dell’audience cui il messaggio è rivolto. Così è evidente che esse saranno diverse se l’opera è destinata ad un luogo pubblico come una chiesa o ad un luogo privato, come un palazzo patrizio. I fedeli che si recano nella chiesa del Gesù non coincidono, come audience collettiva, con gli ospiti dei Barberini.
Bisogna tuttavia tener presente che il concetto di audience collettiva come l’abbiamo delineato nel capitolo precedente non coincide necessariamente con l’insieme dei frequentatori del luogo cui l’opera è destinata: è l’autore del messaggio (in questo caso nella sua doppia veste di committente e realizzatore) che comunque sceglie, tra coloro che entreranno in contatto con l’opera, chi è il suo interlocutore. Così, non soltanto, banalmente, non conterà come audience il personale di servizio di Palazzo Barberini, ma potrebbero non contare, paradossalmente, anche molti dei frequentatori della chiesa del Gesù: il messaggio potrebbe essere fondamentalmente rivolto, ad esempio, a un’audience di «conoscitori», come gli appartenenti all’ordine dei gesuiti a mo’ di comunicazione «interna» (o, viceversa, ad altri ordini religiosi). Non dissimile, del resto, è il caso di molti discorsi «pubblici» fatti soprattutto da politici i cui contenuti hanno come veri destinatari i «conoscitori», costituiti da politici di altre forze, oppure dai propri compagni di partito, corrente, ecc. Naturalmente esiste anche il caso in cui l’opera non soltanto è destinata ad un luogo pubblico ma il pubblico, tutto il pubblico, è il suo destinatario: molti affreschi medievali e molte opere «murali» moderne sono di questo tipo. Il concetto più preciso da adoperare è quello di audience pertinente.
Non vi è, tuttavia, il solo contesto enciclopedico. Altrettanto importanti sono il contesto anaforico e deittico, anche se può sorprendere che queste nozioni si applichino al caso dell’opera d’arte. Vi si applicano invece benissimo. Quello deittico non è altro che l’ambiente che circonda l’opera, ed è di regola importantissimo per la corretta lettura e interpretazione del messaggio. Esso può operare a vari livelli.
Il primo è, ad esempio, quello della «cognizione» dell’ambiente. L’interpretazione alla vista del ritratto del viceammiraglio Michiel Adriaensz de Ruyter, di Ferdinand Bol, dipendeva sicuramente dal fatto che esso era esposto nella sala del consiglio dell’Ammiragliato: è solo quest’ambiente che rende pertinente la storia della marina olandese e, soprattutto, delle sue imprese più fulgide. Chi sedeva in quel consiglio o stava in quel luogo non poteva non richiamare alla memoria la straordinaria vittoria sulla flotta inglese, nell’epica battaglia dei Quattro Giorni, dall’11 al 14 giugno 1666, e il ruolo che vi ebbe de Ruyter, il quale, per di più, era stato promosso viceammiraglio solo pochi giorni prima. È a questi eventi che allude la rappresentazione che circonda e inquadra il ritratto (cfr. Haak 1984). D’altra parte, anche l’interpretazione della pittura della volta della chiesa del Gesù, con l’apoteosi del monogramma di Gesù, non può prescindere dal sapere di essere nella chiesa madre dei gesuiti, contenente la tomba del fondatore dell’ordine, sant’Ignazio di Loyola.
Vi è poi il livello in cui il contesto deittico opera nella sua vera e propria fisicità, per così dire. È il caso delle opere fatte apposta per essere inserite in un certo spazio architettonico, di cui la costruzione rappresentativa tiene conto. Ad esempio, questo tende ad essere tipicamente il caso delle pale d’altare. Siccome il significante dell’opera d’arte è di natura visivo-figurale, esso è soggetto, come abbiamo già notato, alle leggi regolanti la percezione visiva di tipo gestaltico. Nei casi di cui stiamo parlando lo spazio architettonico fisico e l’opera, e cioè ciò che è rappresentato nell’opera, possono formare, dal punto di vista percettivo, un tutt’uno inscindibile proprio perché fa scattare leggi di campo. In questo caso, il contesto deittico, nel senso del contesto fisico che circonda l’opera, è fondamentale per la lettura dell’opera, in quanto diventa parte integrante del suo significante.
Così accade, ad esempio, per la pala d’altare di Tiziano nella chiesa dei Frari di Venezia, che abbiamo appena citato tra i nostri esempi. Un caso in cui la pala non è più al suo posto rende ancora più evidente l’essenzialità del contesto deittico: «Se si potesse riportare la Pala di Brera [Madonna con Bambino, sei santi, quattro angeli e il duca Federico II da Montefeltro, di Piero della Francesca, originariamente situata sull’altare maggiore della chiesa di San Bernardino di Urbino] nel S. Bernardino di Urbino, ricollocandola nell’ubicazione originaria, si otterrebbe un caso illuminante di perfetto accordo o simbiosi tra l’architettura costruita da Francesco di Giorgio e la costruzione architettonica figurata di Piero» (Ragghianti 1974, p. 98).
Esiste, infine, un caso in cui si può fare il paragone diretto tra presenza e assenza del contesto deittico appropriato sullo stesso dipinto. Si tratta del celebre quadro del Veronese Le Nozze di Cana, dipinto nel 1562 per la sala del refettorio del convento benedettino che aveva sede sull’Isola di San Giorgio a Venezia. L’enorme tela – circa 7 metri per 10 – era stata perfettamente adattata alla parete di fondo della sala, così come l’architettura della scena dipinta e il suo punto di vista, dato che il percorso per raggiungere la sala è leggermente in salita e permette di vedere da molto lontano la scena stessa. Questa si svela – ingrandendosi a mano a mano che si procede, fin quasi ad immergere lo spettatore una volta che sia davanti ad essa – all’altezza del luogo dove erano collocati i tavoli per la refezione, generando un’esperienza totale, non soltanto visiva ma anche motoria e propriocettiva, che doveva essere sicuramente accentuata dal contesto culinario fisico che solitamente l’accompagnava.
Il dipinto fu sottratto da Napoleone nel 1797 e spedito in Francia, dove da allora è esposto in una sala del Louvre. Qui le condizioni deittiche non sono neanche lontanamente simili a quelle originali e, a peggiorare ulteriormente le cose, il quadro è esposto sulla parete opposta a quella della Monnalisa, dunque in uno spazio perennemente affollato di schiene (il Louvre ha attualmente – 2014 – una media di 3000 visitatori l’ora che vanno tutti a vedere la Monnalisa) che, nonostante le ragguardevoli dimensioni della sala – circa 28 metri di lunghezza –, rendono impossibile anche il solo raggiungimento di una distanza di osservazione compatibile con le dimensioni dell’opera.
Tuttavia nel 2007 – e cioè esattamente 210 anni dopo essere stato portato via – Le Nozze di Cana è stato reinstallato nella sua sede originale sull’Isola di San Giorgio: naturalmente non il dipinto originale ma una sua copia che però, grazie a una straordinaria combinazione di virtuosismo tecnologico e raffinato artigianato (si veda www.factum-arte.com/pag/38/A-facsimile-of-the-Wedding-at-Cana-by-Paolo-Veronese), è una copia perfetta dell’originale, assolutamente indistinguibile da esso anche dalla distanza più ravvicinata che l’ambiente permette. Ebbene, se si avesse qualche dubbio sull’importanza del contesto deittico, basterà visitare l’opera in entrambi i contesti per rendersi conto, dall’enorme scarto tra le due esperienze, della privazione comunicativa che l’opera del Louvre subisce.
C’è poi il contesto anaforico, facilmente definibile, in analogia con quello linguistico, come la presenza di altre opere d’arte, altri segni, che accompagnano quello che dobbiamo interpretare. Così, alla tela della Vocazione di San Matteo della cappella Contarelli di Caravaggio rispondono la tela di fronte con il Martirio del santo, quella centrale del San Matteo e l’Angelo, dello stesso autore, ma anche gli affreschi della volta della cappella, rappresentanti la Guarigione della figlia del re di Fenicia da parte di San Matteo, opera questa del Cavalier d’Arpino. Pur senza essere un ciclo narrativo organico, è evidente che l’interpretazione di ciascuna opera-segno è influenzata dalle altre, quanto meno in relazione alla scelta di quali episodi di quest’unico tema vengono narrati e di come vengono rappresentati. E, dunque, si può ben dire che ciascuna opera ha come contesto anaforico le altre.
C’è inoltre, anche in questo caso, un ricco contesto deittico: la cappella è dedicata al Contarelli, il cui nome di battesimo è Matteo, anzi, per la precisione si tratta di Mathieu Cointrel, cardinale francese morto una quindicina d’anni prima, ben noto alla comunità francese – che è il pubblico d’elezione, l’audience, della chiesa in cui si trova la cappella, essendo questa (San Luigi dei Francesi) la chiesa della nazione francese – e il cui nipote François Cointrel, oltre che committente della cappella, era, al tempo, anche uno dei due rettori della chiesa stessa.
Il contesto e il museo
Analogamente esisteva un ricco e fondamentale contesto anaforico (nonché deittico, naturalmente, ma su questo non ci soffermeremo) per la cosiddetta Ronda di notte di Rembrandt. Il dipinto fa parte di un genere molto comune nell’Olanda del XVII secolo: il ritratto collettivo di una compagnia della guardia civica. Ne esistono molte dozzine: quando una compagnia terminava il suo servizio, i suoi membri di solito si facevano ritrarre. Il dipinto veniva posto nella sede della organizzazione di milizia cui la compagnia apparteneva, sede dove si svolgevano le adunanze e i banchetti formali delle stesse compagnie. E proprio per decorare la nuova sala di adunanze e banchetti della milizia degli archibugieri il quadro fu commissionato a Rembrandt dai membri della compagnia comandata da Frans Banning Cocq intorno al 1638.
Una sala che misurava circa dieci metri per venti e di cinque metri di altezza, con un lato di finestre sul fiume Amstel; agli altri tre lati sei pitture, ritratti di sei compagnie, più una, ritratto del collegio dei reggenti della milizia. I più celebri pittori dell’epoca ricevettero, insieme a Rembrandt, gli incarichi dei vari quadri con la perfetta consapevolezza che si trattava del progetto più grande e importante mai lanciato fino ad allora, e che, dunque, avrebbe messo in gioco una parte rilevante del prestigio di ciascun autore. Messa in questi termini, l’impresa non poteva non avere i connotati del confronto e della competizione: fra le compagnie attraverso i loro ritratti e fra gli stessi autori dei ritratti.
Si può quindi facilmente immaginare quale fosse l’importanza e l’impatto del confronto visivo che si veniva a creare nella sala: ogni opera rispondeva alle altre e da esse traeva una sua fondamentale giustificazione. L’effetto era ancor più amplificato dal fatto che il tema era lo stesso per tutte, e dunque faceva risaltare non solo la generica maestria tecnica, ma il tipo di soluzione scelta, la capacità di innovare e interpretare il genere, e così via.
Un esempio solo darà un’idea della ricchezza e complessità di questo effetto: insieme al Rembrandt era esposto (e, per fortuna, lo è tutt’oggi nella sala del Rijksmuseum, anche se non nella stessa posizione relativa) il ritratto della compagnia del capitano Cornelis Bicker di Joachim von Sandrart. Una raffigurazione statica, tradizionale, quest’ultima, con gli uomini raggruppati come in una posa fotografica attorno – unico elemento di novità caratterizzante – al busto di Maria de’ Medici. Radicalmente diversa l’interpretazione di Rembrandt dello stesso tema: inusuale, innovativa, con gli uomini sparsi e disordinati folgorati da un’«istantanea» nell’attimo prima di ricevere il comando di schierarsi e marciare.
È evidente che solo questi confronti e riscontri visivi permettono di capire il capolavoro di Rembrandt, interpretandone la reale intenzione comunicativa, come del resto ben attesta la testimonianza dell’epoca di un visitatore della sala (noto tra l’altro per essere piuttosto critico nei confronti di Rembrandt): «Questo pezzo, non importa quanto censurabile [l’autore ha precedentemente riferito alcune critiche al dipinto], supererà secondo me nel tempo tutti gli altri competitori, essendo così pittorico nel concetto, così audace nell’invenzione, così potente che, come molti sentono, tutti gli altri pezzi stanno lì vicino a lui come carte da gioco» (Van Hoogstraeten, Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst, 1678; cit. in Haak 1984, p. 296).
Difficilmente si troverebbe un caso più paradigmatico del ruolo di quello che abbiamo chiamato contesto anaforico. Lo testimonia anche il fatto che ben tre dei quadri originari che si trovavano insieme al Rembrandt sono esposti nella stessa sala del Rijksmuseum anche oggi. Al tempo stesso, proprio questo esplicito riconoscimento della funzione essenziale del contesto anaforico da parte del museo fa nascere una paradossale contraddizione, che discuteremo a fondo più avanti in questo capitolo, ma che segnaliamo subito, dato che risalta in modo particolarmente evidente (forse la parola giusta sarebbe «stridente») in questo caso.
Il Rijksmuseum possiede (più esattamente, ospita) tutti i dipinti del famoso salone degli archibugieri: perché non li espone rispettando le modalità originarie e ristabilendo così sia il contesto anaforico che quello deittico?
Abbiamo invece che la sala del Rembrandt contiene tre dei sei pezzi che accompagnavano la pittura più, strabiliantemente, un quarto quadro, di notevoli dimensioni (due metri d’altezza per quattro e mezzo di lunghezza), che occupa un intero lato della sala, ma che non ha nulla a che fare con gli altri – appartenendo ad un contesto totalmente diverso – se non il fatto di essere di soggetto analogo agli altri (ritratto di una compagnia di milizia, ma non degli archibugieri). Potendosi tranquillamente escludere in questo caso i motivi contingenti quasi sempre invocati a giustificare la non fattibilità di questa operazione (mancanza delle opere per il completamento del contesto – sono tutte nello stesso museo e per di più esposte; ignoranza sulla loro disposizione relativa e sul contenitore – esistono già dettagliate e accurate ricostruzioni «libresche»; mancanza di spazio nel museo – la ricostruzione occuperebbe poco più spazio di quello della sala attuale; ecc.), emerge chiaramente che questo comportamento «omissivo» ha invece alla base ragioni teorico-ideologiche, ragioni che andranno esaminate a fondo in quanto in evidente contrasto con il ruolo primario del co...