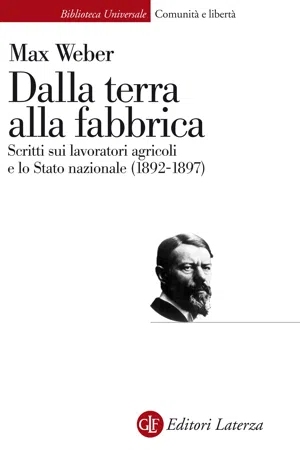
eBook - ePub
Dalla terra alla fabbrica
Scritti sui lavoratori agricoli e lo Stato nazionale (1892-1897)
- 224 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Dalla terra alla fabbrica
Scritti sui lavoratori agricoli e lo Stato nazionale (1892-1897)
Informazioni su questo libro
Le origini della riflessione sul capitalismo, il lavoro e la modernizzazione negli scritti giovanili – finora inediti in Italia – di un classico del pensiero politico contemporaneo.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Dalla terra alla fabbrica di Max Weber,S. Mezzadra,Furio Ferraresi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Filosofia e Filosofia politica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
FilosofiaCategoria
Filosofia politicaIntroduzione
di Furio Ferraresi e Sandro Mezzadra
[Per quanto l’Introduzione sia stata discussa e messa a punto nella sua redazione definitiva da entrambi gli autori (che ne sono quindi parimenti responsabili), Furio Ferraresi ha scritto materialmente i punti 1, 3, 6 e 7; Sandro Mezzadra i punti 2, 4 e 5.]
1. A lungo considerati «minori», gli scritti giovanili di Weber sui lavoratori agricoli e sulla questione nazionale (1892-1897) raccolti in questo volume si sono negli ultimi anni guadagnati il posto che meritano nella complessiva interpretazione dell’opera weberiana1. Sempre più spesso, cioè, sono stati letti non soltanto dal punto di vista della particolare lucidità della diagnosi storica che contengono, ma come una sorta di incunabolo di questioni e di categorie che Weber stesso sarebbe andato sviluppando ed elaborando lungo l’intero arco della sua vita. In questo passaggio ‘biografico’ dagli originari interessi giuridici allo studio dell’economia politica già si annuncia chiaramente quel nucleo di problemi che avrebbe condotto Weber a divenire uno dei fondatori di una nuova disciplina, la sociologia.
In questi lavori cominciano dunque a definirsi tanto i temi peculiari della riflessione weberiana matura, quanto gli strumenti concettuali e le strategie politiche che Weber adotterà per affrontarli. Lo sfondo su cui le sue analisi vengono maturando è il passaggio d’epoca dal patriarcalismo al capitalismo, dalla campagna alla città, dallo «Stato agrario» allo «Stato industriale». Per limitarci a una breve rassegna dei motivi d’interesse di questi testi, che saranno ripresi più distesamente nel corso di questa Introduzione, essi spaziano dalla scoperta straniante della potenza «oggettiva» del capitalismo e della valenza politica della lotta di classe al tema della «condotta di vita» (Lebensführung) come snodo pratico tra processo di individuazione del soggetto moderno e coazioni esercitate dal sistema sociale; dalla questione del ruolo storico-sociale della borghesia tedesca al tema della «comunità nazionale» come dispositivo politico-ideologico di ricomposizione delle lacerazioni sociali prodotte dall’avvento del capitalismo; dal problema della «legittimità» del potere e dal concetto di «lotta» ai temi della razionalizzazione e della transizione dalla «comunità» alla «società».
Diciamolo meglio. Questi scritti, in definitiva, sono talmente importanti che tutta la successiva opera di Weber può essere interpretata come tentativo di risolvere i problemi e di rispondere alle sfide che qui si presentano: la crisi di legittimità di un modello di autorità politica e di un sistema sociale e produttivo incentrato sulla «comunità d’interessi» tra signori terrieri (Junker) e contadini; la questione del controllo e della normazione dei comportamenti soggettivi del lavoro; la rideclinazione in termini etico-economici del tema della «condotta di vita» nel passaggio dal ceto alla classe dinanzi al processo irreversibile della «democratizzazione passiva»; la definizione di un ethos borghese come strumento pratico di disciplinamento sociale e di educazione all’etica del lavoro; il problema del metodo connesso all’utilizzazione di strumenti statistici per la rilevazione delle «tendenze di sviluppo» dei processi economico-sociali. Come si vede sono qui prefigurati i temi che saranno al centro dell’Etica protestante, della Sociologia della religione, dei Saggi sul metodo delle scienze storico-sociali e degli Scritti politici.
2. I testi qui presentati sono il risultato di due differenti ricerche sulla condizione dei lavoratori agricoli: la prima condotta nel 1892 dal Verein für Sozialpolitik; la seconda svolta nei mesi successivi dal Congresso evangelico-sociale.
Tra il dicembre 1891 e il febbraio 1892 il Verein für Sozialpolitik2 organizza sotto la presidenza di Gustav Schmoller un’inchiesta sui lavoratori agricoli in tutte le regioni del Reich, affidata a Hugo Thiel, Max Sering e Johannes Conrad. Al giovane Weber viene attribuito il compito politicamente più scottante, quello cioè di elaborare il materiale relativo alle province prussiane situate a est dell’Elba3. L’incarico gli viene affidato per la sua competenza scientifica in materia di rapporti agrari, dimostrata nello scritto di abilitazione sulla Storia agraria romana (1891)4. L’inchiesta si basa su due questionari inviati a circa tremila «datori di lavoro», il primo dei quali richiede dati precisi sui rapporti contrattuali e sull’entità dei «salari», mentre il secondo sollecita informazioni sullo standard dei rapporti sociali e culturali dei lavoratori5. I risultati complessivi della ricerca sono stati pubblicati nel 1892 dall’editore Duncker & Humblot di Lipsia nei volumi 53, 54, 55 delle Schriften des Vereins für Sozialpolitik con il titolo Die Verhältnisse der Landarbeiter in Deutschland. Il contributo weberiano è compreso nel volume 55 intitolato La condizione dei lavoratori agricoli nella Germania a est dell’Elba. L’impatto sull’opinione pubblica dell’epoca fu notevole. Georg Friedrich Knapp, l’economista tedesco che aveva affrontato il tema della «liberazione dei contadini» e delle riforme prussiane d’inizio Ottocento6, accolse il lavoro weberiano con queste parole: «soprattutto quest’opera ha suscitato in me l’impressione che le nostre conoscenze siano superate e che dobbiamo ricominciare a studiare daccapo»7.
In questo stesso giro di anni Weber è attivo anche all’interno del movimento evangelico-sociale, luogo di raccolta di teologi, economisti e riformatori. Esso propugnava una politica sociale d’ispirazione cristiana, che nelle intenzioni dei suoi esponenti più conservatori doveva rappresentare una sorta di terza via tra marxismo e liberalismo «manchesteriano»8. Weber era vicino alle posizioni della generazione più giovane del Congresso evangelico-sociale, e in particolare a Paul Göhre (il cui lavoro in fabbrica per fare esperienza diretta delle condizioni di vita operaie viene da lui difeso in un articolo pubblicato in «Die christliche Welt»)9 e a Friedrich Naumann10. I programmi di riforma sociale di questa generazione si differenziavano notevolmente da quelli del gruppo raccolto intorno ad Adolph Wagner, Adolf Stoecker e Moritz August Nobbe, presidente del Congresso, più favorevoli alla conservazione della struttura patriarcale della società prussiano-tedesca. Tra il 1892 e il 1893 Weber conduce per conto del Congresso, in collaborazione con il segretario generale Göhre, una nuova inchiesta sulle condizioni dei lavoratori agricoli, differente da quella del Verein für Sozialpolitik perché i questionari vengono inviati, anziché ai datori di lavoro, ai pastori dei distretti rurali, che dovevano compilarli dopo avere interpellato direttamente i lavoratori: in tal modo, Weber tentava di rispondere a un’obiezione che soprattutto da parte socialdemocratica era stata sollevata a proposito dell’inchiesta del Verein für Sozialpolitik, la quale si era basata esclusivamente sulle ‘voci’ dei datori di lavoro. I risultati vengono presentati nella relazione I lavoratori agricoli tedeschi11 (nota anche come Korreferat) alla quinta assemblea del Congresso, svoltasi il 16 e 17 maggio 1894 a Francoforte.
Ma che cosa significava, nella Germania e soprattutto nella Prussia degli anni Novanta dell’Ottocento, discutere di «questione agraria»? Sarà bene anticipare che attorno a questo tema, così come attorno a quello della «questione urbana»12, si svolse un complesso dibattito scientifico e politico, al centro del quale era il futuro economico, sociale e politico della Germania stessa, che si trovava al crocevia tra lo sviluppo capitalistico-industriale e il mantenimento dell’ordine sociale garantito dai grandi latifondi prussiani, tradizionale roccaforte dell’aristocrazia terriera degli Junker e della monarchia.
A partire dagli anni Settanta, in un contesto generale di recessione economica, una grave crisi aveva investito la produzione di cereali destinata all’esportazione, concentrata per la maggior parte nelle campagne prussiane13. Per fronteggiare la situazione, e anche per esaudire le richieste degli agrari, Bismarck vara i provvedimenti legislativi del luglio 1879, che prevedono l’introduzione di dazi protezionistici sui prodotti agricoli14 e che nelle sue intenzioni avrebbero dovuto garantire lo smercio dei cereali prussiani almeno sul mercato interno, proteggendo altresì l’agricoltura delle regioni orientali dalla crescente concorrenza con l’industria15. La politica liberista del suo successore, il cancelliere Leo von Caprivi16, costituisce una parentesi (1890-1894) nella storia del protezionismo doganale tedesco durato altrimenti fino alla prima guerra mondiale. Nell’interesse delle esportazioni tedesche e nella cornice di una politica di pacificazione con gli interessi e con i partiti borghesi, Caprivi decide una drastica riduzione dei dazi sui cereali per consentire agli Stati europei la ripresa delle esportazioni verso la Germania e, come contropartita, l’importazione dei prodotti industriali tedeschi. Gli agrari reagiscono fondando nel 1893 la Lega degli agrari, un’organizzazione di massa che si poneva l’obiettivo di proteggere gli interessi dei proprietari terrieri dalle politiche liberiste del governo17.
La crisi dell’agricoltura prussiana, che si protrasse fino all’inizio della guerra, corrispondeva in realtà – e così fu interpretata da Weber – allo sgretolamento di un’intera compagine sociale. Il paesaggio delle campagne orientali veniva modificato radicalmente dall’introduzione di coltivazioni intensive per il mercato internazionale (come la barbabietola da zucchero), che sostituivano le tradizionali colture cerealicole, aumentando a dismisura il fabbisogno di lavoratori stagionali e favorendo l’utilizzazione di braccianti avventizi, pagati male e «accasermati» alla meglio, che si fermavano solo per il periodo del raccolto. I vecchi lavoratori agricoli tedeschi, intanto, lasciavano a migliaia i distretti rurali, migrando dapprima verso le Americhe e poi in direzione delle province e dei centri urbani più industrializzati (Berlino, Amburgo, Renania-Vestfalia). Il fenomeno raggiunse dimensioni di massa intorno alla metà degli anni Settanta, facendo della «penuria» di forza-lavoro agricola un tema centrale nel discorso pubblico dell’epoca e inducendo i proprietari delle regioni orientali a utilizzare, in sostituzione dei braccianti tedeschi emigrati, lavoratori provenienti dalle province polacche dell’est, dalla Polonia russa e dalla Galizia. Il «nomadismo» dei lavoratori condusse a una vera e propria alterazione nella composizione ‘etnica’ e ‘nazionale’ della forza-lavoro a tutto svantaggio dell’elemento tedesco, sollevando il problema della «Polonisierung des deutschen Ostens» che lega a doppio filo la questione agraria con quella nazionale e con quella, ancora più generale, del futuro della civiltà tedesca18.
Si manifesta qui un campo di tensione tra gli interessi economici dei proprietari terrieri e la «ragion di Stato» al cui interno le politiche di regolazione dei movimenti migratori si sarebbero iscritte fino alla guerra, con effetti di grande rilievo sull’insieme del mercato del lavoro prussiano e tedesco: l’«obbligo di legittimazione» per i migranti polacc...
Indice dei contenuti
- Introduzione di Furio Ferraresi e Sandro Mezzadra
- Nota ai testi
- Nota alla traduzione
- I. La condizione dei lavoratori agricoli nella Germania a est dell’Elba(1892)
- II. «Inchieste private» sulla condizione dei lavoratori agricoli(1892)
- III. La costituzione del lavoro rurale(1893)
- IV. I lavoratori agricoli tedeschi (1894)
- V. Tendenze di sviluppo nella condizione dei lavoratori agricoli nei territori a est dell’Elba(1894)
- VI. Contributi alla discussione sulla relazione di Karl Oldenberg: «Sulla Germania come Stato industriale» (1897)