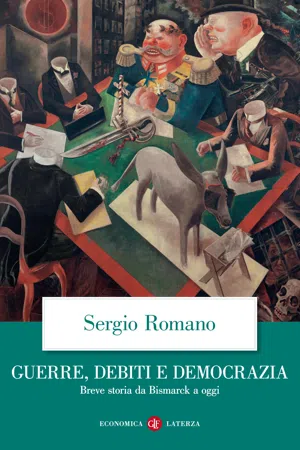Appendice II.
John Maynard Keynes.
Le conseguenze economiche della pace
capitolo vii: Rimedi
Il capitolo è tratto da: John Maynard Keynes, Le conseguenze economiche della pace, trad. it. di F. Salvatorelli, Adelphi, Milano 2007, pp. 201-33, ed è riprodotto per gentile concessione di Adelphi Edizioni.
Premessa al capitolo
John Maynard Keynes era consulente del ministro britannico del Tesoro quando decise di abbandonare la delegazione del suo Paese alla conferenza della pace in segno di protesta per le clausole economiche e finanziarie che gli Alleati volevano imporre alla Germania sconfitta. Si dedicò da allora per alcuni mesi a un saggio intitolato Le conseguenze economiche della pace, che apparve nel 1919. Il libro suscitò dibattiti e consensi, ma non modificò la politica dei governi alleati. La parte VIII del Trattato di Versailles (di cui il lettore trova il testo alle pagine precedenti) affidò a una Commissione per le riparazioni il compito di fissare la somma dovuta. Contemporaneamente fu deciso che «nel periodo compreso fra l’entrata in vigore del Trattato di pace ed il termine previsto per la conclusione dei lavori della Commissione delle riparazioni, la Germania avrebbe pagato agli Alleati l’equivalente di 20 miliardi di marchi oro, parte dei quali in natura, detraibili dal debito complessivo».
Nel gennaio 1921, poco dopo la pubblicazione del libro, una conferenza degli Alleati, a Parigi, decise che la Germania avrebbe pagato la somma di 226 miliardi su un periodo di quarantadue anni; ma aggiunse che 42 miliardi sarebbero stati pagati fra il 1921 e il 1932. Fu anche deciso che sul valore delle esportazioni tedesche sarebbe stato prelevato, per quarantadue anni, il 12%. Era accaduto esattamente ciò che Keynes aveva inutilmente cercato di evitare. In questa prospettiva, probabilmente, aveva deciso di dedicare l’ultimo capitolo, qui riprodotto, ai “rimedi”. Il suo libro è stato scritto in circostanze alquanto diverse da quelle attuali, ma molte osservazioni e analisi si adattano anche a un altro “dopoguerra”: quello che l’Europa sta attraversando dopo la crisi finanziaria del 2008.
Keynes era pessimista. Sperava che la Società delle Nazioni avrebbe promosso la riforma del Trattato di pace, ma non ignorava che la maggiore organizzazione internazionale sarebbe stata paralizzata dal diritto di veto dei suoi membri. La principale preoccupazione dell’economista britannico, in quel momento, era il destino di Russia, Turchia, Ungheria e Austria: Paesi minacciati dalla fame e dall’anarchia. Pensava che l’Europa per uscire dalla crisi avrebbe dovuto affrontare anzitutto almeno tre problemi. Il primo era quello del carbone e dell’acciaio. Era giusto che la Germania, con forniture eccezionali di carbone, indennizzasse la Francia per le distruzioni subite dalle sue miniere nei dipartimenti del Nord e del Pas-de-Calais. Ma non era giusto che venisse privata indefinitamente della sua maggiore risorsa naturale. Il secondo problema era quello delle nuove frontiere statali apparse sulla carta geografica dopo la disintegrazione dei grandi imperi. Che cosa sarebbe accaduto dell’economia europea se ogni Paese avesse applicato le proprie tariffe doganali? La risposta, secondo Keynes, era la creazione di una grande unione doganale di cui avrebbe dovuto fare parte, a suo giudizio, anche la Gran Bretagna. Il terzo problema era la inestricabile giungla dei debiti fra Alleati di cui ho già scritto. Keynes sperava che gli Stati Uniti avrebbero rinunciato al rimborso dei loro prestiti. «Le spese del Regno Unito per la guerra – scrisse – sono state tre volte quelle degli Stati Uniti o addirittura, se confrontiamo il potenziale finanziario dei due Paesi, sette o otto volte maggiori». Gli aiuti forniti dagli Stati Uniti ad alcune potenze europee per una guerra comune non potevano essere trattati alla stregua d’investimenti. Azzerare tutti i debiti, compresi quelli che molti Alleati avevano contratto con la Gran Bretagna, sarebbe stata la migliore delle soluzioni possibili. Ma pur dando prova di una certa flessibilità nel corso dei singoli negoziati con i loro debitori, questa non fu la linea a cui gli Stati Uniti decisero di attenersi.
Per fare fronte alle esigenze della ricostruzione esisteva, secondo Keynes, una soluzione molto più efficace di questo interminabile bisticcio fra debitori e creditori: un grande prestito internazionale a cui avrebbero dovuto partecipare anche gli Stati Uniti. Immaginava le obiezioni degli americani. Quale uso i singoli Stati europei avrebbero fatto della loro quota? Se ne sarebbero serviti per le loro meschine politiche nazionali? Ma Keynes era convinto che valesse la pena di correre il rischio. Avrebbe avuto ancora meno dubbi, probabilmente, se questo prestito fosse stato europeo, gestito dalla Commissione di Bruxelles, ripartito secondo i criteri che sono già in vigore per la ripartizione dei fondi europei e garantito dalla intera Unione. La Germania di Angela Merkel e Wolfgang Schäuble vedrebbe in una tale proposta la mutualizzazione del debito, bestia nera della Repubblica federale. Ma non sarebbe la mutualizzazione del debito, per l’appunto, un passo decisivo sulla via dell’integrazione?
S.R.
Le conseguenze economiche della pace
Capitolo VII: Rimedi
Non è facile mantenere una giusta visuale in cose di tanta mole. Ho criticato l’operato di Parigi, e ho dipinto a tinte fosche le condizioni e le prospettive dell’Europa. Questo è un aspetto della situazione, e risponde, credo, a verità. Ma in un fenomeno tanto complesso i pronostici non puntano tutti in una direzione; e possiamo commettere l’errore di aspettarci conseguenze troppo rapide e inevitabili da quelle che forse non sono tutte le cause in gioco. Il nerume stesso del panorama ci induce a dubitare della sua esattezza; la nostra immaginazione è mortificata più che stimolata da una narrazione troppo dolorosa, e la nostra mente si ritrae da quel che ci pare «troppo brutto per essere vero». Ma prima che il lettore si lasci influenzare da queste naturali riflessioni, e prima che io lo guidi, com’è intenzione di questo capitolo, verso miglioramenti e rimedi e alla scoperta di più felici tendenze, gli consiglio di ristabilire l’equilibrio del suo pensiero considerando due casi opposti: Inghilterra e Russia, dei quali l’uno può incoraggiare in lui un eccessivo ottimismo, ma l’altro dovrebbe ricordargli che le catastrofi sono sempre possibili, e che la società moderna non è immune da mali di gravità estrema.
Nei capitoli di questo libro non ho in generale avuto in mente la situazione o i problemi dell’Inghilterra. Nella mia narrazione, «Europa» va inteso generalmente come Europa continentale. L’Inghilterra è in uno stato di transizione, e ha seri problemi economici. Siamo forse alla vigilia di grandi cambiamenti nella sua struttura sociale e industriale. Alcuni di noi possono guardare con favore a queste prospettive, altri deplorarle. Ma si tratta di prospettive di natura affatto diversa da quelle che incombono sull’Europa. Non scorgo in Inghilterra la minima possibilità di catastrofi, né serie probabilità di un generale rivolgimento della società. La guerra ci ha impoveriti, ma non gravemente: direi che nel 1919 la ricchezza reale del Paese è almeno pari a quella che era nel 1900. La nostra bilancia commerciale è passiva, ma non tanto che il suo riequilibrio debba sconvolgere la nostra vita economica. Il nostro deficit di bilancio è cospicuo, ma non tale che un’azione politica ferma e prudente non possa sanarlo. La riduzione dell’orario di lavoro può avere diminuito un poco la nostra produttività. Ma è lecito sperare che questo sia un dato transitorio, e chi conosce il lavoratore britannico non può dubitare che se gli garba, e se è ragionevolmente contento e in sintonia con le sue condizioni di vita, egli possa produrre in una giornata lavorativa abbreviata almeno altrettanto che nel più lungo orario precedente. I problemi più gravi dell’Inghilterra sono stati esasperati dalla guerra, ma hanno origini più lontane. Le forze del XIX secolo hanno concluso il loro corso e sono esaurite. I motivi e gli ideali economici di quella generazione non ci soddisfano più: dobbiamo trovare vie nuove e rivivere il malaise e infine le doglie di una nuova nascita industriale. Questo è un elemento. L’altro è quello di cui ho parlato nel capitolo secondo: l’aumento del costo reale del cibo e la risposta decrescente della natura a ogni ulteriore aumento della popolazione del globo, una tendenza che non può non essere specialmente dannosa per la massima nazione industriale, e la più dipendente da importazioni alimentari.
Ma questi problemi secolari sono di un genere da cui nessuna età va esente. Di genere affatto diverso sono quelli che possono affliggere i popoli dell’Europa centrale. I lettori che avendo presenti soprattutto le condizioni britanniche a loro familiari tendono a indulgere all’ottimismo, e più ancora i lettori d’ambiente americano, devono volgere la mente alla Russia, alla Turchia, all’Ungheria, all’Austria, dove i mali più terribili che l’uomo può patire – fame, freddo, malattie, guerra, omicidi, anarchia – sono un’esperienza concreta e presente, se vogliono comprendere il carattere delle sciagure contro il cui ulteriore dilagare è sicuramente nostro dovere cercare rimedio, se esiste.
Che fare, dunque? Le proposte di questo capitolo sembreranno forse al lettore inadeguate. Ma la buona occasione si è persa a Parigi nei sei mesi seguiti all’armistizio, e niente di ciò che ora siamo in grado di fare può riparare al danno compiuto allora. Grandi disagi, grandi rischi per la società sono diventati inevitabili. Adesso non ci resta altro che riorientare, per quanto è in nostro potere, le fondamentali tendenze economiche che sono alla base degli eventi attuali, in modo da promuovere il ristabilimento della prosperità e dell’ordine, invece di aggravare sempre più il malessere.
Dobbiamo anzitutto evadere dall’atmosfera e dai metodi di Parigi. I demiurghi della Conferenza possono piegarsi al vento dell’opinione popolare, ma non ci porteranno mai fuori dai nostri guai. Non è da supporre che il Consiglio dei Quattro possa tornare sui propri passi, anche se volesse. La sostituzione degli attuali governi europei è perciò una premessa quasi indispensabile.
Propongo quindi, a quanti ritengono che la pace di Versailles non possa reggere, di esaminare un programma così articolato:
I. Revisione del Trattato.
II. Regolamento dei debiti interalleati.
III. Prestito internazionale e riforma monetaria.
IV. Rapporti dell’Europa centrale con la Russia.
I. Revisione del trattato
Esistono mezzi costituzionali per modificare il Trattato? Il presidente Wilson e il generale Smuts, convinti che la conclusione del patto o covenant della Società delle Nazioni valga più di gran parte degli elementi nocivi del resto del Trattato, ci hanno esortato a contare sulla Società per il graduale evolversi di una vita più sopportabile in Europa. «Ci sono sistemazioni territoriali che occorrerà rivedere – ha scritto il generale Smuts nella sua dichiarazione all’atto della firma ...