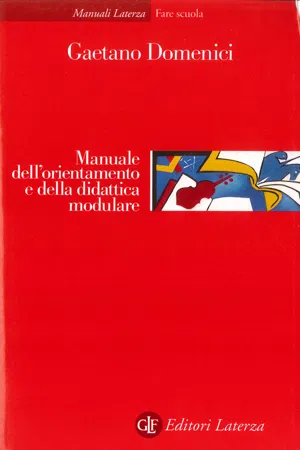1. Scuola e società complesse
1. Perché orientare ed orientarsi è sempre più difficile
Orientare ed orientarsi – intesi per ora e con buona approssimazione come interventi volti ad avviare rispettivamente altri o se stessi a scelte e decisioni, attività e simili, congruenti con i vincoli del contesto, in senso stretto e lato, e con gli interessi, le attitudini, il progetto di vita più o meno abbozzato dell’orientando – hanno rappresentato, fino a qualche anno fa, operazioni relativamente complesse, anche se delicate.
L’orientare e l’orientarsi oggi, nelle cosiddette società postindustriali, dei servizi e della conoscenza, sono diventate operazioni non solo più complesse e articolate, ma ancor più cariche di conseguenze per il singolo e per la collettività di quanto non lo fossero prima, tanto da imporsi ormai come ineludibili sia durante il periodo della formazione scolastica sequenziale sia, in forma di ri-orientamento, durante l’intero arco della vita lavorativa di ognuno. Non è per caso, infatti, che in quest’ultimo ventennio le più importanti leggi di riforma degli ordinamenti didattici scolastici e universitari, annunciate o compiute, abbiano previsto o contemplino lo svolgimento di attività di orientamento e di tutorato sempre più connesse al processo di formazione e che, finalmente, una loro netta integrazione sia prefigurata anche nella scuola primaria. Né accade per caso che in campo produttivo sia piuttosto diffusa la riqualificazione e quindi il ri-orientamento delle mansioni dei lavoratori così come peraltro prevedono molti degli interventi di reintegrazione nei processi di produzione di quanti per qualche ragione ne siano stati esclusi. Come vedremo, si è ormai imposta la necessità di una formazione continua, persino oltre l’arco della vita lavorativa di ognuno, etero, ma anche autodiretta, la quale presuppone e comporta un frequente ri-orientamento.
Addirittura, fino agli anni Cinquanta-Sessanta, anni nei quali il nuovo processo di industrializzazione del nostro paese ha richiesto un ampliamento della scolarità soprattutto di base per rispondere alle nuove esigenze produttive, l’orientamento risultava una questione assai circoscritta oppure un problema cui non occorreva porre mano.
A partire dall’unità d’Italia e fino a qualche decennio fa, gran parte dei destini individuali, di studio e di lavoro, venivano prefigurati con alta approssimazione dalla classe o categoria sociale di appartenenza. In questo periodo i sistemi scolastici di molti dei paesi industrializzati, aperti a tutti, ma non a tutti accessibili, contemplavano non a caso una precoce canalizzazione degli itinerari formativi. Generalmente, uno dei canali previsti serviva per la preparazione agli studi superiori e universitari e veniva frequentato da allievi appartenenti alle classi sociali superiori e dai talenti di quelle subalterne; gli altri canali, quasi sempre brevi, venivano offerti principalmente ad utenti delle classi meno abbienti, per la loro formazione (anzi educazione) di base e per l’addestramento a mansioni lavorative esecutive.
In Italia, nonostante l’unificazione della scuola media dell’obbligo sia avvenuta (anche se in ritardo rispetto a paesi omologhi) nel 1963, addirittura solo nel 1976 è stata superata quella canalizzazione precoce che, seppur in maniera meno vistosa con la media unitaria, continuava a praticarsi subito dopo l’elementare attraverso il sistema delle opzioni dell’insegnamento del latino o delle applicazioni tecniche che consentiva o meno l’iscrizione ai licei. Una scelta, perciò, compiuta molto tempo dopo la liberalizzazione degli accessi universitari a tutte le facoltà, avvenuta nel 1969 come concessione alle rivendicazioni libertarie ed egualitarie del Movimento studentesco (occorre tuttavia precisare che l’attitudine tutta italiana, della destra in generale, di ideare e organizzare scuole capaci di rispecchiare nella loro articolazione la composizione sociale della popolazione per perpetuarla è riaffiorata con i governi di centro-destra che agli inizi di questo secolo hanno prima abolito l’obbligo scolastico sostituendolo con un indecifrabile diritto-dovere di istruzione, poi rendendo – solo sulla carta – formalmente e culturalmente equivalenti istruzione e formazione professionale).
La cooptazione dei talenti delle classi subalterne, già collaudata con la scuola liberale del XIX secolo, non alterava il quadro generale della formazione scolastica, anzi ne giustificava la filosofia complessiva di sistema socialmente selettivo.
Peraltro la stabilità dei saperi e dei repertori di conoscenze acquisite durante gli anni della formazione familiare – per i molti che non potevano accedere alla scuola – e scolastica o universitaria per gli altri, assicurava a ciascun soggetto un patrimonio culturale utilizzabile per l’intero arco della propria vita lavorativa.
Si può ben comprendere, allora, come in una tale struttura socio-produttiva e scolastica l’orientamento rappresentasse, di fatto, un elemento marginale del sistema. Una volta determinata la possibilità di accesso alla scuola e/o all’indirizzo di studio, pochi fattori potevano alterare il prevedibile sbocco lavorativo o professionale in un quadro del mercato del lavoro peraltro abbastanza stabile.
I primi elementi di complicazione sono sorti con l’allargamento della base sociale dell’istruzione pubblica, quindi con l’assunzione da parte della scuola anche del ruolo – più presunto che reale – di strumento della mobilità sociale ascendente; con la progressiva richiesta dal mondo del lavoro di produttori con un più alto livello di istruzione; con la necessità di promuovere un innalzamento della qualità dell’istruzione anche nella scuola di massa.
La diversità interindividuale, sul piano cognitivo e motivazionale, degli allievi presenti nelle singole classi ha progressivamente posto nuove questioni organizzative alla formazione in generale, e in particolare alla didattica e all’orientamento, le cui risposte hanno cominciato a profilarsi solo qualche decennio fa.
A partire dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso, infine, gli scenari di riferimento si sono ulteriormente e repentinamente alterati, creando un disorientamento generale a causa della palese complessità assunta dal problema della formazione e dell’orientamento delle nuove generazioni.
Oggi sono anche altre variabili, oltre a quelle strettamente sociali, che incidono significativamente sulla determinazione dei destini individuali. In una società con tassi di scolarizzazione crescenti assumono infatti un particolare peso l’esperienza formativa del soggetto, la tipologia dei saperi posseduti, gli atteggiamenti cognitivi e non cognitivi verso nuovi universi di conoscenza, in ultima analisi la qualità dei processi e dei risultati di istruzione.
Le ragioni dell’incremento delle difficoltà e della complessità dei processi di orientamento, oltre che della loro necessità, in questa fase dello sviluppo storico del nostro paese, sono così numerose che risulterebbe davvero inutile una qualsiasi elencazione con pretese di completezza: esse mutano, peraltro, col mutare – pressoché continuo – del quadro socio-culturale di riferimento.
Talune ragioni, tuttavia, rivestono un carattere generale, ancorché peculiare, tale da non poter non interessare quanti direttamente o indirettamente si occupino di problemi formativi, scolastici e no, con allievi in età evolutiva o con adulti dentro o fuori il mercato del lavoro. Sono le stesse ragioni che a ben vedere rappresentano nel contempo le principali concause e i principali effetti della complessità delle cosiddette società postindustriali; della loro repentina e continua trasformazione; della incertezza delle loro linee «evolutive», quindi del disorientamento di chi in esse si trova a vivere. Tali ragioni sono, innanzi tutto, la crescita dei saperi e delle modalità del loro impiego nelle principali forme organizzative della vita sociale, culturale e produttiva; la connessa e progressiva diminuzione della stabilità d’impiego, durante la vita attiva, delle conoscenze acquisite nel periodo di formazione scolastica; la richiesta sempre maggiore di mutamento delle funzioni lavorative ed una parallela diminuzione della quantità di lavoro per la produzione di beni e servizi; l’alto costo, individuale e sociale, dello spreco delle intelligenze dovuto ad una scuola incapace di valorizzare interessi, attitudini e talenti individuali; l’aumento tanto dei legami di interdipendenza quanto dei fattori di concorrenza tra le economie dei paesi dell’intero pianeta e, quindi, la globalizzazione; infine, l’urgenza di garantire, soprattutto nelle cosiddette società dell’informazione e della conoscenza, una consapevole partecipazione alla vita democratica, una vera e propria cittadinanza attiva. Eventi, questi, che esigono una sempre più alta cultura diffusa dell’intera popolazione e una contemporanea valorizzazione delle diversità inter e intraindividuali, proprio quando, invece, si registra una sempre più bassa produttività quali-quantitativa dei sistemi formativi e un appiattimento delle competenze e dei saperi fatti acquisire.
2. Crescita dei saperi e conoscenze scolastiche
Fino a qualche decennio fa, il repertorio delle conoscenze e delle competenze acquisite tanto dai laureati quanto da chi aveva potuto frequentare solo alcuni anni della scuola di base o addirittura da chi, analfabeta, le aveva fatte proprie in ambiente di lavoro, poteva ben servire per svolgere con successo il proprio lavoro lungo tutto l’arco della vita produttiva. L’aggiornamento di quei repertori si rendeva necessario in casi davvero sporadici, ovvero non con una frequenza tale da imporre la questione come problema politico-culturale generale. Per far fronte alle novità emergenti, al professionista poteva bastare l’autoaggiornamento; al lavoratore esecutivo una breve fase di riaddestramento alle nuove mansioni.
La prima formazione risultava quindi cruciale nella determinazione delle funzioni di lavoro assunte e svolte socialmente.
D’altro canto la pur progressiva crescita dei saperi non trovava applicazioni immediate nei processi di produzione e di organizzazione del lavoro, così che i quadri di riferimento individuali e collettivi risultavano piuttosto stabili nel tempo.
La recente rivoluzione informatica e telematica – databile all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso – ha prodotto un mutamento radicale dell’intero scenario con effetti assai simili a quelli della prima rivoluzione industriale, sul piano generale; a quelli dell’avvento della scrittura e della stampa a caratteri mobili, sul piano più specificamente culturale. Risultato, e al tempo stesso effetto anch’essa di una nuova utilizzazione delle conoscenze accumulate e dei processi di produzione, ha esteso la sua influenza anche in campi della vita sociale e produttiva dei cosiddetti paesi industrialmente avanzati, che, a detta degli stessi specialisti di settore, sembravano poco permeabili al cambiamento.
Ormai, non v’è forma dell’attività produttiva e di servizio che, seppur in modo diverso, per essere svolta, non si trovi nella necessità di acquisire, disporre, trattare e trasmettere informazioni, sia per rendere competitivi i propri processi di produzione nonché i prodotti medesimi, materiali o immateriali che siano, sia per far diventare progressivamente migliori i servizi offerti.
Bisogna considerare che a partire dagli anni Cinquanta il numero dei ricercatori è cresciuto a livello planetario in forma quasi esponenziale, accelerando l’effetto autopropulsivo della scienza e della tecnologia, ulteriormente incrementato poi dai mezzi informatici e dalla circolazione delle idee e dei dati anche per via telematica, messi perciò a disposizione di ogni ricercatore in tempo reale. Ciò ha prodotto un incremento dei saperi scientifici e, induttivamente, anche, ma non solo, degli ambiti disciplinari affini oltre che delle applicazioni tecnologiche, tale da rendere via via nel tempo sempre meno stabili i saperi trasmessi dalla scuola.
L’orizzonte dei possibili impieghi di questi ultimi è venuto così sempre più a ridursi, producendo per un verso la necessità di revisionare strutturalmente i saperi tradizionalmente proposti in forma curricolare classica, per altro verso la diminuzione del peso complessivo della funzione formativa della scuola con la conseguente minore appetibilità della formazione scolastica intesa come uno dei più importanti mezzi della mobilità sociale e come strumento di facilitazione dell’ingresso nel mondo del lavoro. Peraltro, le nuove Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (tic), divenute ormai così pervasive da denotare e connotare l’ambiente in cui si sviluppano le prime esperienze del bambino di oggi, e Internet hanno fatto credere ai più, come vedremo, ad un inevitabile depotenziamento del ruolo formativo della scuola.
Anche il proliferare di corsi e itinerari di istruzione informale, para ed extrascolastici, talvolta solo apparentemente più rispondenti alle esigenze emergenti dal mondo del lavoro, ritenuti dai più come immediatamente spendibili, e perciò più attraenti, rappresenta una manifestazione ulteriore della perdita di centralità del ruolo formativo della scuola nell’immaginario collettivo, della interpretazione del sistema scolastico come inadeguato alle emergenti richieste formative della società.
Certo, non vi è ormai azienda medio-grande che non assicuri una formazione specifica ai neoassunti e un adeguamento delle competenze di chi già in esse vi lavora attraverso brevi corsi di qualificazione e riqualificazione professionale. È senz’altro vero, ancora, che proprio in forza della crescita esponenziale dei saperi, il mancato aggiornamento per soli pochi anni delle competenze in settori conoscitivi di frontiera produca un vero e proprio analfabetismo di ritorno; che a distanza di poco tempo dal conseguimento di un qualsiasi titolo di studio l’abbattimento delle conoscenze acquisite risulti pressoché equivalente a tre-quattro anni di formazione ricevuta; che l’educazione non solo ricorrente ma addirittura continua, come s’usa dire oggi, costituisca un elemento imprescindibile dell’attuale condizione esistenziale. Ma è anche vero...