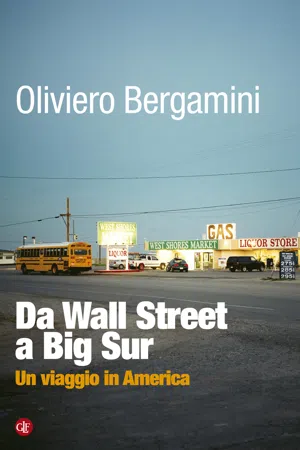1. Wall Street
L’occhio impazzito del ciclone
Ogni tanto nel canyon di grattacieli arrivano soffi di vento carichi dell’odore dell’oceano che palpita nella baia, poco lontano; e nella mente affiora l’immagine dei velieri che fecero la fortuna della città-porto di New York. Soffi che accarezzano la facciata da tempio greco fuori scala, dove campeggia una bandiera americana enorme e vivida, divisa in due dall’ombra dei palazzi vicini. Il frontone è imponente, ma la porta da cui passano frettolosi gli operatori è piccola, senza pretese; se non la nobilitassero un metal detector e un paio di poliziotti annoiati, se la bandiera non scintillasse quasi artificiale nella luce ariosa delle belle giornate, sarebbe difficile anche solo supporre che qui si forgia una parte importante dei destini del mondo. Qui, nella Borsa di New York, concentrazione di potere economico e finanziario ancora senza pari.
Nel Seicento era solo un viottolo di campagna costeggiato da un muro di pietre e pali di legno, costruito a difesa della colonia fondata da laboriosi olandesi sulla punta dell’«isola delle colline», ovvero, in lingua indigena, «Manhattan». Oggi Wall Street (la «strada del muro») taglia un labirinto urbano quasi cubista, non molto larga né luminosa. Eppure emana un fascino strano, come trasudasse l’energia della ricchezza che continuamente viene creata e distrutta in un ciclo immateriale e poderoso che propaga ovunque i suoi effetti. In una sorta di omaggio a una divinità ammirata e temuta, ogni giorno migliaia di turisti arrivano fin qui, indugiano quasi ipnotizzati, e alla fine si fanno fotografare davanti alla grande facciata simil-greca, con un incerto sorriso.
Celebrata ed esecrata da infiniti libri e film, Wall Street è cuore e simbolo del capitalismo americano, fonte di ricchezza, ma anche di ingiustizia e corruzione morale, nemica dell’ideale democratico che giace all’origine degli Stati Uniti. L’espressione «Wall Street», naturalmente, non indica solo la Borsa di New York, ma il complesso di istituti finanziari e grandi banche che hanno sede a Midtown, nella parte centrale di Manhattan, o in altre meno celebri strade di quel Financial District dominato fino al 2001 dalle Torri Gemelle.
Nel 2010 il «New York Times» ha rivelato che il primo mercoledì di ogni mese nove persone si riuniscono in un grattacielo di Midtown. Sono i rappresentanti di nove delle più importanti banche del mondo: JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Deutsche Bank, UBS, Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, Bank of America e Citigroup. Scopo delle riunioni è proteggere l’interesse di questi istituti nel mercato dei derivati, il più controverso e remunerativo dei mercati finanziari. Un consesso semi-segreto di super-banchieri è una vera festa per gli amanti delle teorie cospirazioniste: quale migliore prova del fatto che ristrette élites occulte tirano i fili della politica, dell’economia e persino della storia, all’insaputa delle masse?
In effetti la materia in cui il «New York Times» ha affondato la lama della sua inchiesta è inquietante. I derivati sono prodotti finanziari esoterici, praticamente incomprensibili per le persone comuni. In sostanza, sono titoli che rappresentano scommesse sul valore futuro di altri titoli, indici, valute, e che vengono usati per complesse, gigantesche operazioni di compravendita e di copertura di rischi. Nonostante la sua quasi totale opacità, quello dei derivati è diventato oggi il più remunerativo tra tutti i business finanziari; più dei prestiti a interesse, più delle consulenze per fusioni e acquisizioni societarie. Nelle loro riunioni mensili con vista su Manhattan i nove grandi banchieri collaborano per tener fuori da questo business altri istituti di credito e al tempo stesso far sì che le norme che lo disciplinano restino il più possibile deboli e vaghe. Oggi i quattro quinti dei profitti dei maggiori istituti di credito americani provengono non dalle tradizionali attività di credito ma dalla speculazione finanziaria. Proprio quella speculazione che tra il 2007 e il 2009 ha innescato la crisi che ha messo alle corde l’Occidente.
Nel suo rapporto finale, la Commissione del Congresso creata per ricostruire le cause del crollo borsistico del 2008 fotografa quasi con incredulità il circo dell’azzardo in cui Wall Street si è trasformata negli anni 2000. «Il sistema finanziario che abbiamo esaminato assomiglia ben poco a quello della generazione dei nostri genitori», scrivono con malcelata nostalgia i commissari. Negli ultimi trent’anni i mercati finanziari sono diventati globali, la tecnologia ha stravolto la velocità e la complessità degli strumenti e delle transazioni, le operazioni di borsa sono diventate accessibili a costi ridotti. E il settore finanziario è diventato una forza dominante dell’economia. Il salto cruciale è avvenuto tra il 1978 e il 2007, quando il valore complessivo dell’industria finanziaria è passato da 3.000 a 36.000 miliardi di dollari, raddoppiando la sua quota di incidenza sul Pil Usa. Tra il 1980 e il 2006 i profitti del settore erano passati dal 15% al 27% dei profitti totali delle corporations statunitensi; nel 2008 sono arrivati al 41%!
Da privati relativamente prudenti gli investitori di Wall Street si sono trasformati in grandi società per azioni quotate in borsa, inclini a rischi sempre maggiori e con potere sempre più grande. Nel 2005 le dieci maggiori banche commerciali detenevano il 55% di tutti i titoli del mercato. Oggi questa quota è ancora più alta.
Tradizionalmente si usa distinguere tra «economia reale» (la sfera dell’industria, dei servizi, della produzione di beni «concreti») ed «economia finanziaria» (l’insieme delle operazioni borsistiche e finanziarie). La seconda, in teoria, dovrebbe servire come strumento per raccogliere, gestire e distribuire capitali necessari alla prima. In realtà le due sfere operano in base a dinamiche ampiamente indipendenti e, a partire dagli anni ’70, la divaricazione è diventata quasi totale. Gli Stati occidentali si sono affidati sempre più alla finanza per produrre ricchezza attraverso la moltiplicazione a catena dei rendimenti, ed essa è diventata un settore praticamente autonomo; da subordinato alla produzione «reale» è passato ad esserne «dominus». Questa «finanziarizzazione», con epicentro negli Usa, ha stravolto le economie avanzate di tutto il mondo, producendo quello che Fabrizio Maronta ha definito «capovolgimento del nesso tra reddito da lavoro e speculazione». Nel decisivo periodo tra il 1980 e il 2007 il Pil mondiale (l’economia reale) è cresciuto da 10.000 miliardi di dollari a oltre 55.000; il valore degli «attivi finanziari» è passato invece da 12.000 a 195.000 miliardi, una crescita cinque volte superiore. Il «big bang» della finanza, in particolare, è avvenuto negli anni ’90. Oggi, secondo alcune stime, il Pil mondiale è calcolato tra i 65.000 e i 70.000 miliardi di dollari, ma l’insieme dei titoli finanziari circolanti nel mondo vale circa dieci volte tanto: 700.000 miliardi di dollari. Secondo altre stime, oggi per ogni dollaro di prodotto globale dell’economia reale ce ne sono addirittura 14 di finanza: 63.000 miliardi contro 851.000 miliardi. E di questi ultimi solo circa 250.000 sono di attività finanziarie «tradizionali», mentre la maggior parte, oltre 600.000 miliardi, sono derivati, attività finanziarie – come si è detto – per nulla trasparenti, e quasi totalmente non regolamentate. I soli derivati valgono 14 volte la capitalizzazione complessiva di tutte le Borse del mondo. Cifre quasi impossibili da immaginare. Denaro virtuale che «se precipitasse tutto dal cielo sulla terra non troverebbe di fronte a sé una quantità altrettanto grande di merci da comprare», ha scritto Guido Viale, ma che rappresenta una forza d’urto potenzialmente sconvolgente per i bilanci pubblici e le economie.
Non è accaduto per caso. Dagli anni ’80 in poi la politica neoliberista innescata dalle «rivoluzioni conservatrici» di Ronald Reagan e Margaret Thatcher ha prodotto una quasi totale «deregulation» del settore. Abolendo ogni restrizione sulle diverse tipologie di attività finanziaria, praticamente azzerando gli obblighi di correlazione tra capitali effettivi delle società e volume degli scambi, ha fatto sprigionare in pochi anni un mercato vertiginoso e ad altissimo rischio, caratterizzato dal parossistico ricorso al leverage, cioè l’uso di acquistare enormi volumi di titoli avendo a disposizione solo una frazione del denaro necessario, confidando semplicemente nella possibilità di rivenderli con profitto prima di doverli effettivamente pagare, in tempi rapidissimi. «Le cinque maggiori banche di investimento, Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch e Morgan Stanley», scrive ancora la Commissione, «operavano con capitali estremamente esigui... I loro rapporti di leverage erano di 40 a 1, il che significava che per ogni 40 $ di titoli c’era solo 1 $ di capitale per coprire le eventuali perdite. Meno del 3% di calo del valore del patrimonio finanziario poteva cancellare una società». Ancora più alto era il rapporto praticato dalle semipubbliche agenzie di concessione mutui Fannie Mae e Freddie Mac, che nel 2007 raggiunsero una «leverage ratio» di 75 a 1. Per di più, gran parte di queste operazioni erano a tempo brevissimo. «Ad esempio, alla fine del 2007, Bear Stearns aveva 11,8 miliardi di dollari di risorse proprie (‘equity’) e 383,6 miliardi di dollari di esposizione (‘liabilities’) e prendeva a prestito fino a 70 miliardi di dollari sul mercato giorno-su-giorno (‘overnight market’)», scrive la Commissione. «Era come se una piccola impresa avesse un capitale di 50.000 dollari e 1,6 milioni di dollari di esposizione e dovesse restituirne quasi 300.000 ogni giorno».
Nei giorni più affollati la coda per i biglietti dura ore, e si sale su ascensori stipati, ma la balconata sulla sommità dell’Empire State Building riserva una vista davvero emozionante sui grattacieli di Midtown Manhattan e del Financial District; con un giro di sguardo si può abbracciare gran parte dei luoghi dove il potere della finanza ha origine, sorta di gigantesca Stonehenge di una relazione molto prosaica, quella del denaro. Basta spingere lo sguardo al di là dell’Hudson, però, per scorgere in lontananza le distese di abitazioni del New Jersey suburbano; e il legame tra due mondi così diversi alla vista, in realtà, è strettissimo. Negli Usa, e non solo, il vorticoso giro di titoli finanziari si è intrecciato con il mercato immobiliare e il business dei mutui. Dagli anni ’90 in poi la crescita apparentemente senza fine dei prezzi delle case (15-20% all’anno e oltre), unita a bassi tassi di interesse, stimolò gli americani ad accollarsi mutui sempre più gravosi, anche ben al di là dei loro mezzi. Uno su dieci era del genere «option arm», con rate iniziali bassissime, ma crescenti nel tempo. Tra il 2001 e il 2007 la somma media di mutuo ipotecario per famiglia negli Stati Uniti crebbe da 91.500 dollari a 149.500 (+63%), mentre i salari rimanevano sostanzialmente fermi. Mutui concessi senza garanzie, pur di far lievitare il giro d’affari; mutui che le banche sapevano sarebbero diventati capestri per chi li contraeva. «Predatory lending», «prestiti predatori», mentre i mutui-spazzatura diventavano con sublime eufemismo «subprime loans» («al di sotto della prima qualità»). Anche le stesse società d’investimento partecipavano all’euforia immobiliare. La Lehman Brothers nel 2007 possedeva 111 miliardi di titoli basati su immobili commerciali e residenziali, il doppio rispetto ad appena due anni prima, e quattro volte le sue risorse di altro genere.
Così accadde il miracolo. Usando i crediti dei mutui come garanzia di obbligazioni emesse sul mercato, le banche trasformarono «magicamente» dei passivi (i prestiti concessi e non ancora restituiti) in attivi (i titoli), che nella spirale vorticosa degli scambi acquistavano valori sempre più alti e al tempo stesso «vuoti» di contenuto economico reale.
I meccanismi del crack del 2008 sono ormai noti. Fermatasi la corsa del mercato immobiliare, il veleno dei «subprime loans» scatenò i suoi effetti letali. I prezzi dei titoli precipitarono, trascinando in basso quelli delle azioni dei grandi istituti finanziari. L’indice Dow Jones conobbe il peggior crollo dal 1929, nel settembre 2008 la grande banca d’investimenti Lehman Brothers fallì clamorosamente, altri grandi istituti arrivarono sull’orlo del collasso. Improvvisamente sembrò possibile che tutto il sistema bancario Usa si disintegrasse; con rischi incalcolabili per l’intero capitalismo americano.
In un clima semi-apocalittico Barack Obama scelse di salvare Wall Street. Ispirato da Timothy Geithner, già capo della ripartizione newyorchese della Federal Reserve, fortemente legato a Goldman Sachs, nazionalizzò di fatto i grandi istituti di credito già semi-pubblici come Aig, Fannie Mae e Freddie Mac, al prezzo di 170 miliardi di dollari, e destinò 700 miliardi di dollari alla ricopertura dei buchi di bilancio delle banche d’affari, che grazie a questo poderoso salvagente a carico dei contribuenti riuscirono a sopravvivere. E dal 2009 ripresero a macinare profitti, sostanzialmente con gli stessi meccanismi di prima.
Dopo la crisi che ha spaventato il mondo, Barack Obama ha provato (senza troppa decisione) a imbrigliare i colossi della finanza. Ma non ci è veramente riuscito. La riforma finanziaria che ha firmato nel 2010 è forse – come lui stesso l’ha definita – «la più dura dopo quella introdotta a seguito della Grande Depressione». I contenuti non sono disprezzabili. Il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, votato dalla maggioranza democratica, conferisce alla Federal Reserve maggiori poteri e obblighi di controllo su banche e istituti finanziari, assegna al Congresso la facoltà di ispezionare i libri contabili della stessa Fed (novità storica), istituisce un’autorità di protezione e garanzia per i risparmiatori, fissa condizioni e regole più stringenti per gli scambi borsistici ed extraborsistici. Ma nonostante le strida dei Repubblicani che la accusano di strangolare la finanza americana con i suoi lacci e lacciuoli, la legge non comprende l’unica misura davvero in grado di azzerare il rischio di un nuovo disastroso crack; una netta, rigorosa separazione tra attività di credito (e assicurative) da un lato, e mera speculazione finanziaria dall’altro.
Questa separazione era esistita in passato, ma era stata gradualmente eliminata dall’ondata di deregulation avviata nei reaganiani anni ’80, proseguita nei clintoniani ’90, e culminata nel 1999 con il Gramm-Leach-Bliley Act, la cruciale abolizione del Glass-Steagall Act (che, varato nel 1933, nel pieno della Grande Depressione, imponeva la distinzione tra banche d’affari e d’investimento), e nel 2000 con il Commodity Futures Modernization Act, che dava via libera alla fusione tra banche commerciali, banche di investimento e compagnie assicurative, abolendo di fatto qualsiasi controllo pubblico sui mercati finanziari, e in particolare quello dei derivati. Fu così che Wall Street si tramutò definitivamente in una colossale sala d’azzardo, con banche, assicurazioni, fondi pensioni immersi in operazioni ad alto rischio, con titoli sempre più sofisticati e slegati da concreti beni «sottostanti».
La battaglia per la riforma finanziaria si è concentrata su due misure cruciali per stroncare questo stato di cose. La prima, la cosiddetta Volcker rule, se pienamente applicata, avrebbe imposto una separazione tra attività di credito e speculative, e in particolare vietato alle grandi banche di esercitare il cosiddetto «proprietary trading» (la speculazione sui mercati per proprio interesse diretto, con l’effetto – ad esempio – di scommettere al ribasso in veste di speculatori su titoli di credito «spazzatura» che in veste di banche commerciali avevano venduto «come buoni» ad altri clienti). La seconda, la cosiddetta Lincoln rule, avrebbe costretto le banche ad affidare le proprie attività sul mercato dei derivati a società distinte, oppure, in alternativa, a rinunciare a una serie di vantaggiose garanzie della Federal Reserve.
Tra la primavera e l’estate del 2010 i senatori democratici Carl Levin del Michigan e Jeff Merkley dell’Oregon hanno cercato a più riprese di introdurre una versione robusta della Volcker rule nel progetto di riforma del sistema finanziario che si stava discutendo, sfruttando ogni passaggio dell’iter congressuale e ogni meandro del regolamento, ma hanno finito con l’essere sconfitti da abili contro-manovre parlamentari che hanno apportato al provvedimento modifiche tecniche tali da privare la Volcker rule di gran parte della sua efficacia effettiva.
Ancora più dura è stata la resistenza alla Lincoln rule. Sostenendo che le banche devono poter competere con i fondi di investimento più speculativi, una coalizione che andava dal potente presidente della Commissione Bancaria del Senato Chris Dodd allo stesso Dipartimento del Tesoro, passando per decine di parlamentari repubblicani e democratici, ne ha lasciato intatto solo l’involucro, adottandola con tante eccezioni che di fatto la quasi totalità dei derivati ne risulta esente. A partire da Dodd, noto campione degli interessi di Wall Street a Washington, la quasi totalità dei parlamentari che hanno partecipato a questa castrazione della riforma finanziaria aveva ricevuto cospicui contributi elettorali da banche e società di credito. Nulla di nuovo; secondo OpenSecrets.org l’industria finanziaria Usa nel suo complesso, tra il 1990 e il 2010, ha investito 2,3 miliardi di dollari in contributi elettorali; più di sanità, energia, difesa, agricoltura e industria messe insieme. Non è un caso che la Committee on Financial Services della Camera abbia ben 61 membri.
Sul fronte giudiziario il governo ha attaccato con maggiore decisione. Il 2 settembre del 2011 la Federal Housing Finance Agency ha avviato cause legali nei confronti di 17 istituti di credito, tra cui Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup ed altre, accusandole di aver venduto in modo truffaldino a Fannie Mae e Freddie Mac ben 20...