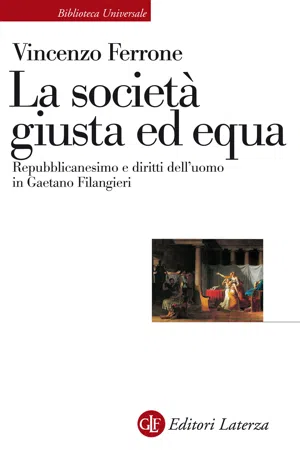
eBook - ePub
La società giusta ed equa
Repubblicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri
- 384 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
La società giusta ed equa
Repubblicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri
Informazioni su questo libro
Attraverso quali percorsi nacquero e si svilupparono in Italia il linguaggio dei diritti dell'uomo, il repubblicanesimo dei moderni e il costituzionalismo illuministico? Esiste una relazione tra la cultura politica del tardo Illuminismo e la genesi della tradizione democratica e repubblicana italiana? La politica del XVIII secolo ebbe la sua sintesi più alta nella Scienza della Legislazione di Gaetano Filangieri, un clamoroso best seller tradotto nelle principali lingue e ripetutamente ristampato.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a La società giusta ed equa di Vincenzo Ferrone in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Filosofia e Storia moderna. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
FilosofiaCategoria
Storia modernaCapitolo settimo
Patria o nazione?
Il patriottismo repubblicano e costituzionale
degli illuministi italiani
Virtù nella repubblica è l’amore della patria e dell’eguaglianza. Non è una virtù morale, né una virtù cristiana, è la virtù politica; ed è la molla che fa muovere il governo repubblicano [...]. È nel governo repubblicano che si ha bisogno di tutta la potenza dell’educazione.
Montesquieu, L’esprit des lois (1748)
Io chiamo dunque repubblica qualunque stato retto dalle leggi, sotto qualunque forma di amministrazione possa presentarsi, poiché solo in questo caso l’interesse pubblico governa e la cosa pubblica ha un suo peso. Ogni governo legittimo è repubblicano.
Rousseau, Contrat social (1762)
V’ha patria dove
sol uno vuole, e l’obbediscon tutti?
Alfieri, Virginia (1783) a. III, sc. II
Che cosa vuol dire essere un pensatore repubblicano nel secolo XVIII?
La conoscenza degli sviluppi della tradizione repubblicana nella storia politica dell’Illuminismo non ha fatto grandi passi in avanti in questi ultimi decenni1. Paradossalmente, all’avanzamento della ricerca non ha probabilmente giovato la recente esplosione d’interesse verso questi temi da parte dei filosofi e degli scienziati della politica, i quali hanno finito con il privilegiare nei loro libri una sorta di repubblicanesimo immaginario, svincolato dal contesto, fatto di arbitrarie ricostruzioni metastoriche la cui natura paradigmatica sconta programmaticamente larghe concessioni all’anacronismo: il vero peccato mortale dello storico di professione. Per dirla tutta, e con franchezza, le grandi opere di John Pocock e di Quentin Skinner2, la cui importanza resta comunque fuori discussione, hanno finito con l’orientare non sempre positivamente le indagini, sia da parte di epigoni meno attrezzati dei maestri sia da parte di storici di altre discipline perennemente a corto d’idee. In prima battuta, per comprendere le linee direttrici, i caratteri originali e le peculiarità del repubblicanesimo nel Settecento siamo infatti costretti a ricorrere ancora oggi alle Trevelyan Lectures tenute da Franco Venturi a Cambridge nel 1969 e pubblicate con il titolo Utopia e riforma nell’Illuminismo. In quelle pagine si prendeva atto del definitivo superamento, agli inizi del XVIII secolo, del modello repubblicano come realtà politica e istituzionale di fronte allo strapotere delle grandi monarchie assolutiste. Dopo un secolo di guerre e di rivoluzioni di ogni tipo in cui il confronto tra le due forme di governo si era sempre risolto, armi in pugno, a favore delle monarchie, la progressiva marginalizzazione nel contesto internazionale delle Province Unite, di Venezia, di Genova (bombardata e umiliata nel 1684 dalle navi di Luigi XIV), pareva dare ragione a quanti, come Montesquieu, consideravano ormai decisa per sempre la sfida tra monarchia e repubblica con la soluzione trovata in Inghilterra, nel corso del Seicento, a favore di una monarchia costituzionale. Quella soluzione, che rilanciava la formula istituzionale del governo misto, la distribuzione dei poteri, e proclamava solennemente la tutela dei diritti degli inglesi attraverso il Bill of Rights, aveva dato del resto una prima convincente e concreta risposta al problema della libertà di fronte all’assolutismo nelle moderne società commerciali: la vera grande questione politica, che stava tanto a cuore all’illuminista francese e, più in generale, a molti pensatori politici dell’epoca. A partire da quel momento il repubblicanesimo, quello autentico degli antichi, sembrava esser stato sconfitto per sempre, relegato nelle polverose soffitte della storia proprio perché si era rivelato inadeguato a risolvere il problema decisivo della libertà.
Riferendosi alle due forme di governo repubblicano apparse nella storia, Montesquieu sentenziava in tal senso: «La democrazia e l’aristocrazia non sono stati liberi per loro natura. La libertà politica non si trova che nei governi moderati»3, gli unici governi che, praticando la distribuzione dei poteri e riconoscendo il principio di legalità, garantivano concretamente la libertà personale. Nella «maggior parte dei regni d’Europa» le monarchie avevano vinto la battaglia contro le repubbliche, seguendo fedelmente proprio questa strada costituzionale. «Gli antichi – precisava Montesquieu delineando un paradigma interpretativo che verrà approfondito e reso celebre da Constant – non conoscevano la distribuzione dei tre poteri nel governo di uno solo, non potevano farsi un’idea giusta della monarchia»4; così come in tempi più recenti nelle «repubbliche italiane dove questi poteri sono riuniti [nelle mani di poche famiglie] la libertà è minore»5. Anche in Francia, dopo gli eccessi dispotici di Luigi XIV, l’auspicabile ripristino di una «monarchia temperata» fondata sulla secolare costituzione naturale del regno che attribuiva ai corpi intermedi, alla nobiltà ereditaria e ai signori feudali la storica funzione di assicurare la libertà, limitando il potere del sovrano, secondo lo schema del «governo gotico» dei popoli germani, rendeva del tutto anacronistico il ricorso a forme istituzionali di tipo repubblicano. Politicamente, insomma, il repubblicanesimo non serviva più, diventava di fatto un progetto politico inattuale e comunque perdente di fronte alle dure repliche della storia. Il suo certificato di morte venne stilato in pagine destinate a rimanere famose proprio nell’Esprit des lois del 1748, quando Montesquieu dichiarò l’avvenuto declino della funzione della virtù, sostituito dall’onore come principio di governo, nelle moderne monarchie temperate chiamate a governare società oramai condizionate soprattutto dai commerci, dalla produzione e dal consumo piuttosto che dalla guerra. In queste monarchie, egli precisava,
la politica fa compiere le grandi imprese adoperando il meno possibile la virtù [...]. Lo Stato vive indipendentemente dall’amor di patria, dal desiderio di vera gloria, dalla rinuncia di se stessi, dal sacrificio dei propri interessi più cari, da tutte quelle eroiche virtù che troviamo tra gli antichi e delle quali abbiamo solamente udito parlare. Le leggi prendono il posto di queste virtù, ormai inutili: lo Stato ne dispensa [...]. La virtù non è la molla di questo governo! Certo non ne è esclusa: ma non ne è la molla6.
Benché ancora ricca di suggestioni la politica della virtù repubblicana, il primato dello spirito pubblico passava in secondo piano in un’epoca in cui regnava incontrastato l’esprit de commerce. E ciò nondimeno, a ben vedere, come tutti i capolavori ricchi di suggestioni e dalla struttura retorica ed espositiva particolarmente complessa, anche l’Esprit des lois si prestava a equivoci e a molteplici chiavi di lettura. Se da un lato quel libro certificava di fatto la morte del repubblicanesimo degli antichi, sottolineandone l’anacronismo come forma di governo alternativo alla monarchia, allo stesso tempo però, separando la forma di governo dal principio motore del repubblicanesimo, individuato nella passione per la virtù, ne tracciava uno straordinario quadro sintetico, un idealtipo affascinante, denso di particolari inediti, di riflessioni critiche mai prima formulate sul tema dell’educazione, dell’economia, della giustizia7. Indicando la natura profonda, l’esprit autentico del repubblicanesimo nell’autogoverno, nel primato delle virtù politiche come mentalità, costume e impegno morale dei singoli a favore della collettività, Montesquieu consegnava più o meno consapevolmente ai suoi contemporanei qualcosa di assai simile a un manuale del perfetto repubblicano. Nel collocare all’interno delle pagine dell’Esprit des lois quello che divenne l’arsenale del pensiero repubblicano nel corso dell’intero XVIII secolo, Montesquieu faceva però anche delle precise scelte di campo destinate a influire profondamente nei dibattiti successivi nell’ambito della cultura illuministica. L’elogio e l’ammirazione verso il mondo della polis greca e la Roma di Cicerone erano infatti accompagnati dalla severa critica delle arcaiche repubbliche aristocratiche che ancora sopravvivevano a se stesse nell’Europa del Sei-Settecento. Senza mai accennare alla gloriosa esperienza comunale di autogoverno e di umanesimo civico delle città italiane nel medioevo e nell’età rinascimentale, alle oligarchie di Venezia e di Genova ancora in vita, parole sprezzanti erano riservate al conservatorismo, alla palese mancanza di libertà e alla corruzione che affliggevano quei patriziati invecchiati, sclerotici, privi di prospettive, prigionieri della loro gloriosa storia e incapaci di rinnovarsi e di aprirsi alle nuove esigenze. Meno negativi erano certamente i giudizi verso le cosiddette repubbliche federate dell’Olanda, della Svizzera e dell’Impero germanico. Restava malgrado ciò sullo sfondo, anche in questo caso, la constatazione di quanto fosse ormai distante il vitale e prospero mondo del repubblicanesimo degli antichi rispetto alle moderne repubbliche aristocratiche condannate, per la loro natura intrinseca, all’immobilismo per sopravvivere.
Il fatto è che lo schema elaborato da Montesquieu, oltre a rispecchiare fedelmente la realtà storica del momento, prendeva in qualche modo atto anche della nascita in Inghilterra dell’ennesima metamorfosi del repubblicanesimo classico: una metamorfosi ancora una volta fondata principalmente sul mito di Cicerone, sul rilancio di testi di scrittori latini come Livio e Sallustio, di esempi e suggestioni provenienti, nella maggioranza dei casi, dall’antica Roma, utilizzati soprattutto, e allo stesso tempo, sia come critica genericamente libertaria e anti-assolutistica, sia come franca denuncia della progressiva sparizione delle virtù civiche nelle moderne società commerciali, dove iniziava a regnare indiscusso il primato dell’interesse individuale su quello collettivo. In tal senso, nata con la rivoluzione inglese a metà del Seicento, questa ennesima variante della tradizione repubblicana aveva preso corpo, in un primo momento, sotto forma di «neo-roman theory of free States» particolarmente attenta a definire la natura della «civil liberty» di fronte alla monarchia8, per poi allargarsi – anche a causa del rapido consolidamento del regime monarchico-costituzionale degli Hannover – alle esigenze di una critica efficace contro le degenerazioni dei costumi e la corruzione che stavano accompagnando la trasformazione della società inglese in una moderna economia di mercato. Eredi diretti di Machiavelli, di Sydney e di quel James Harrington che avrebbe amato vedere in Londra la «new Rome in the west»9, i Freethinkers inglesi dell’età augustea elaborarono nei primi decenni del secolo una cultura e un orizzonte ideale di tipo repubblicano capace di denunciare ogni forma di dispotismo, di tirannia e di concessioni all’assolutismo, rivendicando le ragioni della libertà politica accanto a quelle della libertà filosofica, insistendo sulla tolleranza religiosa e sulla lotta della ragione alla superstizione con toni e accenti già di stampo illuministico. Nel fronte composito di questi nuovi commonwealthmen che andava da Toland a Shaftesbury, a John Trenchard, a Matthew Tindal, a Anthony Collins, alcuni preferirono spendersi – e lo fecero con un certo successo – per accreditare in Europa l’immagine suggestiva di una monarchia costituzionale inglese che al di là della forma di governo rispettava nella sostanza i principi repubblicani, avendo rilanciato quel governo misto così caro a Polibio, a Cicerone, a Machiavelli e a Sidney; altri preferirono piuttosto insistere sulla propaganda di un repubblicanesimo degli antichi come filosofia morale, denuncia della corruzione, appello alla pratica delle virtù civiche e della libertas philosophandi, all’individuazione di un governo patriottico schiuso a una più larga partecipazione popolare: il celebre Discourse of Freethinking del 1714 di Anthony Collins rappresentò davvero una sintesi efficace e il manifesto principale delle idee di quel mondo composito e contraddittorio accomunato comunque dall’odio verso il dispotismo dei re.
A metà del secolo, anche grazie a Montesquieu che ben conosceva quel fecondo dibattito contro il cosiddetto governo della corruzione di Walpole attraverso le opere di Swift, del «Craftsman» del suo amico Bolingbroke, e, soprattutto, per aver soggiornato in Inghilterra nel 1729-30, il tema della necessità di distinguere quando si parlava di repubblicanesimo tra la forma del governo e i principi che lo facevano «muovere» e lo caratterizzavano cominciò a diventare un luogo co...
Indice dei contenuti
- Premessa. Un mondo da riscoprire:le radici illuministiche della cultura democraticae repubblicana dell’Italia contemporanea
- Parte prima La nuova politica «ex parte civium»
- Capitolo primo L’Illuminismo e la critica politicadella «scientia juris»
- Capitolo secondo La critica del modello costituzionale britannico:la rivoluzione americana come laboratorio politico
- Capitolo terzo Contro Montesquieu e il costituzionalismo cetuale.La denuncia del «mostro feudale»e della «monarchia temperata»
- Capitolo quarto La costruzione del nuovo costituzionalismo:sociabilità massonica ed eguaglianza
- Capitolo quinto La scuola giusnaturalistica napoletanae la fondazione storica e filosofica dei diritti dell’uomo
- Capitolo sesto Oltre la ragion di Stato: le basi morali e religiosedella nuova politica «ex parte civium»
- Capitolo settimo Patria o nazione? Il patriottismo repubblicano e costituzionale degli illuministi italiani
- Parte seconda Una eredità difficile
- Capitolo ottavo I caratteri originali del costituzionalismo illuministico.Dalla «Scienza della legislazione»al «Progetto di Costituzione napoletana» del 1799
- Capitolo nono Vincenzo Cuoco. La critica nazionaleal costituzionalismo cosmopolita dei Lumi
- Capitolo decimo Il liberale Constant contro l’illuminista Filangieri:due interpretazioni della modernità a confronto
- Capitolo undicesimo Eresie filangieriane nella tradizione democratica europea:il principio di giustizia e il diritto alla felicità