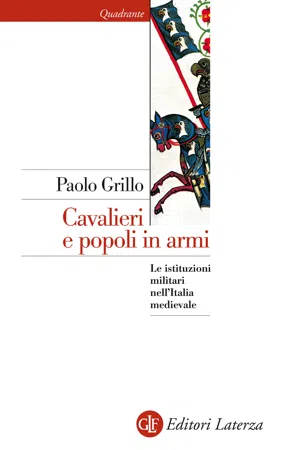
- 240 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Il lettore troverà in queste pagine i modi in cui venivano organizzate, ricompensate e controllate le forze armate destinate a garantire la sicurezza e l'espansione delle diverse dominazioni che si sono avvicendate in Italia nell'arco di un millennio, fra il V e il XV secolo. Non dunque una storia della guerra o delle armi, ma una storia delle istituzioni militari che, muovendo dagli eserciti di popolo di Goti e Longobardi, giunge alle prime guarnigioni permanenti quattrocentesche, passando per i professionisti della guerra bizantini, i cavalieri carolingi, sassoni, normanni e svevi, le fanterie comunali, le turbolente bande di soldati di ventura tedeschi, inglesi e bretoni e, infine, i condottieri italiani.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Cavalieri e popoli in armi di Paolo Grillo in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia dell'Europa medievale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
StoriaCategoria
Storia dell'Europa medievale1. Dall’esercito romano agli eserciti barbarici
1. La caduta dell’Impero romano d’Occidente: una crisi militare?
La caduta dell’Impero romano d’Occidente è un argomento che non cessa di affascinare gli storici. Oggi si tende a ridimensionare il peso dell’evento, cercando di evitare la tradizionale contrapposizione fra Germani e Romani e, anche per superare vecchie letture nazionalistiche, si preferisce parlare di «migrazioni» o addirittura di «incontri» di popoli che non di «invasioni» secondo la tradizione storiografica ottocentesca. In tale prospettiva, in cui le dimensioni dell’incontro e dello scontro si intrecciano e si sovrappongono, si può rivalutare la lettura «militare» della crisi del V secolo, non perché in una serie di battaglie campali i barbari avessero sconfitto l’esercito dell’Impero e, di conseguenza, ne avessero invaso i territori, ma perché poche, decisive battaglie assottigliarono oltremisura gli organici delle forze romane, sicché fu necessario ricostituirle con elementi germanici autorizzati a insediarsi all’interno dei confini.
L’esercito imperiale, fino ad allora praticamente imbattuto negli scontri con i Germani, subì una sola, ma determinante sconfitta nella battaglia di Adrianopoli combattuta nell’agosto del 378 contro la popolazione dei Goti che, due anni prima, dopo aver passato pacificamente il confine danubiano, si erano ribellati mettendo a ferro e fuoco la Tracia (l’attuale Bulgaria). Nel durissimo scontro, i Romani subirono un’inaspettata e disastrosa sconfitta nella quale perì lo stesso imperatore d’Oriente, Valente, e vennero distrutti almeno i due terzi dell’esercito di manovra. Per uno Stato disperatamente a corto di riserve umane, la morte di un gran numero di soldati bene addestrati fu un colpo impossibile da riassorbire senza ricorrere a massicci inserimenti di guerrieri barbari.
La disfatta aprì ai Germani la strada entro i confini dell’Impero, sia ai Goti, che si rifiutarono di uscirne e non poterono venirne scacciati, sia, soprattutto, agli altri popoli stanziati lungo i confini del Reno e del Danubio, frettolosamente arruolati per colmare le perdite. Ciò non toglie che gli imperatori considerassero provvisoria tale situazione e ambissero ad allontanare gli sgraditi ospiti non appena superata l’emergenza. Nella parte orientale essi ebbero successo, poiché dall’anno 400 i sovrani di Costantinopoli iniziarono a perseguire una radicale politica di romanizzazione dei vertici militari, che passò anche attraverso l’eliminazione fisica dei comandanti stranieri. In Occidente, invece, il crollo del confine renano nel 406 e il peso acquisito dall’elemento germanico nell’esercito impedirono una soluzione di tal genere, sicché gli stanziamenti barbarici entro i confini continuarono a crescere in numero e quantità per tutto il V secolo. Gli studiosi sono divisi sulle modalità e le forme di questi stanziamenti. Per Walter Goffart, i trasferimenti furono promossi e favoriti dal governo imperiale, alla ricerca di nuove braccia e di nuove truppe: i nuovi abitanti però sfuggirono al controllo delle autorità pubbliche, ritagliandosi margini di autonomia tali da creare vere e proprie entità statali indipendenti. Altri ricercatori, come Peter Heather, hanno invece insistito sulla dura resistenza tentata dagli eserciti imperiali di fronte alle migrazioni di intere popolazioni entro i confini della romanità, riproponendo, se non l’idea di una vera e propria «invasione» barbarica, quanto meno l’immagine di un Impero conscio del pericolo che andava correndo, pur se impotente a combatterlo.
2. L’esercito del basso Impero
D’altro canto, ben prima di Adrianopoli l’esercito aveva cominciato a rappresentare un problema per l’Impero: puntello della sicurezza interna ed esterna e, spesso, fonte diretta del potere degli autocrati saliti al trono, l’immensa macchina militare romana, che poteva inquadrare oltre mezzo milione di uomini, rappresentava anche un’insaziabile fonte di spese, che inghiottiva una percentuale sempre maggiore del bilancio statale ed era perciò sempre più malvista dai gruppi dirigenti civili. In particolare, dopo la «crisi del III secolo», che aveva visto l’Impero dilaniato dalle guerre civili e la definitiva affermazione dell’esercito come principale fonte del potere a spese del senato e della popolazione di Roma, l’opera riformatrice di Diocleziano e di Costantino diede l’avvio a una progressiva «militarizzazione» dello Stato romano, le cui risorse umane, fiscali ed economiche sarebbero state in prevalenza destinate al mantenimento delle truppe.
L’esercito romano negli ultimi due secoli di vita dell’Impero d’Occidente era infatti molto diverso da quello del pieno splendore della tarda età repubblicana e dei primi tempi del principato. Diocleziano (284-305) aveva reintrodotto la coscrizione obbligatoria, dopo che, da circa quattrocento anni, i reparti romani erano stati costituiti da volontari professionisti. Come per le altre principali professioni, la normativa dioclezianea prevedeva l’ereditarietà del mestiere di soldato. Le forze così costituite potevano essere integrate da arruolamenti di volontari o da leve annuali, in base alle quali ogni proprietario o gruppo di proprietari fondiari (detto capitulum) doveva fornire un uomo: era però possibile evitare questo servizio col pagamento di una tassa, detta aurum tironicum, con la quale venivano pagati i sostituti necessari. In effetti, le necessità dell’esercito dovevano confrontarsi con quelle dell’agricoltura e dell’artigianato, poiché l’Impero era, all’epoca, territorialmente vastissimo, ma demograficamente povero. La miglior soluzione al problema, già talvolta utilizzata in precedenza ma poi sistematizzata nel corso del IV secolo, era quella di ricorrere ai barbari stanziati oltre il limes, arruolati a pagamento: sebbene, come vedremo, alla lunga tale sistema abbia causato gravi problemi, in un primo momento dimostrò invece grande efficacia, visto che l’esercito si rivelò una possente macchina di integrazione e di «romanizzazione» per i Germani entrati al suo servizio.
Fu però l’imperatore Costantino (306-337) a rinnovare radicalmente le tradizioni militari romane, stabilendo una distinzione fra truppe confinarie di presidio (limitanei) e riserve mobili (comitatenses). Sotto Costantino, inoltre, l’esercito si valse sempre più di unità meno numerose e agili (alae, vexillationes, cunei o, più genericamente, numeri), composte da poche centinaia di uomini, abbandonando via via le grandi legioni che radunavano 5 o 6.000 combattenti. I comandi vennero riorganizzati su scala locale: ogni provincia (diocesi) dell’Impero aveva un magister militum, che guidava i comitatenses ivi stanziati, mentre nelle regioni di frontiera i limitanei erano sotto l’autorità dei duces, che a loro volta rispondevano ai comites, a livello diocesano. Queste nuove cariche sostituirono i prefetti dell’età classica, a cui fu lasciata la sola amministrazione civile. L’imperatore era poi affiancato da un magister militum e un magister equitum quali comandanti generali.
La difesa delle frontiere impiegava risorse imponenti. La Notitia Dignitatum – un catalogo dei reparti dell’esercito imperiale redatto in Occidente nei primi anni del V secolo – elenca centinaia di castelli che vegliavano sui limites dell’Impero, ognuno con una robusta guarnigione di Romani o Germani. L’organizzazione dei limitanei e la loro efficienza bellica sono stati oggetto di un vivacissimo dibattito storiografico. Oggi la maggior parte degli studiosi concorda sul fatto che essi non furono semplici «soldati-coloni», privi di capacità di combattimento, ma rappresentarono una forza considerevole ed efficace. Stanziati in fortezze, accampamenti e torri del limes o insediati nelle città di confine, equipaggiati dallo Stato ed esenti dalla gravosa tassa detta capitatio, di norma ricevevano uno stipendio che solo in epoca tarda venne sostituito con l’attribuzione di appezzamenti fondiari. Fu nel corso del V secolo che i limitanei persero importanza nei confronti dell’esercito di manovra e divennero progressivamente truppe di seconda scelta.
La riserva strategica nacque da un ampliamento della guardia imperiale, i palatini, di cui i nuovi reparti ereditarono paga e privilegi. Essi presero il nome di «seguito» (comitatus) del sovrano e vennero dunque denominati comitatenses. Le loro unità furono scaglionate nelle diverse province e acquartierate presso le principali città. Ciò favoriva anche l’approvvigionamento di tali corpi e ridistribuiva meglio sull’intero territorio imperiale vantaggi e svantaggi dell’ospitalità alle truppe. Una posizione polemica, già vivace negli scrittori del IV secolo e proseguita da alcuni storici contemporanei, vuole che l’istituzione dei comitatenses abbia finito con l’indebolire troppo le difese dei confini, senza creare unità veramente efficienti nelle riserve. La critica sembra tuttavia ingiusta, visto che l’apparato bellico delineato da Costantino si mantenne efficiente per circa un secolo in Occidente e per oltre trecento anni in Oriente. Bisogna anche notare che dal punto di vista operativo non è possibile stabilire una divisione troppo rigida fra i limitanei e i comitatenses, dato che truppe dei due ranghi spesso combatterono fianco a fianco, anche in occasione di campagne offensive o di spedizioni punitive oltre confine.
Dal punto di vista tattico, vennero progressivamente introdotte due importanti innovazioni. Sia fra i limitanei, sia fra i comitatenses, crebbe sempre più il peso della cavalleria, con l’adozione, sul modello orientale, della collaborazione fra uomini d’armi corazzati (catafratti) e tiratori montati. Per quanto incerti, i dati della Notitia Dignitatum attribuiscono ai reparti a cavallo una consistenza pari a circa il 30% delle forze complessive. Secondo la stessa fonte, in Italia ne erano schierate sette unità (vexillationes):
i comites seniores, i cavalieri Promoti seniores, i cavalieri Brachiati seniores, i cavalieri Cornuti seniores, i comites Alani, i cavalieri Mauri feroci, i cavalieri Costanti di Valentiniano iuniores1.
Nel contempo, si sviluppò un articolato sistema di fortificazioni interne. Fin dal tempo di Aureliano (270-275) era stato ordinato che le città dell’Impero fossero cinte da mura e la cerchia della stessa Roma fu rinnovata nel 271. Nei decenni successivi, la rete dei castelli che sorvegliavano le principali strade di comunicazione all’interno dei confini fu ampliata secondo un complesso disegno strategico volto a interrompere le principali vie di penetrazione a disposizione di eventuali invasori obbligandoli a fermarsi o a dividersi, rendendoli in tal modo vulnerabili ai contrattacchi delle riserve imperiali. Non mancarono, a fianco delle fortificazioni pubbliche, cinte difensive e torri erette spontaneamente da grandi proprietari e da comunità contadine per garantirsi l’autodifesa. Si può dire che nel tardo Impero i due elementi che avrebbero poi dominato la storia militare del Medioevo, ossia il combattente corazzato a cavallo e il castello, avevano già cominciato ad affacciarsi quali protagonisti.
L’esercito romano del IV secolo rimaneva comunque una forza considerevole, in grado di imporre la sua totale superiorità su tutti gli eventuali avversari in Europa e di tenere in rispetto i Persiani in Asia. Secondo le stime più attendibili, esso poteva contare su quasi mezzo milione di effettivi, di cui il 40% in Occidente e il 60% in Oriente, ben armati ed equipaggiati. La sua organizzazione era fortemente centralizzata: Diocleziano aveva disposto la creazione di una rete di allevamenti e di fabbriche di armi statali, distribuiti per tutto il territorio dell’Impero, grazie ai quali era possibile fornire alle diverse unità cavalli, corazze, armi ed equipaggiamenti di alta qualità e conformi a standard di produzione ben precisi. Secondo la Notitia Dignitatum, in Italia si producevano
a Concordia, frecce, a Verona, scudi e armi, a Mantova, corazze, a Cremona, scudi, a Pavia, archi, a Lucca, spade2.
Tutto ciò, ovviamente, aveva un prezzo: l’esercito assorbiva infatti una parte altissima delle entrate fiscali, suscitando ostilità e malumore nei contribuenti civili, che vedevano finire nelle mani dei militari una grande parte del denaro da loro versato.
Dopo la crisi economica e monetaria che travagliò l’Impero nel corso del III secolo, per l’approvvigionamento dell’esercito fu introdotta la fornitura in natura del necessario, prassi che prese il nome di annona militaris e sostituì precedenti imposte pagate in denaro. Rispetto a queste, l’annona è stata solitamente interpretata come un metodo più rozzo di gestione delle risorse, ma aveva in realtà precise finalità pratiche. Essa serviva infatti a garantire la destinazione all’esercito di una quota fissa del prelievo fiscale e a liberare i comandanti dalla necessità di procacciarsi di volta in volta le risorse necessarie al mantenimento delle truppe. Inoltre, il provvedimento era utile in un periodo di inflazione galoppante, poiché garantiva la fornitura di quanto era dovuto ai soldati, che sfuggivano in tal modo all’aleatorietà di uno stipendio versato nella svalutatissima moneta bronzea. Oltre ai viveri, infatti, essi ricevevano anche donativi straordinari in oro, metallo dal valore ben più stabile. Proprio in oro dovevano venir versate tutte le tasse con finalità militari (fra cui l’aurum tironicum, già ricordato), mentre le altre potevano essere pagate in bronzo. Ciò non contribuì alla popolarità dell’esercito e dei suoi costi presso le élites civili, costrette a procurarsi metalli preziosi a prezzo di mercato per poter assolvere i loro doveri fiscali. L’ostilità a tali pagamenti cresceva poi proporzionalmente alla quantità di denaro che veniva sborsata a favore non di combattenti romani, ma di mercenari barbari.
3. La germanizzazione dell’esercito
L’immissione degli elementi stranieri negli eserciti romani aveva iniziato a essere consistente già nel corso del III secolo, ma rimase sempre sotto il rigido controllo dell’amministrazione imperiale. I barbari venivano di norma inquadrati in unità minori (dette auxilia), di entità e composizione assai variabili. Non vi era comunque una specifica vocazione militare dei popoli germanici e delle steppe, poiché l’Impero, affamato di braccia, li utilizzava in diversi settori: Eusebio, biografo di Costantino, scrive che questi nel 334 accolse l’iperbolica quantità di 300.000 Sarmati nel territorio romano assegnando i migliori all’esercito e destinando gli altri ai lavori agricoli. I Sarmati furono così dispersi fra Tracia, Scizia, Macedonia e Italia settentrionale, dove fondaro...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- 1. Dall’esercito romano agli eserciti barbarici
- 2. Bizantini e Longobardi
- 3. Apogeo e crisi delle istituzioni militari carolinge
- 4. Gli eserciti «privati»
- 5. Una pluralità di ordinamenti militari: Longobardi, Bizantini, Arabi e Normanni nel Mezzogiorno italiano
- 6. Cavalieri e crociati
- 7. Gli eserciti comunali
- 8. Federico II, Carlo d’Angiò e la crisi degli eserciti comunali
- 9. L’età delle compagnie di ventura
- 10. Le condotte del primo Quattrocento
- 11. Alle soglie delle guerre d’Italia