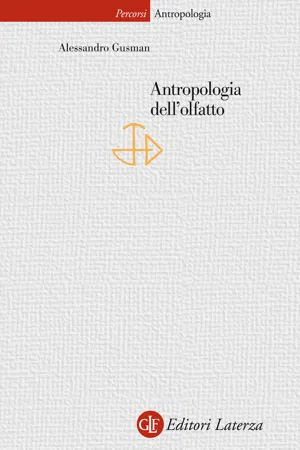
- 208 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Antropologia dell'olfatto
Informazioni su questo libro
Un viaggio nel tempo e nello spazio, attraverso culture europee ed extra-europee, passate e presenti, alla scoperta dei simboli e dei significati attribuiti all'olfatto. Una sintesi originale e inedita che consente all'antropologo di cogliere sfere di significato inaccessibili al solo sguardo e al lettore di scoprire quanto le nostre percezioni siano culturalmente influenzate.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Antropologia dell'olfatto di Alessandro Gusman in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Social Sciences e Anthropology. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Social SciencesCategoria
AnthropologyOlfatto e plasticità neuronale
Chi si occupa delle scienze umane
ha bisogno di sapere dell’occhio che vede
tanto quanto dell’oggetto veduto.
(Kluckhohn 1979: 21)
6.1. La plasticità delle reti neuronali tra biologia e antropologia
6.1.1. «Incompletezza» e «plasticità» umana
Il concetto di neuroplasticità, o plasticità del sistema nervoso, è un’acquisizione molto recente delle neuroscienze; ancora all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso era opinione diffusa che il cervello fosse un meccanismo molto rigido nella sua eccezionale complessità, e che ogni forma di adattamento fosse impossibile. Solo negli ultimi vent’anni gli scienziati hanno iniziato a comprendere come in realtà la struttura cerebrale sia molto più malleabile di quanto si pensasse in passato. La neuroplasticità è una caratteristica che riguarda soprattutto (ma non in maniera esclusiva, come vedremo) la corteccia cerebrale, ossia la parte filogeneticamente più recente dell’encefalo umano, ed è particolarmente marcata nel periodo dello sviluppo, soprattutto nei cosiddetti «periodi critici». Tuttavia, negli ultimi anni numerosi studi hanno dimostrato che anche la corteccia cerebrale dell’adulto conserva un certo grado di plasticità; sebbene diminuisca notevolmente, non è però vero, come si è pensato fino a tempi recenti, che questa capacità di riorganizzarsi dei circuiti nervosi della corteccia venga persa al termine dello sviluppo.
Benché la ricerca scientifica sia giunta solo molto di recente a dimostrare l’esistenza di fenomeni di plasticità nell’encefalo umano (il che ha aperto la via a nuove discussioni sul ruolo che la biologia e la cultura rispettivamente occupano nella definizione dell’essere umano come tale), da sempre i pensatori sono stati affascinati dalla particolare capacità dell’uomo di adattarsi agli ambienti più disparati, e di elaborare in questi contesti numerosissime differenti forme culturali. L’idea che l’uomo sia un essere dalla natura particolarmente indefinita, destinato a completarsi nell’interazione con l’ambiente culturale e fisico in cui viene a trovarsi, è stata sostenuta da umanisti e filosofi di ogni epoca. La validità di questo genere di intuizioni è stata confermata dagli studi scientifici, che hanno dimostrato «come i circuiti neuronici, almeno per certi aspetti, quali ad esempio le dimensioni e le modalità di organizzazione dei campi recettivi, possano concretamente modificarsi in risposta al mutare delle circostanze» (Purves et al. 2000: 475). Il «mutare delle circostanze» usato dai neuroscienziati richiama, per chi si è formato in altre discipline, l’idea dell’apprendimento in contesti socio-culturali differenti.
È piuttosto sorprendente constatare la somiglianza delle affermazioni di scienziati dei nostri giorni con quelle di pensatori di secoli passati, nel trattare della capacità di adattamento dell’uomo dovuta alla plasticità del suo cervello, caratteristica che lo rende «plasmabile» anche dopo la nascita1. Prendiamo ad esempio l’orazione De hominis dignitate, che Pico della Mirandola aveva preparato nel 1486, senza poi poterla pronunciare per l’opposizione della Chiesa nei confronti dei suoi contenuti; in essa si trovano passaggi interessanti a proposito dell’indeterminatezza della natura umana, e della conseguente possibilità dell’uomo di abitare ogni luogo del mondo e di decidere ciò che vuole divenire. Secondo Pico, non esisterebbe una natura peculiarmente umana, né per l’uomo un posto specifico dove stare, ma la possibilità per questo particolare animale di «diventare ciò che progetta». L’incompletezza della natura umana non si presenta, agli occhi di Pico, come un difetto, ma come un dono che il Creatore ha fatto all’uomo, conferendogli in tal modo una proprietà unica tra gli esseri viventi, quella della scelta della forma che egli vuole assumere: «perché di te stesso quasi libero e sovrano artefice, ti formassi e ti scolpissi nella forma che avresti prescelto».
Confrontiamo queste asserzioni con quelle, più recenti, di Ian Robertson (1999); noteremo una consonanza di vedute e di termini ben maggiore di quanto ci si potrebbe aspettare:
La storia dell’uomo è unica da un punto di vista evolutivo poiché siamo in grado di forgiare il nostro destino plasmando il nostro cervello. Come specie, siamo sopravvissuti alla selezione naturale in quanto muniti d’una capacità di adattamento pressoché illimitata – quella flessibilità che ci viene da quel 40 per cento della materia cerebrale, i lobi frontali, che costituisce l’essenza della nostra «umanità» (Robertson 1999: 10; corsivo mio).
I temi della capacità di adattamento e della possibilità di modellamento del proprio destino da parte dell’uomo sono simili, anche se chiaramente Robertson può sostenere la propria tesi con prove scientifiche non disponibili a Pico della Mirandola. Grazie alle scoperte compiute dalle neuroscienze negli ultimi decenni, l’uomo può essere liberato dai determinismi biologici che a lungo hanno avuto seguaci nel Novecento; torna così anche nelle trattazioni scientifiche il tema della scelta e della libertà dell’uomo, costante argomento di discussioni filosofiche. Se per Johann Gottfried Herder la cultura e l’educazione rappresentano una vera e propria seconda genesi per l’uomo (1992: 158), il neurofisiologo Lamberto Maffei, distinguendo tra un cervello «imprigionato» e uno «libero», parla esplicitamente di un «nutrimento culturale» da cui dipende in parte lo sviluppo del secondo (Maffei 2000: 8).
Come detto, sono numerosi i pensatori che hanno affrontato temi simili nelle loro opere: da Giambattista Vico a Blaise Pascal, da Michel de Montaigne a Friedrich Nietzsche, e tutti richiederebbero un’analisi più approfondita. Nelle pagine seguenti cercheremo di riassumere brevemente le posizioni di tre filosofi e antropologi che in modi ed epoche diverse hanno trattato il tema dell’incompletezza e indeterminatezza dell’essere umano.
a) Johann Gottfried Herder. Nelle Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, scritte tra il 1784 e il 1791, Herder descrive l’intera realtà come un processo unitario nel quale si manifesta una forza divina. Questa si esprime attraverso forme di vita sempre più alte e complesse; il culmine del percorso è naturalmente l’uomo, superiore agli altri animali perché in possesso del linguaggio, della stazione eretta, della ragione e, ciò che più interessa qui, di una natura indefinita che lo rende libero più di ogni altro essere. L’uomo è descritto da Herder come un animale incompleto e particolarmente povero di istinti che possano guidarlo nei suoi comportamenti, come invece avviene per gli altri animali. Per questo l’essere umano deve apprendere i comportamenti, secondo modelli che gli vengono forniti dalla cultura in cui vive. Ciò significa naturalmente che in contesti culturali diversi si troveranno modelli differenti, con il conseguente formarsi di una grande varietà di tipi umani.
L’uomo herderiano, per le caratteristiche peculiari a cui abbiamo accennato, è la «creatura centrale e intermedia tra tutti gli animali della terra» (Herder 1992: 23), in grado di concentrare su di sé, imparandole o ereditandole, tutte le migliori qualità degli altri animali. Proprio la capacità di apprendere e perfezionarsi fa sì che l’uomo sfugga alla necessità da cui sono dominate le bestie, affermando il proprio libero arbitrio. In virtù delle capacità che lo rendono libero, è però anche un essere indeterminato, privo della guida sicura degli impulsi. Anche per Herder, come per Pico della Mirandola, questa indefinitezza è una ricchezza, non un limite: gli altri animali hanno ricevuto dalla Natura istinti sicuri che li conducono alla meta prefissata, ma al contempo li soggiogano; l’uomo possiede invece impulsi naturali molto affievoliti e perciò, eccetto alcune dotazioni innate necessarie alla sopravvivenza, egli deve «imparare da capo tutto ciò che appartiene all’Umanità e alla ragione» (Herder 1992: 91). In questo compito lungo e complesso la libertà di scelta è sempre massima, fatto che rende possibile la realizzazione di forme di umanità pressoché illimitate. Inoltre, il compito con cui l’uomo si deve confrontare, quello di completarsi con l’educazione, è infinito: l’esercizio di formarsi alla vera umanità dura tutta la vita, ed è la fonte tanto dei migliori risultati e delle conquiste del genere umano, quanto delle sue degenerazioni e aberrazioni. In questo processo di apprendimento le uniche guide giungono dai modelli elaborati dalla società, quelli che Montaigne e Pascal chiamavano «costumi», e che Herder inizia a raccogliere sotto il nome di «cultura», ritenendola la «seconda genesi dell’uomo» (ivi: 158). La cultura è per Herder la peculiarità del genere umano, anche se talvolta nella trattazione assume caratteri quasi deterministici, tanto da far sembrare che alle costrizioni imposte dalla natura agli animali si sostituiscano quelle derivate dalla «cultura che forma e deforma», cui l’uomo non può sottrarsi e che «forma la sua testa e modella le sue membra» (ivi: 159). Infine, anche il clima svolge un ruolo importante nel plasmare l’uomo in forme molto diversificate, così come lo sono appunto i climi della terra. Herder si affretta però immediatamente a chiarire che esso «predispone, favorisce, ma non costringe lo sviluppo dell’uomo» (ivi: 114). L’essere umano, in conclusione, risulta dall’azione congiunta della natura (la forza genetica) e dell’ambiente fisico e culturale.
Ci sono passi delle Ideen in cui è ancora più esplicita la nozione di plasticità, e della sua diminuzione con il passare degli anni. In una sezione dedicata specificamente al cervello e al suo sviluppo Herder spiega che questo è più fluido e morbido nel giovane che nell’adulto, e che nel corso del tempo diviene sempre più «secco e solido» (ivi: 40). Lo stesso concetto viene ribadito più avanti, allorché il filosofo afferma che
Il cervello del bambino è ancora molle e attaccato alla scatola cranica; a poco a poco forma le sue circonvoluzioni e diventa sempre più solido con il passare degli anni. Lo stesso per le membra, per gli istinti del fanciullo (ivi: 156).
Il tono delle affermazioni farà sorridere gli specialisti, ma certo i contenuti sorprendono per le intuizioni molto attuali.
b) Arnold Gehlen. Anche la concezione «antropobiologica», espressa da Arnold Gehlen nell’opera Der Mensch, pubblicata per la prima volta nel 1940, parte dall’idea dell’essere umano come animale non ancora definito, caratterizzato da uno sviluppo tardivo, e conseguentemente da incompletezza.
Particolarità dell’ontogenesi umana è infatti secondo Gehlen il primitivismo e il ritardo nello sviluppo; ciò conferisce all’uomo una morfologia singolare, caratterizzata dalla mancanza di organi ad alta specializzazione, adattati a un ambiente definito. Questi fatti dimostrerebbero – come Gehlen si sforza di convalidare con esempi – che le diverse parti del corpo dell’uomo risalgono a stadi ontogenetici fetali, conservati in età adulta (Gehlen 1990: 115). Come già in Herder, la non specializzazione dell’essere umano viene considerata come un fattore positivo, poiché lascia aperte un gran numero di possibilità di sviluppo. A differenza degli altri animali, l’uomo, proprio grazie alla sua indefinitezza, è in grado di sviluppare numerose possibilità di utilizzo delle membra, fatto che lo rende in grado di sopravvivere in qualunque situazione.
Oltre alla primitività degli organi, ciò che colpisce Gehlen è la «primavera extrauterina» che caratterizza l’ontogenesi umana (ivi: 72): solo all’età di un anno il bambino acquisisce il grado di formazione che gli altri mammiferi hanno già alla nascita. Questa circostanza è della massima importanza, perché fa sì che il bambino si sviluppi seguendo non solo le imposizioni genetiche, ma anche gli stimoli che gli provengono da tutta una serie di vissuti. Ciò determina nell’uomo una caratteristica «apertura al mondo», parte fondamentale nel processo di sviluppo delle membra, dei sensi e delle abilità motorie.
Apertura al mondo significa soprattutto che l’essere umano non è disposto dalla natura a vivere in alcun ambiente specifico. Questo rivolgersi all’esterno si presenta come il rovescio della medaglia della mancanza di specializzazione fisica e della carenza di istinti, che costringono l’uomo a trovare nuovi strumenti per sopravvivere nel contesto fisico e culturale in cui si trova a operare. Sottoposto all’«azione plasmatrice» dell’ambiente, l’essere umano è però in grado di modificarlo a sua volta, sostituendo così al mondo soggettivo in cui vive la bestia un mondo culturale, che è per lui come una seconda natura (ivi: 108-109), e che gli fornisce quelle strutture di cui abbisogna per far fronte alla sua originaria incompletezza.
È a questo livello che si pongono due concetti fondamentali del pensiero antropologico di Gehlen, quelli di «esonero» e di «azione»: l’uomo è un essere manchevole, che deve aprirsi al mondo per poter sopravvivere, ma che in tal modo si espone a una profusione di stimoli provenienti dall’esterno, cui la cultura risponde con l’esonero (ivi: 56). Esso consiste nella capacità, culturalmente appresa, di agire indipendentemente dai bisogni e dagli stimoli immediati e primari, passando a piani di azione simbolici e intellettuali. Grazie alle abilità di esonero, gli individui non subiscono passivamente l’eccesso di stimoli, ma prendono posizione rispetto a essi, selezionandoli: è questo il piano dell’azione, del dirigersi verso il futuro, cercando di dominare il più possibile gli impulsi endogeni ed esogeni.
Come abbiamo detto, l’attitudine a controllare in qualche modo il mondo, anziché subirlo, non è innata per l’uomo, ma necessita dell’educazione che solo la cultura può fornire. Le abilità proprie della specie umana (soprattutto il camminare e il linguaggio), necessarie per l’esonero, verrebbero acquisite solo con grande fatica e dopo molto tempo, senza l’intervento esterno:
La capacità, decisiva per un essere che agisce, di prendere posizione verso l’esterno e verso l’interno, agendo autonomamente e esercitando il relativo controllo, ha come condizione del suo sviluppo l’influsso e la permanente presenza della società (ivi: 88).
L’azione della società e gli sforzi che l’uomo fa per autodisciplinarsi sarebbero però inutili senza quella peculiarità del cervello umano che è la plasticità (ivi: 144). Solo questa caratteristica rende possibile la sopravvivenza in assenza di specializzazione degli organi, ed è perciò una necessità biologica che sopperisce alla deficienza organica dell’uomo.
La procedura dell’esonero riguarda naturalmente anche gli stimoli percettivi, fatto molto interessante per i temi affrontati in questo libro: per Gehlen infatti la percezione non è una passiva ricezione di stimoli provenienti dal mondo esterno, ma un processo attivo di elaborazione del profluvio di impressioni da cui i sensi sono colpiti. Il mondo percettivo dell’uomo è dunque, caso unico, autonomamente elaborato e ordinato, e ciò avviene fin dalla prima infanzia, quando il bambino, utilizzando le mani e la bocca come strumenti di conoscenza delle forme e degli oggetti, riduce il caos delle informazioni che gli giungono tramite le facoltà percettive, e inizia a creare quelle categorie che gli permetteranno in seguito di «appropriarsi del mondo» (Gehlen 1990: 198).
Le argomentazioni di Gehlen, pur affascinanti e a tratti sorprendenti per la loro attualità, non sono esenti da errori, dovuti in buona parte alle conoscenze scientifiche dell’epoca. Oggi molte sue affermazioni sarebbero facilmente contraddette; in particolare, il filosofo mostra un relativismo culturale troppo accentuato, come egli stesso ammetterà alcuni anni dopo la pubblicazione di Der Mensch, sostenendo di aver conferito troppo poca attenzione alla componente istintuale innata nel dirigere i comportamenti umani.
c) Clifford Geertz. Tra gli antropologi, Clifford Geertz è senza dubbio uno di quelli che più hanno utilizzato il concetto di «incompletezza» relativamente all’uomo, nel tentativo di chiarire il ruolo della cultura nello sviluppo della specie umana, più che del singolo individuo. Già in Interpretazione di culture (1988), l’antropologo americano inseriva due articoli relativi alla connessione tra lo sviluppo della cultura e l’evoluzione umana, soprattutto del cervello. Più recentemente Geertz è ritornato...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- Capitolo I. L’antropologia sensoriale
- Capitolo II. L’antropologia dell’olfatto
- Capitolo III. L’odore dell’Altro
- Capitolo IV. Odori e riti
- Capitolo V. Odore di vita, odore di morte
- Capitolo VI
- Olfatto e plasticità neuronale
- Conclusione. Due punti di vista
- Bibliografia