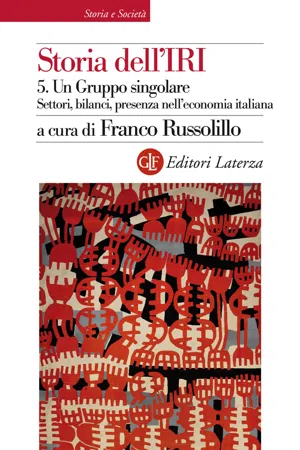Capitolo 1. La siderurgia IRI dal Piano Sinigaglia alla privatizzazione (di Ruggero Ranieri con la collaborazione di Salvatore Romeo)
[A Salvatore Romeo si devono i paragrafi II.1, II.2 e II.3.]
I. IL PIANO SINIGAGLIA, LA CECA, IL NUOVO CENTRO DI TARANTO E LA GRANDE STAGIONE DELL’ITALSIDER (1948-1968)
1. Gli anni della Ricostruzione (1948-1952)
Il programma siderurgico IRI Finsider – il cosiddetto «Piano Sinigaglia» – venne discusso e approvato dopo alcune sedute del Comitato interministeriale per la ricostruzione (Cir) nel corso del 1948. Prevedeva di concentrare la produzione di ghisa d’altoforno in tre impianti a ciclo integrale, con una capacità complessiva di poco inferiore a quella pre-bellica. Gli impianti di Cornigliano sarebbero stati ricostruiti e completati con un’acciaieria Martin e con modernissimi treni di laminazione a caldo e a freddo, per consentire «un’alta produttività di lamiere e lamierini di qualità superiore, di latta e di nastro da servire anche come principale fonte di rifornimento dell’industria trasformatrice ed automobilistica nazionale». A Piombino si raggruppavano invece le lavorazioni delle rotaie e di prodotti semifiniti, mentre Bagnoli avrebbe curato prevalentemente la produzione di profilati, dei tondi per cemento armato e della vergella.
La Finsider nel 1948 era un gruppo diversificato, articolato in quattro grandi aziende: Ilva, Siac, Terni e Dalmine (a cui si sarebbe poi aggiunta la Cornigliano), con cinque stabilimenti dotati di altiforni (i tre contemplati nel Piano, oltre a Servola e Portoferraio), ben dieci stabilimenti a carica solida con relativi laminatoi e, infine, sei centri di seconda lavorazione. Il Piano Finsider prevedeva una «radicale azione di concentramento», tale da portare alla «limitazione dei nostri stabilimenti attivi, ma con una maggiore valorizzazione delle loro attrezzature che oltre a venire riordinate e ammodernate risulteranno sfruttate ai livelli più adeguati alle loro migliori capacità». Alcuni stabilimenti avrebbero dovuto essere chiusi: tra di essi quelli di Portoferraio, distrutto durante la guerra, Bolzaneto, Savona. Altri, come Terni, Campi (Siac), Lovere, Marghera, Servola, Dalmine e Apuania, dovevano essere modernizzati e valorizzati. Un programma di razionalizzazione non realizzato pienamente: molte situazioni locali si rivelarono difficili da trattare e i relativi problemi continuarono ad affliggere la Finsider. Stando ai progetti, una volta realizzato il Piano la Finsider avrebbe raggiunto una quota intorno al 90% della produzione nazionale di ghisa e al 60% dell’acciaio grezzo, garantendo ai produttori privati la disponibilità, a prezzi convenienti, di ghisa e di semilavorati dai suoi stabilimenti a ciclo integrale. Il punto chiave era proprio quello dei prezzi: la scommessa del Piano era che si potesse produrre ghisa e acciaio in Italia a prezzi internazionali.
1.1. Il Piano Sinigaglia
Le due sedute del Cir dedicate all’esame del Piano Sinigaglia si svolsero nel gennaio e nell’agosto 1948. Quella di gennaio fu molto fredda e contrastata: preceduta da un «Promemoria sulla siderurgia italiana», in cui Sinigaglia insisteva, fra l’altro, sulla necessità di ricostruire Cornigliano, vide notevoli contrasti con il ministro dell’Industria e del commercio Roberto Tremelloni. Questi contestava l’idea stessa della necessità di una siderurgia di massa, in sintonia con una visione comune allora all’opinione liberista e a molti imprenditori privati. Sinigaglia, particolarmente assertivo in questa occasione, non si limitò a controbatterne le vedute: chiese che il governo facesse propria la sua visione del problema. I finanziamenti sarebbero arrivati, egli stesso se ne faceva garante; mentre rifiutava in anticipo il ricorso a operazioni di salvataggio intraprese con alcuni settori della meccanica – il riferimento era alla creazione del Fondo per il finanziamento dell’industria meccanica e alle difficoltà della meccanica pesante e della cantieristica IRI. La siderurgia, ripeteva Sinigaglia, si può risanare e portare sul piano economico. Ferrari Aggradi lo appoggiò decisamente: il Piano Finsider, egli assicurava, non era punitivo per le imprese private siderurgiche, ma anzi era destinato ad aprire loro nuove opportunità; lo stesso Sinigaglia se n’era fatto carico esplicitamente nei piani economici presentati alla Conferenza di Parigi sul Piano Marshall. Riferendosi ai privati, l’autore del Piano fu più secco: «chiedono unicamente maggiori importazioni di rottame», che egli giudicava, peraltro, difficili da ottenere; «non hanno alcun progetto d’insieme».
Alla riunione intervenne, sia pure in ritardo, Luigi Einaudi, e questo fu una fortuna per Sinigaglia, perché l’autorevole ministro liberale, da cui ci si sarebbe aspettati una valutazione severa delle ambizioni Finsider, finì invece per sposarne, sia pure cautamente, la linea. Tremelloni, ormai in minoranza, si appellò allo stato di incertezza politica (si era poco prima delle elezioni spartiacque del 18 aprile 1948): «Nelle attuali condizioni – affermò – è difficile formulare impegni a lunga scadenza». Su questo si trovarono tutti d’accordo, e del resto Sinigaglia non mancò di sottolineare come egli avesse già parlato con De Gasperi della minaccia comunista, a livello non solo politico ma anche sindacale ed economico.
Il clima della riunione di agosto fu molto diverso. Vi parteciparono molti ministri, che sollevarono obiezioni di diverso tipo: alcuni temevano un ridimensionamento eccessivo della siderurgia privata, altri erano scettici sulle possibilità della Finsider. Ma non vi fu alcuna opposizione di principio: sembrava, anzi, che tutti aspettassero di essere convinti. Cosa che puntualmente avvenne. Il Piano, formalmente approvato insieme ai progetti di investimento delle altre finanziarie IRI agli inizi di settembre 1948, divenne parte fondamentale degli obiettivi economici del governo italiano.
Quando nella storia ci si trova di fronte a figure torreggianti che imprimono il loro segno sugli eventi, diventa complesso ristabilire l’equilibrio tra fattori oggettivi e soggettivi. Oscar Sinigaglia fu indubbiamente una di queste figure. In quel periodo la Finsider si trovò a combattere su diversi fronti: all’interno contro i suoi detrattori e concorrenti, all’esterno con l’amministrazione americana per gli aiuti del European Recovery Program (Erp) e parallelamente con la Fiat – con cui, come vedremo, si raggiunse un accordo dopo complesse trattative – e con i partner europei nella Ceca. In tutte queste situazioni il ruolo svolto dal suo presidente fu prevalente e ininterrotto, con un profluvio di memoriali, corrispondenze, documenti, incontri formali e informali. In quegli anni drammatici, letteralmente egli si caricò sulle spalle il futuro della siderurgia italiana. Non era, del resto, la prima volta. Presentando al governo le sue proposte «di sistemazione definitiva» dell’industria, ricordava come l’impresa
è stata già tentata da chi vi parla ben cinque volte nella sua vita da quarant’anni a questa parte senza mai riuscirvi [...] Questa è la sesta volta; è solo per fare questo nuovo ed ultimo tentativo che ho accettato, già vecchio, di rientrare nel lavoro e nell’industria, esclusivamente nell’interesse del nostro paese.
Nel richiamo all’interesse nazionale traspare la matrice culturale insieme nittiana e patriottica (talvolta perfino nazionalistica) che accomunò Sinigaglia ai grandi dirigenti dell’IRI della prima fase, quelli che videro nell’intervento statale «straordinario» la premessa per fare dell’Italia un grande paese industriale. Un orizzonte di emergenza, temporaneo, non un paradigma o una filosofia, tanto da permettere a Sinigaglia di rimanere ancorato ai valori del mercato.
L’assunto iniziale era che la siderurgia fosse la base di tutto il sistema produttivo. Occorreva, in primo luogo, rifornire l’industria meccanica italiana a prezzi competitivi, comparabili a quelli della concorrenza straniera, mettendola in condizione di affrontare produzioni di serie e di affacciarsi sui mercati dell’esportazione. Una siderurgia competitiva in Italia non era solo indispensabile, ma anche possibile: non c’era più, infatti, come era stato vero agli albori, una inferiorità «naturale», legata alla mancanza nel sottosuolo nazionale di carbone da coke e delle quantità necessarie di minerale di ferro. Inoltre, l’abbassamento dei costi di trasporto e la meccanizzazione delle operazioni di carico e scarico avevano annullato il premio agli impianti siderurgici sorti presso le miniere, come quelli dei paesi di più vecchia industrializzazione, e offrivano, invece, un vantaggio per impianti costieri, che potessero ricevere via mare carbone e minerale di prima qualità.
La siderurgia italiana, quindi, aveva una grande opportunità. Doveva sviluppare una produzione costiera basata su altiforni e acciaierie (cioè «a carica liquida»), assicurandosi l’accesso a fonti di materie prime, di facile trasporto via mare. Preferibilmente questo doveva avvenire con il possesso o la partecipazione a giacimenti esteri, in particolare di minerali di ferro, ma anche di carbone (Sinigaglia pensava al carbone tedesco della Ruhr). Altrimenti, si poteva ripiegare su contratti a lunga scadenza. In ogni caso i prezzi delle materie prime, e soprattutto del ferro, sarebbero stati sottratti alle oscillazioni congiunturali che, invece, caratterizzavano il mercato del rottame, i cui costi seguivano la congiuntura. Tra l’altro il rottame da importazione, di cui l’Italia faceva largo uso, era disponibile prevalentemente nei paesi industrializzati concorrenti della siderurgia italiana, da cui non era saggio dipendere totalmente. Non si trattava di cessare le produzioni basate sul rottame (elettriche o «a carica solida»), ma di contenerle: sviluppando di più il ciclo integrale ci si metteva in condizione di poter sfruttare, secondo le condizioni del mercato, la fonte più conveniente. Il Piano Sinigaglia, infatti, contemplava di mantenere una certa quota di produzione Finsider in stabilimenti basati sul rottame, per raggiungere un «equilibrato e elastico ricorso ai due processi produttivi fondamentali (minerale e rottame)». Si poteva lasciare più spazio ai produttori privati in particolari fasi della congiuntura, senza però rinunciare, da parte Finsider, a competere nel mercato dei prodotti finiti. Per sfruttare queste opportunità, insisteva Sinigaglia, occorrevano uno sforzo di innovazione tecnologica, la razionalizzazione dei costi e l’elevamento della produttività, un’ottima organizzazione aziendale, una forte capacità di iniziativa imprenditoriale, fiducia nell’espansione del mercato.
Importante, per il suo alto profilo tecnico e amministrativo, fu il gruppo dirigente che si strinse intorno a Sinigaglia. In particolare tre persone: il suo braccio destro e numero due Ernesto Manuelli, direttore generale Finsider dal 1945, che si occupava della parte finanziaria e tesseva la trama dei rapporti esterni con il mondo politico e istituzionale. Manuelli, già con Sinigaglia alla Sofindit, proveniva dal ministero degli Scambi e valute, dove era ispettore centrale, ed era stato collaboratore di Agostino Rocca all’Ansaldo. Gli ingegneri di punta fu...