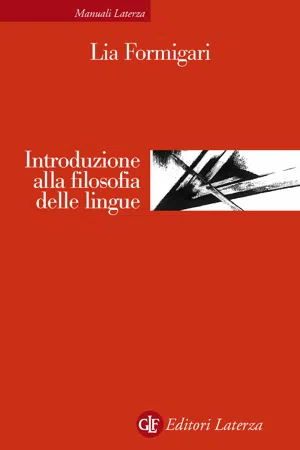
- 140 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Introduzione alla filosofia delle lingue
Informazioni su questo libro
Con una particolare attenzione orientata alla didattica, Lia Formigari introduce alla filosofia del linguaggio sotto il profilo delle pratiche linguistiche nelle lingue storico-naturali, discute i temi salienti del dibattito teorico attuale e ne enuclea i modelli teorici.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Introduzione alla filosofia delle lingue di Lia Formigari in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Philosophy e Linguistics. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
PhilosophyCategoria
LinguisticsII. L’origine della parola
«Natura di cose altro non è che nascimento di esse in certi tempi e con certe guise,
le quali sempre che sono tali, indi tali e non altre nascon le cose»
(Giambattista Vico, Scienza Nuova, 1744)
2.1. Filogenesi della parola: il modello della continuità
L’origine del linguaggio non è un problema linguistico, perché la linguistica non ha altro oggetto che le lingue bell’e fatte: può tutt’al più studiarne l’evoluzione, non la nascita, lasciando casomai quest’ultima questione alla filosofia. Questo dichiarava un linguista francese, Victor Henry, autore di un libro intitolato Antinomies linguistiques (1896), ben interpretando la tendenza della linguistica del tempo a delimitare rigorosamente l’oggetto teorico della sua disciplina. Ma l’assoluta incommensurabilità dei sistemi di comunicazione umana rispetto a quelli animali, e la peculiarità delle pratiche linguistiche, spiegano a sufficienza il fatto che il tema della glottogenesi sia uno tra i più persistenti in filosofia del linguaggio. Spesso la comunità dei linguisti ne ha preso le distanze: qualche volta nei fatti (come quando, con la nascita del comparatismo linguistico, l’attenzione si spostò piuttosto sulla genesi e storia di singole lingue e famiglie linguistiche), qualche volta con dichiarazioni esplicite, come quella che abbiamo visto. Il flusso dei contributi intitolati all’origine del linguaggio non cessò mai veramente, neppure nei decenni coperti dall’interdizione di cui Henry si fa interprete, anche se certo il numero degli scritti sull’argomento si ridusse a dimensioni neppure lontanamente comparabili con la ricchezza di saggi precedentemente prodotti dalla cultura illuministica e poi romantica. Ma dagli anni Novanta in poi il dibattito è ripreso, superando ogni possibile precedente con un’offerta sconfinata, e che non accenna a diminuire, dei titoli e siti dedicati all’argomento.
La sfida filosofica resta difficile da eludere. Si tratta di capire se Henry avesse ragione anche nell’affermare ch’essa non abbia davvero alcuna ricaduta sulla linguistica, o se origine e natura delle lingue non siano invece temi epistemologicamente correlati. In effetti, il suo inappellabile giudizio, pronunciato in tempi ormai lontani, sembra essere smentito oggi, e non solo sul piano quantitativo: le discussioni sull’origine del linguaggio rivelano sempre meglio il fatto che si tratta di un tema in vario modo pertinente all’epistemologia della linguistica, e non di un mero problema di antropologia filosofica o di filosofia della storia. C’è un punto dell’orizzonte teorico in cui il problema dell’origine del linguaggio tende a saldarsi con quello dell’origine delle lingue. Gli studi di genetica, accertando corrispondenze sconosciute in passato fra distribuzione di famiglie linguistiche e patrimonio genetico delle popolazioni, consentono oggi di cominciare a disegnare mappe, impensabili fino a pochi decenni fa, della filiazione delle lingue, e la cronologia delle migrazioni e gli studi demografici hanno un’importanza decisiva nella questione. Optare, ad esempio, per la monogenesi delle lingue può imporre alla ricerca linguistica compiti di ricostruzione d’una protolingua comune. Questo è avvenuto in forme diverse in tempi diversi: s’è identificata senz’altro la lingua madre con una delle lingue conosciute (l’ebraico prima, più tardi il sanscrito) o s’è avanzata, ancora di recente, l’ipotesi di una lingua comune non attestata ma di cui sarebbe possibile rintracciare elementi nelle lingue attuali. Il monogenetismo è stato la dottrina più antica e diffusa, alimentata e sostenuta nell’immaginario collettivo dell’Occidente dalla tradizione biblica. In favore della tesi poligenetica, d’altra parte, militano considerazioni non trascurabili. Se la comparsa di una organizzazione neurologica abbastanza complessa da consentire l’emergere di un’attitudine al linguaggio è ascrivibile a tempi assai più remoti, l’effettiva realizzazione di quel potenziale nella forma di quelle che noi chiamiamo lingue viene però ragionevolmente datata a sessanta-ottanta migliaia di anni fa. Questo collocherebbe la nascita delle lingue in un tempo successivo alle grandi migrazioni dei nostri antenati dalla comune culla africana. È una tesi sostenuta dal linguista francese Claude Hagège, e ha conseguenze importanti sia per la classificazione tipologica delle lingue, che le suddivide in base alla condivisione di tratti fonologici o morfosintattici, sia per la classificazione genetica, che ne stabilisce la parentela.
Negli Stati Uniti, la questione dell’origine del linguaggio è stata di recente molto dibattuta, principalmente nel contesto della giustificazione teorica o, al contrario, della confutazione dei princìpi fondamentali della linguistica generativa. Ha portato o sta portando a un riesame in alcuni casi radicale della teoria di Chomsky, ma anche a riformulazioni sostanziali del problema delle origini. Anche se ripercorre antiche tematiche filosofiche (prima fra tutte quella della misura in cui natura e cultura contribuiscono rispettivamente alla costituzione umana), il dibattito sull’origine del linguaggio viene oggi giustamente riabilitato nella sua valenza epistemologica.
Anche oggi, certo, benché sia arricchito da una incomparabile quantità di nuovi dati paleontologici, il dibattito si fonda in gran parte su un’archeologia di indizi più che di reperti. I reperti fossili ci possono informare circa le condizioni anatomiche che rendevano possibile l’emergere del linguaggio, non sulla sua effettiva insorgenza. Reperti di cultura materiale attestano stadi di vita associata, e rituali ad essa connessi, che difficilmente potrebbero essere stati raggiunti senza efficaci strumenti di comunicazione, ma che non ci dicono molto sulla effettiva capacità simbolica dei loro fabbricanti ed utenti. Alla parzialità dei reperti si deve supplire con dati provenienti dalla neurologia, dalla genetica, dall’osservazione dei sistemi di comunicazione animale e dei processi di acquisizione del linguaggio nei bambini. Tutti dati, peraltro, che possono, anzi devono, essere valutati alla luce delle diverse, spesso opposte, ipotesi di partenza.
Ma vale la pena di fare un passo indietro, visto che come dicevo il problema ha una lunga storia. Nel corso di questa storia, sotto diverse configurazioni si celano due modelli teorici ritornanti. Un primo modello postula la continuità evolutiva fra natura animale e natura umana e, nell’umano, la continuità funzionale fra competenze cognitive generali e competenza linguistica. Un secondo modello pone invece fra l’una e l’altra natura una cesura originaria e tende a separare la facoltà del linguaggio dagli altri dispositivi dell’intelligenza.
Il primo modello circola fin dall’età classica e rappresenta la nascita della parola a partire da voci emesse dapprima in modo spontaneo sotto la pressione di passioni e bisogni, e solo successivamente istituzionalizzate alla stregua delle altre invenzioni. È, oltre che continuista, gradualista: la nascita del linguaggio viene descritta come un processo attraverso il quale dalle primitive forme di comunicazione fatte di gesti, di espressioni vocali e fisiognomiche si passa ai segni sempre più ritualizzati e convenuti all’interno delle comunità umane. Le prime forme di comunicazione sono dominate dalle reazioni senso-motorie (le posture del corpo suscitate dai moti dell’animo, l’espressione del volto che tradisce quei moti), dalla deissi e dall’imitazione (il gesto che indica, il gesto che mima l’oggetto o la circostanza o passione, la voce che imita i suoni della natura nell’onomatopea). Sono puramente espressive, sintomatiche, fisio- e patognomiche, rivelano o tradiscono gli stati del soggetto; diventano comunicative solo in quanto vengono interpretate dagli astanti. Nel tempo, gesti e suoni, via via emancipati dal riferimento immediato ad oggetti o stati d’animo, vengono ritualizzati nelle arti della musica, della danza, della poesia, mentre le voci, sempre meglio articolate, acquistano maggior potere rappresentativo. La categorizzazione distingue classi di oggetti o eventi con nomi comuni che il soggetto rappresenta così nella loro generalità agli interlocutori e a se stesso, favorendo nell’interazione e nella riflessione l’esercizio del pensiero astratto. Di qui la nascita delle società politiche e l’invenzione delle arti del vivere, in breve la civilizzazione. Il gesto e l’espressione fisiognomica restano sistemi integrati col sistema verbale, anticipano o sottolineano parole e frasi, all’occorrenza le sostituiscono. Le metafore che popolano le lingue attuali testimoniano ancora la natura iconica delle prime forme espressive, la tendenza a generalizzazioni fantastiche e alla rappresentazione delle cose inanimate o astratte in sembianze animate e sensibili.
Questo modello conosce il suo momento di gloria nell’antropologia filosofica a partire dagli inizi del secolo XVIII (Vico). Depurato dei suoi aspetti più mitologici, connessi con l’idea della storia universale e delle sue leggi, viene utilizzato come ipotesi di lavoro in antropologia cognitiva (Condillac). La nascita del linguaggio verbale, conseguenza dell’interazione sociale all’interno di popolazioni dotate di un’organizzazione già sufficientemente complessa, viene considerato il discrimine tra l’esercizio di facoltà elementari, condivise con gli altri animali (memoria e immaginazione, sia pure vincolate all’attualità della percezione, e una qualche capacità simbolica), e quello delle facoltà superiori. Un rapporto di mutua incentivazione si instaura tra la lingua e i bisogni materiali dei parlanti, tra un’intelligenza simbolica sempre meglio articolata dal punto di vista morfosintattico e forme di organizzazione sociale e civile via via più complesse.
Il modello viene più tardi conciliato senza difficoltà con l’idea darwiniana di evoluzione, e costituisce ancora una base dell’attuale antropologia evolutiva. Precursori del linguaggio verbale, o condizioni per il suo sviluppo, vengono indicati nelle caratteristiche proprie degli ominidi. La posizione eretta libera gli arti anteriori dal peso del corpo e dalla deambulazione, e genera la manualità, che consente di costruire strumenti e di produrre gesti comunicativi. Rende il volto accessibile alla comunicazione fisiognomica e perciò all’interazione fra le menti. L’aumentato volume del cranio crea le condizioni anatomiche per lo sviluppo neurale. L’allungamento del tratto sopralaringeo consente l’articolazione della voce. La condivisione di esperienza articola la vita di gruppo in forme complesse, fondate sulla cooperazione e la divisione dei compiti.
Le soluzioni continuiste sembrano adattarsi bene, come si vede, a una posizione che non consideri il linguaggio come un tratto originario della natura umana, ma piuttosto come una tecnica della sua costruzione. Il modello biologico nel quale la maggior parte degli studiosi continuisti oggi si riconosce è ben rappresentato, ad esempio, dalla posizione di Gerald Edelman, autore fra l’altro di un libro tradotto in italiano col titolo Sulla materia della mente (1993). Condizione per l’emergere del linguaggio verbale sarebbe una coscienza primaria capace già di categorizzare i dati della percezione e organizzarli in mappe mentali, una coscienza che vediamo agire del resto anche nel comportamento degli animali superiori. Una coscienza di ordine superiore emergerebbe invece solo grazie all’evoluzione, nei primati, di una memoria concettuale sempre più ricca e, negli ominidi, di capacità fonologiche e di speciali aree cerebrali per la produzione, l’ordinamento e la memoria dei suoni linguistici.
Le posizioni continuiste attuali conoscono naturalmente molte sfumature e distinzioni interne, perfino nella misura in cui si attengono al modello darwinista classico oppure lo rielaborano, come spesso avviene, attenuandone gli aspetti di linearità e finalismo. Resta però il fatto che una ricerca orientata nella direzione di una continuità o saldatura adattativa tra comunicazione animale e parola umana, che a sua volta avrebbe influito per una sorta di co-evoluzione sulla conformazione della mente, tenderà a descrivere l’emergere del linguaggio umano articolato, capace di conferire alla specie vantaggi nell’accesso alle risorse e maggiore successo riproduttivo, come affinamento e potenziamento di facoltà e pratiche dell’intelligenza preverbale. Anche nelle sue versioni moderne, con diverse sfumature a seconda delle posizioni, l’ipotesi continuista rappresenta lo sviluppo del linguaggio astratto come derivato da forme di comunicazione elementari, costituite da vocalizzazioni come appunto i gridi d’allarme animali. Questi sono certamente dotati di una funzione comunicativa essenziale per il gruppo, ma non di un significato astratto; sono spontanei, cioè non appresi, e identici per tutti gli individui del branco. Di qui si svilupperebbe una protolingua costituita da un numero sufficiente di rappresentazioni simboliche corrispondenti a diversi tipi di oggetti. Queste rappresentazioni sarebbero i precursori delle rispettive parole (la rappresentazione dell’animale predatore diventa grido articolato d’allarme, e di lì nome del predatore...). Già la fase di protolingua consentirebbe una serie di comportamenti simbolici essenziali per la vita del gruppo: il potersi riferire a una cosa anche in assenza di essa è la condizione di ogni narrazione o previsione, consente l’affrancarsi progressivo dalla contingenza delle circostanze nella direzione di comportamenti sociali sempre più complessi e meglio coordinati.
Sulla base di questa ricostruzione, si può ipotizzare che la morfologia e la sintassi delle lingue si siano sviluppate, con la scoperta di relazioni tra simboli, a partire da primitive forme di espressione pre-sintattica che dovevano comunque consentire le correlazioni minime sufficienti a produrre enunciati elementari. L’interazione comunicativa avrebbe incentivato l’analisi del primitivo simbolismo fonico e gestuale fino a produrre la parola sintatticamente articolata. Sono evidenti, rispetto alla semplice capacità di segnalare un oggetto od evento, i vantaggi evolutivi offerti dalla capacità di verbalizzare la distinzione tra agenti di un’azione, i fini di un’azione, le sue cause e i suoi tempi ecc. Avere quella capacità significa poter narrare fatti avvenuti in passato ed altrove, a noi e ad altri, poter riferire i racconti altrui, e questo è un salto di qualità incomparabile nella trasmissione dell’informazione. Sappiamo che alcune scimmie sono in grado di differenziare il segnale di pericolo a seconda che il predatore sia un leopardo, un serpente o un’aquila, innescando così nel branco i meccanismi di difesa più appropriati. Su Homo sapiens sappiamo sicuramente meno che sulle scimmie attuali; è tuttavia presumibile che a un certo punto possedesse già un lessico più vario di quell’elementare semantica scimmiesca. È chiaro il vantaggio, in termini di sopravvivenza, tra saper emettere il segnale leopardo! e il poter comunicare ai compagni di branco le proprie esperienze in fatto di leopardi e quelle che abbiamo a nostra volta sentito riferire da altri. O scambiarsi previsioni sul comportamento dei leopardi. O – non ultimo – inventare storie di leopardi: per esorcizzare la paura, per spiegare, anticipare od elaborare gli eventi, per rappresentarne e nobilitarne gli attori. La narrazione diventa così strumento per scandire le opere e i giorni, e matrice dei miti fondativi delle società umane.
Infine, progettazione e previsione essendo le condizioni per la trasformazione dell’ambiente e queste condizioni essendo appunto incrementate, in modo incomparabile, dall’interazione comunicativa, la parola sintatticamente articolata può aver contribuito a generare la caratteristica propria di una popolazione umana: il fatto che quanto più dispone di strumenti tanto meno è costretta ad adattarsi all’ambiente ed è invece capace di modificarlo. L’avvento del linguaggio spiegherebbe dunque anche la trasformazione della specie da adattabile in adattante.
Quelli che anche gli antichi modelli continuisti avevano indicato come precursori del linguaggio articolato – il gesto, l’imitazione, la sinergia tra modalità percettive – tornano oggi a riproporsi in formulazioni non speculative o non puramente speculative. Alcuni autori hanno elaborato l’ipotesi che gesti dinamici si siano evoluti a partire dall’imitazione brachio-manuale e facciale fino all’imitazione vocale articolata. Altri risalgono, sulla base di una tassonomia dei gesti umani, a ‘primitivi’ gestuali comuni a umani e primati che costituirebbero una sorta di paleontologia del gesto, e propongono la tesi apparentemente paradossale che una lingua parlata sia essa stessa un sistema di gesti; che entrambe – lingua di segni e lingua di parole – si basino su un dizionario di base comune, il dizionario dell’attività neuromuscolare, cioè il gesto. Il parlato sarebbe insomma una sorta di gestire articolatorio, la struttura fonetica di un enunciato essendo un insieme di movimenti articolatori piuttosto che di configurazioni statiche. È una tesi che ha implicazioni importanti, prima fra tutte l’idea che la produzione di enunciati non viene pianificata a livello segmentale dal locutore né percepita come tale dall’ascoltatore, ma prodotta e recepita come struttura unitaria. È poi una tesi che tende a considerare primaria nella comunicazione la sinergia tra modalità diverse, uditiva, visiva e motoria.
Il ruolo dell’imitazione sembra essere rafforzato dalla recente descrizione di neuroni che si attivano sia quando il soggetto compie un’azione sia quando vede altri compierla. La primitiva scoperta di questi «neuroni specchio», com’essi furono denominati, fatta e resa pubblica da un gruppo di ricercatori tra cui Giacomo Rizzolatti e Vittorio Gallese, riguardava i macachi. Ma il fatto, a quanto pare accertato, che negli umani l’osservazione di azioni manuali attivi la cosiddetta area di Broca, area cerebrale elettiva per quanto riguarda il controllo del linguaggio, confermerebbe la continuità evolutiva tra il gesto e la parola, e indurrebbe a pensare che la specializzazione linguistica di quell’area derivi da un meccanismo preesistente, originariamente deputato alla produzione e al riconoscimento degli atti motorii. Il controllo volontario del tratto vocale implica l’osservazione e imitazione dei suoni altrui, la loro rappresentazione nei termini dell’azione necessaria a produrli. L’imitazione si conferma come dispositivo essenziale nell’interazione sociale, dove il senso e l’esito delle azioni iniziate dall’interlocutore devono essere anticipati intuitivamente per orientare e regolare in modo flessibile le proprie strategie operative e comunicative.
Un’altra antica ipotesi sembra tornare attuale: che la protolingua sia stata un simbolismo prevalentemente lessicale, privo di marcatori grammaticali atti a distinguere forme come singolare/plurale, presente/futuro ecc. o funzioni come soggetto/oggetto ecc., e incapace di strutturare gerarchicamente le proposizioni principali e subordinate in frasi complesse. In passato, in favore di questa ipotesi militava la convinzione che le lingue primitive rispecchiassero ancora questa povertà di dispositivi sintattici: una convinzione smentita poi dalla linguistica storica dell’Otto e Novecento, che ha contestato l’idea stessa di lingue primitive. Oggi, l’ipotesi di una progressione dalla protolingua alle lingue sembrerebbe confortata dal fatto che a quanto pare anche le lingue attuali subiscono un processo di grammaticalizzazione unidirezionale, dal lessicale al sintattico, con una graduale trasformazione di elementi lessicali o lessemi (nomi e verbi) in unità grammaticali o morfemi (affissi, verbi ausiliari ecc.).
Al centro del dibattito resta il confronto tra i sistemi di comunicazione dei viventi umani e non umani. Il continuismo sottolinea in proposito la larga condivisione di strategie e competenze. E non c’è dubbio che, singolarmente presi, i requisiti richiesti per il linguaggio – la competenza fonetica, la competenza referenziale, la libertà dallo stimolo, la capacità di categorizzare e di istituire inferenze, la capacità pragmatica di ‘leggere’ l’altrui pensiero, perfino la componenzialità – sono tutti più o meno condivisi da una o più specie di animali non umani. Sul piano fonetico, ad esempio, il controllo volontario del tratto vocale, che è la condizione per l’articolazione, è condiviso da alcuni uccelli. Alcune scimmie antropoidi possono essere istruite a riconoscere parole del linguaggio umano, il che implica la capacità di distinguere i suoni linguistici dai non linguistici. A quanto pare, anzi, alcune scimmie sud-americane batterebbero perfino i neonati umani nell’abilità di discriminare il ritmo rispettivo di lingue diverse. La capacità referenziale, cioè la capacità di designare cose e situazioni anche assenti, è condivisa da alcuni codici animali, come la danza delle api, che presenta una configurazione ad hoc per comunicare la localizzazione e la distanza di una fonte di cibo alle compagne di sciame. È già un esempio di quella associazione arb...
Indice dei contenuti
- Avvertenza
- I. L’intelligenza linguistica del mondo
- II. L’origine della parola
- III. Modelli di categorizzazione
- IV. Comunicare e comprendere
- V. A mo’ di conclusione
- Per saperne di più
- Riferimenti bibliografici