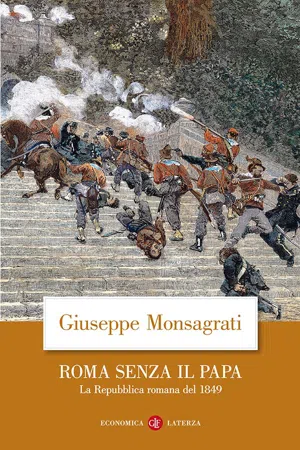V. L’inizio delle ostilità
«Gli italiani non si battono»
Solo all’apparenza simile alla Francia del primo Napoleone, la Francia del 1849, non potendo contare sulla stessa qualità di comando, ricorreva con frequenza a qualche machiavellismo. Appena sbarcati, i suoi uomini alzarono un albero della libertà, evocatore di antichi ricordi giacobini, e vi intrecciarono i due tricolori, ma non ci volle molto per capire che si trattava soltanto di una messa in scena. In verità, era una messa in scena che speculava sull’ambiguità della politica francese, orientata secondo i piani conservatori di Luigi Napoleone ma ancora condizionata da una certa forza parlamentare della Sinistra che rispecchiava il suo radicamento negli strati inferiori della società. Lo stesso Mazzini, pur consapevole di avere contro tutti i governi europei, il 30 marzo, il giorno dopo la nomina a triumviro, aveva chiesto al principe Gerolamo Napoleone Bonaparte, cugino di Luigi Napoleone che sapeva contrario alla spedizione, di dirgli quali fossero le reali intenzioni del governo di Parigi
Quindici anni dopo Mazzini ammetterà di avere coltivato in quei mesi una speranza: provocare, con la resistenza romana, «un mutamento nelle cose di Francia», e in tal modo offrire «un’opportunità ai membri della Montagna, ai nostri amici nell’Assemblea, d’iniziare la resistenza a Luigi Napoleone». Il proposito era obiettivamente un po’ troppo ambizioso perché sopravvalutava la volontà e le capacità combattive dell’opposizione transalpina e si fondava su una previsione errata del risultato delle imminenti elezioni politiche in Francia, fissate per il 13 maggio. D’altro canto, più realisticamente lo stesso Mazzini, sentendo avvicinarsi la tempesta, aveva lasciato intravedere nel suo rapporto del 24 aprile la disponibilità a un atteggiamento più conciliante, affermando che presto la Costituente, coerentemente con l’articolo 2 del decreto fondamentale, avrebbe definito «le guarentigie che possono assicurare al Pontefice il libero esercizio della sua autorità spirituale». E solo di essa. Perché, se c’era qualche potenza che riteneva indispensabile al papa una porzione di territorio per l’esercizio della sua autorità spirituale, ebbene, osservava Mazzini con inconsueta ruvidezza, questa potenza sarebbe «libera di dargli quel potere ma in casa sua» e senza esigere dai romani «che si tornasse addietro sopra una decisione fatta regolarmente».
Mentre da Roma fioccavano le proteste del Triumvirato, dell’Assemblea, del municipio romano e del circolo popolare di Civitavecchia, mentre alcuni cittadini francesi residenti in Roma, raccolti in un comitato presieduto da Gabriel Laviron, chiedevano a Oudinot di desistere da ogni forma di aggressione (e trovavano un’eco nella stampa rivoluzionaria d’oltralpe dove compariva un appello alla diserzione), i francesi non facevano in tempo a sbarcare che già prendevano prigioniero senza incontrare resistenza l’intero battaglione Mellara, lo disarmavano e mettevano la città portuale in stato d’assedio. Trattamento non molto diverso era riservato al battaglione dei bersaglieri lombardi – circa 500 – che, comandati dal milanese Luciano Manara, erano appena giunti in porto: Oudinot ne consentiva lo sbarco per poi catturarli e liberarli solo dopo aver loro imposto un impegno formale a non combattere prima del 5 maggio, che era la scadenza entro la quale era sicuro che sarebbe entrato in Roma. Era in lui una certezza che da tempo proprio i francesi avevano diffuso in tutta Europa, la certezza che «les italiens ne se battent pas», come aveva di recente ripetuto anche un personaggio relativamente ben disposto come il socialista Proudhon parlando di una «Italia troppo poco bellicosa». Mantenendo l’impegno di non combattere, Manara e i suoi, entrati in Roma il 29, gli avrebbero dimostrato che quanto meno sapevano mantenere la parola data (ma dal rapporto del ministro della Guerra romano risulta che, «ove il bisogno esigesse», Manara non avrebbe mancato di entrare in battaglia).
Quella frase – gli italiani non si battono – ripetuta più volte dagli stranieri, costituì per tutti coloro che erano accorsi a Roma, e per Garibaldi soprattutto, una di quelle provocazioni di cui ogni proposta politica ha bisogno per raccogliere simpatie e avere qualche probabilità di risultare vincente. Per la dirigenza romana non fu certamente il solo strumento propagandistico, perché l’apparato simbolico della Repubblica romana ne produsse molti altri, a opera di persone che come Mazzini, Mameli e in genere i repubblicani erano dei veri esperti di comunicazione. La bandiera tricolore recante spesso la scritta «Dio e Popolo», la stessa proclamazione delle leggi e dei decreti che si apriva con la formula «In nome di Dio e del Popolo», l’aquila e il fascio romano richiamati in vita nell’iconografia ufficiale come simboli di forza, lo stile classicheggiante dei proclami della Commissione delle Barricate enfatizzavano concetti che si imprimevano con forza nell’immaginario della popolazione, anche di quella meno politicizzata, facendo leva su emozioni e sentimenti sempre più diffusi: l’onore, l’orgoglio della propria origine, la difesa delle memorie avite, l’odio per i Galli invasori. La novità che così si produceva era quella di una crescente partecipazione della gente alla vita della città già a partire dal rito del voto: ovviamente non tutti, ma molti cominciavano a sentirsi parte dei processi decisionali attraverso i quali si concretizzavano il progetto repubblicano e l’aspirazione a fondare la nazione.
Garibaldi: una risorsa e un problema
Nella Capitale, pur tra tanti dubbi sul che fare, ci si era già cominciati ad attrezzare per la difesa, che era comunque impresa ardua, viste le magre finanze della Repubblica e l’ampiezza del territorio da difendere contro quattro possibili invasori. Il Triumvirato aveva allertato per tempo la Commissione di guerra che aveva dislocato le forze disponibili privilegiando come fulcro difensivo dello Stato, secondo quanto proposto da Pisacane, la zona di Terni, in modo da opporsi alla temuta avanzata austriaca: così il 14 aprile si era spedito a Bologna una divisione comandata da Luigi Mezzacapo; il 24 erano state prese misure per affidare a Livio Zambeccari la città di Ancona con ordine di resistere a tutti i costi; lo stesso giorno Pisacane, in qualità di sostituto di Giuseppe Avezzana, ministro della Guerra, aveva inviato a Garibaldi, che stazionava ad Anagni, l’ordine di convergere su Roma in vista di un eventuale attacco francese; il 25 ancora Pisacane aveva comunicato a Mazzini tutte le disposizioni prese, inclusa quella di «fortificare il Gianicolo e le vicinanze di Roma». Il problema vero era a monte, e nasceva dalla cronica penuria di armi e dalla scarsissima affidabilità di quelle disponibili. Si suppliva con l’entusiasmo dei volontari che ormai affluivano quotidianamente, anche dall’estero; si poteva anche contare sullo spirito combattivo delle popolazioni, forse meno fredde che all’inizio, ma restava il fatto che Enrico Dandolo, appena entrato in Roma, non poteva che segnalare «grande prodigalità di coccarde e nastri, di sciarpe e di bandiere; fucili inadatti e diversi e pugnali e pistole di tutte le fogge». Non c’era nemmeno una totale omogeneità ideologica, ma questo era un punto a favore, almeno sotto il profilo del pluralismo: Dandolo, Manara, la stessa Belgiojoso erano monarchici, ai garibaldini che incontrandoli gridavano Viva la Repubblica rispondevano con un Viva l’Italia!. Appunto Manara preciserà di avere a cuore l’onore dell’Italia e non una Repubblica guidata da personaggi come Mazzini e Cernuschi; verso Mazzini anche la Belgiojoso avrà, nella sua corrispondenza privata, parole molto sprezzanti dettate da un senso di superiorità assolutamente ingiustificato così sul piano politico come su quello morale, e ancor meno su quello intellettuale.
A cose finite affiorerà tra le pieghe della memorialistica un’altra questione che conviene qui anticipare e che riguarda da un lato alcuni conflitti di personalità che non giovarono alla causa repubblicana, dall’altro le scelte strategiche adottate dal Triumvirato, accolte talvolta con qualche borbottio che dopo la caduta si tramuterà in una critica esplicita a Mazzini. Al centro di entrambe le questioni si stagliano per autorevolezza, a parte Garibaldi di cui vedremo più avanti i motivi di dissenso, le figure di Carlo Pisacane, ex ufficiale borbonico formatosi alla Nunziatella e non ancora approdato nel ’49 alle concezioni socialiste della maturità, e di Felice Orsini, il futuro attentatore di Luigi Napoleone. Molto stimato professionalment...