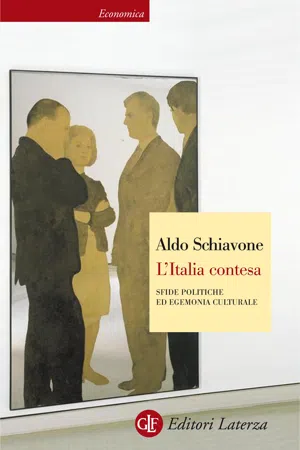la nuova politica
1. Il leader della transizione italiana è diventato oggi il solo ostacolo al suo definitivo compimento. La normalizzazione della nostra politica non aspetta che la sua uscita di scena per potersi concludere.
Un giudizio così netto è inevitabile, se le cose stanno come abbiamo cercato di descriverle. Tutto quello che ha integrato il «dispositivo Berlusconi» ci rimanda a un contesto che si sta ribaltando rovinosamente su se stesso. L’esaltazione dell’anomia capitalistica, l’apologia incondizionata del mercato, la vocazione antistatalista, l’idea di un popolo decostruito sino alla completa frantumazione, l’attualità del richiamo anticomunista; perfino l’alone di irresistibilità che ha circondato il sovrapporsi abnorme fra imprese e governo: ogni aspetto di quel meccanismo ci richiama a uno sfondo da cui ci stiamo staccando.
La vittoria elettorale del 2008 – favorita peraltro da una breve e disastrosa esperienza di centrosinistra, il cui fallimento andrebbe analizzato con attenzione – è arrivata, appena in tempo, a suggellare il primato su un intero ciclo storico: ma è un punto terminale, l’esaurirsi estremo di una parabola, che non può allontanarci da una valutazione obiettiva del quadro che intanto sta prendendo corpo innanzi a noi.
Quindici anni fa Berlusconi aveva colto al volo – lo abbiamo visto – un’occasione straordinariamente favorevole; ha poi condotto a lungo le danze, dal governo come dall’opposizione, e ha avuto un’opportunità per incidere davvero sul Paese: sfruttarla sarebbe stato comunque difficile, tenuto conto delle alleanze e del contesto – e poi perché è nello stile della storia d’Italia non concedere mai troppo a chi vuol cambiarla davvero – e perciò non ha saputo, o potuto, approfittarne. Dopo ha vinto ancora, di nuovo utilizzando una circostanza estremamente propizia, e sta reggendo sull’onda dell’ultimo consenso, inseguendo il miraggio di una «istituzionalizzazione» definitiva del proprio carisma. Ma già i suoi ministri migliori parlano un’altra lingua, e hanno in mente un Paese diverso. Certo, la fascinazione di cui è capace resta forte, per una specie di automatismo della memoria che impiega tempo a operare i suoi disinvestimenti simbolici, ed egli non rinuncia ai suoi tentativi di rimanere il padrone esclusivo del comando politico. La strada del declino è ormai tracciata.
La situazione si sta infatti completamente capovolgendo: prima con il ritorno di antiche paure, in un clima sempre più impregnato di stanchezza, di disillusione e di affanno, con strati di incertezza e di ansia che nessun ottimismo di maniera riesce più a sciogliere; poi con il precipitare di una crisi di portata imprevedibile, che ci sta scuotendo dalle fondamenta, e da cui non sappiamo ancora come e quando usciremo.
La recessione, prima ancora che modificare il tessuto sociale del Paese, comincia a ridisegnarne il profilo mentale. E per la prima volta da quando è entrato in politica, si sta determinando uno scenario che mette Berlusconi fuori sintonia rispetto alla maggioranza degli italiani, a quel «suo» popolo cui ha saputo finora rivolgersi con tanto successo. Quanto sta accadendo oltrepassa completamente la sua visuale; è antropologicamente al di là della sua comprensione. Egli non è il leader per una stagione il cui primo obiettivo è di non diventare un’epoca d’angoscia. Non ha nemmeno le parole per dirlo – a che rischio siamo esposti, e quali minacce ci sovrastano. Non ha nessuna capacità di cogliere l’aspetto drammatico e discontinuo della vita (una mancanza che in un altro momento ha contribuito alla sua riuscita). La performance nella quale si è interamente calato, corpo e anima, fino a tramutarsi nella rappresentazione simbolica di se stesso – la statua vivente della sua fortuna, del suo vitalismo, del suo calore emotivo, della sua capacità di sedurre per persuadere – si sta sbiadendo, e morde sempre meno. È uno spettacolo che non ha avvenire.
2. Il problema che abbiamo di fronte è innanzitutto culturale: riguarda le idee, le strategie, gli stati d’animo, e non tocca certo solo l’Italia. Ed è una questione di misura – di una misura nuova, difficile da conquistare.
Essa attiene, in sostanza, al rapporto che la nostra civiltà vuole stabilire fra potenza e ragione: fra i grandi poteri del nostro tempo – la scienza, la tecnica, la finanza, il mercato – e la razionalità che siamo capaci di immettere nella trama complessiva del nostro universo sociale. Ed è esattamente di questo che ci parlano le difficoltà che stiamo vivendo.
La sfida è totale. E a dare una risposta sarà chiamato l’insieme delle classi dirigenti del pianeta (non sorprenda questa espressione, dovremo farci presto l’abitudine), ovunque si trovino – anche se per ora la massima concentrazione, e quindi la maggiore responsabilità, è in America e in Europa. Esse dovranno imparare a pesare e valutare la sconfinata forza trasformatrice delle nostre tecnologie e delle nostre economie – rispetto all’ambiente, alla natura, alla forma sociale e politica del mondo – e a padroneggiarla, piuttosto che lasciarsene solo condizionare. Il nostro futuro dipende dalla rapidità di questo addestramento; e la crisi che stiamo attraversando è insieme un’occasione e un segnale.
Da oltre vent’anni il mondo è entrato nella terza rivoluzione tecnologica della sua storia – dopo quella agricola e quella industriale – e l’impatto ha innescato conseguenze di cui ancora non ci rendiamo ben conto. Probabilmente, ha avuto un peso decisivo anche nella fine del comunismo e nel definitivo disintegrarsi dell’impero sovietico, entrambi diventati improvvisamente fossili inservibili nel mondo che si stava preparando.
La fuoriuscita dall’età industriale – dalla pesantezza della produzione di merci materiali come unico indicatore della ricchezza sociale – ha dato alle economie dell’Occidente una sensazione di leggerezza e di onnipotenza che non avevano mai prima provato. Cadevano vincoli e confini secolari, che erano parsi insormontabili. Le nuove tecniche, esse stesse immediatamente sotto forma di merce, e le nuove produzioni – informazioni, conoscenza, servizi – spingevano verso una mondializzazione dei mercati e una dematerializzazione dell’economia sempre più veloci e capaci di autosostenersi. Il settore industriale classico era confinato in un comparto secondario e marginale, come a suo tempo lo era diventato quello agricolo sotto la pressione dell’allora incalzante sistema di fabbrica.
La dimensione «astratta» del capitalismo – quella stessa genialmente analizzata da Marx – subiva un’accelerazione strepitosa. Astrazione non più soltanto rispetto al lavoro umano o alle merci materiali, ma alla stessa forma del denaro – astrazione dunque di un’astrazione – ridotta a non rappresentare più niente se non una virtualità finanziaria che avendo già preteso d’inglobare nel proprio calcolo l’insieme della vita, si poneva in rapporto unicamente con se stessa, con le sue previsioni e con le sue manovre, in un perenne corto circuito fra innovazione e mercato. Ed è stata proprio questa contabilità fantasmatica – sospesa fra la realtà della sua astrazione e la virtualità delle sue strategie speculative – ad alimentare la gigantesca ondata di avidità e di consumi che alla fine ci ha travolto, partita là dove la rivoluzione era cominciata: dal cuore della società americana.
Riconosciamolo subito, però: vi è, nella configurazione di funzioni, di poteri e di relazioni che ha avvolto in questi anni il pianeta, molto da cui non si torna più indietro: un elemento profondo di razionalità che indica una direzione della storia. Il salto tecnologico è inarrestabile, e subirà probabilmente ulteriori accelerazioni, verso traguardi che già cominciamo a intravedere. Il rapporto fra tecnica e mercato, annodati in un vortice di rivoluzione permanente – un’integrazione ad alta intensità che coinvolge l’insieme dell’organizzazione produttiva – è il più straordinario motore di sviluppo che la storia dell’umanità abbia mai saputo mettere in campo, ed è oggi insostituibile; e lo sarà, verosimilmente, per molto, prima che le stesse conquiste tecnologiche possano rendere ipotizzabile una diversa creazione e distribuzione della ricchezza sociale. E dal canto suo, anche la globalizzazione delle dinamiche economiche ha raggiunto un livello dal quale sarebbe impensabile retrocedere: il mondo è davvero diventato un mondo «piatto».
Si tratta di un’irreversibilità che non deve spaventare. Perché non sono queste tendenze ad averci portato nella tempesta in cui siamo. Anzi, esse si rivelano con sempre maggiore chiarezza come il risultato ricco di promesse di un percorso in cui si riflette il destino stesso della nostra specie.
Il lato oscuro si annida invece in un clamoroso errore che abbiamo commesso – dal quale sì, che si può e si deve retrocedere. Ed è consistito nel non esserci resi conto che la potenza della macchina che avevamo predisposto era pari alla sua pericolosità, e le sue prestazioni non minori dei suoi rischi. Nella colpevole sopravvalutazione, cioè, della capacità autoregolatrice dell’insieme dei processi che si erano innescati, una volta abbandonati – come noi li abbiamo lasciati – alla loro spontaneità incontrollata. Nel misurare in modo sbagliato quanta intrinseca progettualità sociale essi fossero in grado di sprigionare, nelle condizioni storicamente date, e quanta capacità avessero di proteggere le loro stesse costruzioni (il mito dell’«ordine spontaneo», esaltato da von Hayek). Insomma, nell’aver fatto troppo affidamento sulla bontà senza riserve di un paradigma liberista che la cultura della neodestra mondiale ha sùbito trasformato nella sua bandiera, e nel cui nome ha ottenuto grandi vittorie.
Ha pesato di sicuro in questo abbaglio – che l’America ha esportato nel resto del mondo – la presenza di un’eredità ideologica assai vincolante, di un’interpretazione della storia che il crollo del comunismo spostava tutta dal lato di un’apologia acritica del mercato, della sua «mano invisibile», dei suoi «spiriti animali» e della sua «magia» di reaganiana memoria. E ha contribuito anche la spinta endogena della nuova economia a liberarsi ovunque possibile di vincoli e di parametri precostituiti (ne abbiamo accennato), a operare in un terreno massimamente deregolato, per poter imporre i propri ritmi e i propri contenuti. Anche l’avvio della rivoluzione industriale fu segnato del resto, nell’Inghilterra fra Sette e Ottocento, da una pressione simile: tutta la teoria economica classica, da Smith a Ricardo, fino allo stesso Marx, ha lavorato nel fuoco di questa febbre. Che ogni decollo tecnologico debba necessariamente comportare una sua stagione di «capitalismo selvaggio» sembra quasi, ormai, una regolarità nella storia del mondo moderno, una specie di legge tendenziale del suo sviluppo.
Ma soprattutto ha influito, nel provocare l’errore, l’idea – diffusasi rapidamente in tutto l’Occidente almeno dagli inizi degli anni ottanta del Novecento – che la politica, qualunque politica, prigioniera come si ritrovava di forme statali ormai obsolete, fosse diventata una figura regressiva, una forma depotenziata e scaduta, rispetto ad altre forze molto più in grado di incidere sul profilo del nostro futuro: la stessa tecnica, il mercato, le soggettività individuali e d’impresa, se lasciate padrone di agire e di decidere per il meglio, e cioè secondo i propri interessi particolari.
È stato lo scacco della politica come luogo di formazione per eccellenza dell’interesse generale e del bene comune (abbiamo detto prima di una sua «stanchezza») a consentire negli ultimi decenni alle grandi reti della tecnoeconomia di disegnare in solitudine la forma civile e naturale del mondo: l’aver essa accettato di rinchiudersi in una funzione in qualche modo secondaria, subalterna, di puro assecondamento rispetto a scelte e decisioni prese altrove, sulla base di criteri senza trasparenza, dominati dall’opacità di poteri che non avrebbero mai dovuto rispondere alla collettività del loro operato.
Nel non aver arginato a sufficienza questo ridimensionamento ha avuto la sua parte – e ora non possiamo fingere di dimenticarlo – un elemento di incontestabile realismo. La politica percepiva che il suo declino dipendeva dalla perdita effettiva di qualcosa di essenziale: il controllo sulle grandi opzioni alla base delle forme sociali della vita. Queste erano ormai costruite altrove, e apparivano come non più contendibili. L’avvio della globalizzazione stabiliva dovunque rapporti esclusivi tra soggettività sociali, innovazioni tecnologiche e sviluppo dei mercati, attraverso circuiti la cui densità non lasciava spazio ad altre presenze. La politica arrancava dietro, emarginata da una trasformazione che tendeva continuamente ad escluderla, e ne riduceva comunque opzioni e spazi, vincolandoli a una rete di condizionamenti e di variabili del tutto al di fuori della sua portata; e tutto ciò proprio mentre le franavano intorno i grandi sistemi ideologici di riferimento messi a punto fra diciottesimo e ventesimo secolo, e non sapeva come e con cosa sostituirli.
Nell’età delle Rivoluzioni – dall’americana alla francese, alla sovietica, e poi a quella cinese – la politica era stata universalmente percepita come il principale elemento di trasformazione della vita e del mondo, e aveva concentrato intorno alle sue pratiche un potere enorme e una capacità di mobilitazione senza precedenti, durati in Europa almeno sino agli anni settanta del secolo scorso: in parte rifluito nei congegni infernali delle grandi dittature del Novecento, dove tutto era politica, e dove la celebrazione della sua pervasività avrebbe raggiunto la sua fosca apoteosi.
Ma quella stagione si era ormai conclusa già prima del crollo del comunismo. E il definitivo esaurirsi del mito della Rivoluzione in Occidente, se da un lato coincideva con la vittoria della democrazia nella sua classica forma liberale, aumentava d’altra parte la caduta di credibilità della politica come principale fattore del cambiamento – attraverso di lei sembrava non passasse ormai più nulla di decisivo – e finiva con il seg...