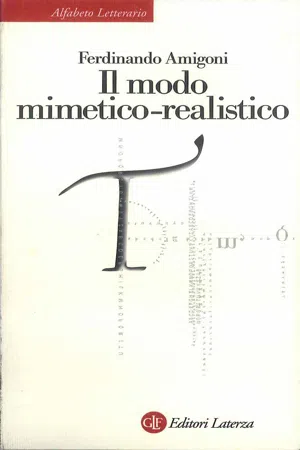1.
Realtà, verosimile, finzione
Realismo come modo e come genere
Parlando di un romanzo, di un film, di una rappresentazione teatrale, o magari di un dipinto, capita spesso di ricorrere ad aggettivi come «epico», «fiabesco», «idillico», «realistico», «comico», «tragico», «satirico», ecc. Esistono dunque costanti che attraversano i generi propriamente detti. Un autore è infatti libero di adottare le convenzioni di un genere o di ibridare generi diversi: in entrambi i casi tuttavia, sprovvisto com’è del potere divino di creare dal nulla, non può non utilizzare materiali già esistenti e fortemente connotati. Si è convenuto, accogliendo la proposta terminologica del critico canadese Northrop Frye (1912-1991), di chiamare «modi» tali costanti che consentono tra l’altro, anche al lettore (o allo spettatore) meno informato, una prima, elementare definizione di ciò che ha davanti agli occhi.
Il modo di cui qui si tratta è il modo mimetico-realistico: se il primo aggettivo della coppia deriva dal greco mímesis, «imitazione» o meglio «rappresentazione», il secondo deriva da res, parola che in latino significava «cosa», «oggetto». Siamo alle prese con i problemi di enorme portata filosofica e tuttora aperti, dopo venticinque secoli (almeno in Occidente) di indagini, connessi al rapporto tra parola letteraria, e dunque irreale, finzionale per definizione, e realtà. Essendo reperibile in qualche misura in tutti i generi letterari (non esistono testi letterari a grado zero, per quanto riguarda il realismo: se ne trova sempre qualche traccia), il modo realistico è assai più ampio del realismo inteso come genere narrativo, tipicamente rappresentato dal canone del grande romanzo ottocentesco. Tenterò di descrivere brevemente alcune delle più importanti proposte teoriche che hanno preso le mosse dalle seguenti, tutt’altro che timide domande: «Che rapporto c’è, ammesso che un rapporto vi sia, tra gli oggetti nominati dalla letteratura e la realtà»?, «Come può un testo letterario dare l’illusione di parlare della realtà»?, o più ottimisticamente: «Come può un testo letterario parlare della realtà»? Da qui a interrogarsi sul rapporto tra linguaggio e mondo il passo è breve: mi dispiace ammettere che non sarà possibile esimersi del tutto dal compierlo. Vedremo poi qualche esempio di narrazione realistica, scelto con quel larghissimo margine di arbitrio necessario per contenere un discorso di per sé quasi privo di confini e certamente interminabile.
La mimesis in Aristotele
Probabilmente verso il 330 a.C. il filosofo greco Aristotele (384/383-322 a.C.) scrive il suo trattato sulla Poetica che, tradotto in latino nel XIII secolo, diventa il testo canonico per eccellenza della riflessione sulla parola letteraria, e tale rimane a tutt’oggi.
Dopo avere enumerato vari generi letterari, tra cui i più importanti sono il poema epico, la tragedia e la commedia, Aristotele precisa che tutti questi generi sono «imitazioni» (miméseis) di «persone che agiscono». Il lettore non fatica molto a rendersi conto che «imitazione» (mímesis) è un termine che ricorre con altissima frequenza nel testo. Aristotele stila tipologie dei temi («azioni» nel testo greco) e dei personaggi «imitati» da tragediografi, commediografi e dall’autore epico più venerato al suo tempo, Omero; ciò che qui interessa precede tuttavia ogni possibile casistica.
È stato più volte osservato che Aristotele non delimita con rigore il concetto di mímesis; in realtà, si potrebbe anche affermare che nel corso del suo trattato non faccia altro che circoscrivere progressivamente il campo semantico del termine. Cosa intende Aristotele quando parla di «imitazione»? Il poeta imita nel senso che copia un modello esistente in natura, misurando il grado di perfezione della propria opera sulla somiglianza con il modello, o piuttosto imita creando un oggetto artificiale conforme in qualche modo a qualcosa che potrebbe esistere in natura? E ancora: il poeta vuole creare l’illusione di un frammento di realtà simile a quelle ingannevoli nature morte chiamate trompe-l’oeil, o vuole che lo spettatore (l’ascoltatore, il lettore) abbia coscienza di trovarsi davanti a un prodotto dell’arte umana? Insomma: mímesis come simulazione (con tutte le connotazioni negative che sempre accompagnano la simulazione) o come rappresentazione?
Compito del poeta non è dire le cose avvenute, ma quali possono avvenire, cioè quelle possibili secondo verosimiglianza o necessità. Lo storico e il poeta [...] si distinguono invece in questo: l’uno dice le cose avvenute, l’altro quali possono avvenire. Perciò la poesia è cosa di maggiore fondamento teorico e più importante della storia perché la poesia dice piuttosto gli universali, la storia i particolari.
Il poeta non copia nulla che esista effettivamente nel mondo fenomenico, non descrive per accumulazione i «particolari» che preleva dalla realtà, non cerca di ingannare gli spettatori (o i lettori) chiedendo loro di credere senza alcuna mediazione nella realtà di quanto dice; costruisce viceversa strutture verbali dotate di significato «universale». Aristotele ravvisa nell’opera poetica un peculiare valore conoscitivo (un «fondamento teorico», nientemeno). Oggetto del poeta sono «le cose» «possibili secondo verosimiglianza (eikós) o necessità (anankáion)». Se proprio dello storico è il compito di raccontare fedelmente le «cose avvenute», il poeta opera in modo assai diverso. Per raggiungere il proprio scopo, il poeta deve costruire racconti saldamente strutturati secondo principi di unità e di coerenza logica. Privi di elementi accidentali, chiusi alla casualità sempre presente nel mondo reale, i racconti dei poeti vanno dunque giudicati secondo criteri di coerenza interna e di adeguamento agli scopi propri dell’arte verbale. Allo stesso modo non è lecito criticare un pittore perché ha dipinto, l’esempio è di Aristotele, una cerva con le corna; ciò che importa è la capacità rappresentativa (mimetica) di cui il pittore deve dare prova: le eventuali sue mancanze in fatto di precisione zoologica non riguardano i principi e i fini dell’arte figurativa. Attraverso la necessità logica (anankáion) di un inizio («ciò che esiste senza venire necessariamente dopo qualcosa d’altro, ma dopo cui qualcosa d’altro necessariamente o per lo più c’è o si produce») e di una fine («ciò che esiste necessariamente o per lo più dopo qualcosa d’altro, e dopo cui non c’è null’altro»), il creatore di racconti mette insieme una ben delimitata sequenza significativa, scegliendo alcuni elementi dall’infinita e casuale massa di fenomeni che compongono la realtà o dall’insieme caotico della propria memoria storica, e la propone con un duplice fine estetico e conoscitivo al pubblico. La grandezza di Omero consiste anche, secondo Aristotele, nell’avere evitato di rappresentare interamente la guerra di Troia: il poeta, lo si è visto, non deve fare concorrenza allo storico.
Il nodo centrale del discorso è senza dubbio la nozione di «verosimile» (eikós). Anzitutto, e sembra un paradosso, il verosimile è categoria precedente e superiore al vero, a ciò che è realmente accaduto: il poeta, se gli occorre, può anche narrare fatti storici; dopotutto, precisa imperturbabile Aristotele, può capitare che tra i fatti realmente accaduti ve ne siano di verosimili. Il verosimile è ciò che accade «per lo più», ha dunque a che vedere con il possibile e il probabile, all’interno, diremmo oggi, di un sapere condiviso da autore e lettori. Il verosimile è una categoria a tale punto primaria, che Aristotele, pur di salvaguardare l’autonomia dell’arte, è disposto a sfiorare la contraddizione. Per motivi di coerenza ed economia narrativa infatti, può capitare che il poeta debba ricorrere al «meraviglioso» (thaumastón) (interventi di dei, incongruenze nella distribuzione dei saperi, comportamenti assurdi di alcuni personaggi), ovvero al soprannaturale e all’illogico: ma se il poeta non può talora fare a meno di ricorrervi, «si deve preferire l’impossibile verosimile al possibile incredibile». Si noti che il carattere fondativo del verosimile porta il padre della logica a parlare di «impossibile verosimile»: il lettore non può non avvertire i primi sintomi di quel disturbo che un filosofo del Novecento ha definito «crampo mentale».
Perché il verosimile ha una posizione tanto centrale nella Poetica? Semplicemente perché senza verosimile l’opera poetica non funziona. Senza verosimile non è possibile, secondo Aristotele, quell’identificazione dello spettatore (o del lettore) con l’eroe, che porta il primo, attraverso il noto processo emotivo («pietà e paura»), alla «depurazione (kátharsis) di siffatte emozioni». L’opera poetica unisce all’alto valore conoscitivo un valore catartico, anzi, il valore conoscitivo dell’arte è peculiare e insostituibile proprio perché inscindibile dal processo catartico.
Due cause appaiono in generale aver dato vita all’arte poetica, entrambe naturali: da una parte il fatto che l’imitare è connaturato agli uomini fin dalla puerizia (e in ciò l’uomo si differenzia dagli altri animali, nell’essere il più portato ad imitare e nel procurarsi per mezzo dell’imitazione le nozioni fondamentali), dall’altra il fatto che tutti traggono piacere dalle imitazioni.
«Nozioni fondamentali» e «piacere», dunque; l’arte poetica come gioco mimetico per adulti, radicato in quanto è proprio dell’uomo rispetto agli animali: l’imitazione. Anche se tra le varie categorie sussiste una qualche circolarità, una possibile catena concettuale della Poetica potrebbe essere la seguente: mímesis > verosimile > universale > identificazione > piacere/catarsi > conoscenza. Sarebbe forse lecito chiedersi quali «nozioni fondamentali» apprenda chi segue le vicende rappresentate sul palcoscenico da attori che dicono di chiamarsi Edipo e Giocasta. Perché la mímesis raggiunga i suo scopi, perché uno scambio di «nozioni fondamentali» abbia luogo, lo spettatore deve sviluppare capacità complesse (ma è un dovere, lo si è visto, connesso in diversi modi al piacere estetico): interpretare strutture verbali di estrema densità semantica, comprendere un racconto dotato di consequenzialità logica, unità e completezza, ritrovare un frammento della propria memoria culturale (una storia antica ritenuta vera nelle sue linee essenziali), reperire in se stesso aspetti che lo accomunano all’eroe, condividere i valori – il laico Aristotele ne è certo – della «saggezza» (phrónesis) necessaria alla felicità individuale e alla prosperità della polis, i valori di cui il filosofo parla nei suoi trattati sull’Etica e sulla Politica.
Il realismo e la storia: Lukács e Auerbach
Non sempre i critici e i teorici della letteratura hanno discusso di mimesis con la chiarezza concettuale di Aristotele. Nei testi di György Lukács (1885-1971) e di Erich Auerbach (1892-1957), autori di opere imprescindibili sul realismo letterario, il generico termine «realtà» ricorre senza definizioni preliminari così spesso che il lettore rischia di perdere di vista le abissali differenze che esistono tra un romanzo e il mondo esterno.
«È ben difficile guardare negli occhi la realtà qual essa è veramente, e nessuno ci riesce di primo acchito. Ciò comporta non soltanto una grande fatica, ma anche un serio sforzo morale». La pretesa di guardare negli occhi la realtà, con cui si aprono i Saggi sul realismo di Lukács, non appare oggi più ingenua di quanto dovette apparire nel 1946, nell’anno cioè della sua formulazione. Ma al Lukács convertitosi al marxismo non interessano astratti problemi epistemologici. Il suo discorso prende le mosse da tre postulati: a) la realtà è oggettivamente conoscibile, b) la realtà è un insieme fluido di forze so...