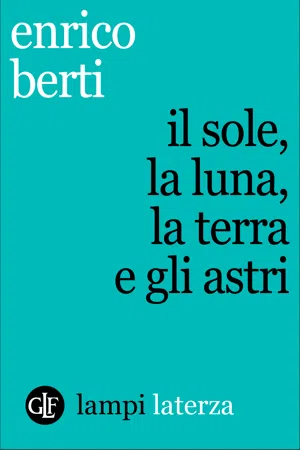
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Il sole, la luna, la terra e gli astri
Informazioni su questo libro
Per spiegare i fenomeni celesti osservati a occhio nudo quali movimenti bisogna ipotizzare che gli astri compiano? Da questa domanda, posta da Platone ai suoi discepoli, nasce la discussione sui moti dei pianeti dei primi grandi filosofi greci, dalla teoria dei sette cieli, all'universo a due sfere. Teorie che uniscono la 'matematica pura' alle interpretazioni filosofiche, alle volte antropomorfizzanti, degli elementi celesti.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Il sole, la luna, la terra e gli astri di Enrico Berti in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Philosophy e Philosophical Essays. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
PhilosophyCategoria
Philosophical EssaysIl sole, la luna, la terra e gli astri
1. Il Sole, la Luna e gli astri
Platone – come dice Sosigene – pose a coloro che si erano occupati di queste cose il seguente problema: quali movimenti uniformi e ordinati conviene assumere come ipotesi (hupotetheisôn) per “salvare” i fenomeni (diasôthê ta [...] phainomena) concernenti i movimenti dei pianeti?1
Un grande scienziato e storico della scienza, Pierre Duhem, ha visto in questo passo, definito con estrema nettezza, lo scopo dell’astronomia, e parimenti di ogni teoria scientifica: formulare ipotesi che spieghino nel modo più semplice possibile fenomeni, cioè dati di osservazione, estremamente complessi. Nella fattispecie si tratta di ipotizzare dei movimenti circolari e uniformi, destinati a produrre, mediante la loro combinazione, un movimento simile al moto degli astri. Quando le costruzioni geometriche di una teoria assegnano a ciascun pianeta un percorso conforme a quello rivelato dalle osservazioni, lo scopo della teoria è raggiunto: “salvare le apparenze” (phainomena, in greco, significa infatti “le cose come appaiono”)2.
Il passo sopra riportato deriva – come il suo stesso autore, cioè Simplicio, segnala – da un’opera di Sosigene, filosofo e astronomo del II secolo d.C., che fu maestro di Alessandro di Afrodisia. Ma Sosigene lo ha ripreso dalla Storia dell’astronomia di Eudemo di Rodi, discepolo immediato di Aristotele, che probabilmente ne aveva udito il racconto dalla viva voce del maestro. Nessuno ha mai dubitato della sua autenticità, perché esso da un lato è espressione del pensiero di Platone, quale risulta dai suoi dialoghi, e dall’altro corrisponde perfettamente a ciò che tutte le testimonianze antiche riferiscono sul modo di operare di Platone nell’Accademia. Esso sta alla base delle prime grandi teorie astronomiche sviluppate nell’antichità greca, le quali nacquero tutte per rispondere alla domanda di Platone.
Recentemente un celebre studioso di Platone e dell’Accademia, Konrad Gaiser, è riuscito a ricostruire la scena in cui Platone pose il suddetto problema ai suoi scolari e collaboratori. Il mosaico che si trova nel Museo Archeologico di Napoli, in cui sarebbe rappresentata la scuola di Platone (fig. 1), per molto tempo esso era stato considerato una rappresentazione dei Sette Sapienti, ma Gaiser con fine intuito e solidi argomenti, che hanno convinto tutti gli studiosi, è riuscito a dimostrare che esso non solo rappresenta l’Accademia, ma ne rappresenta precisamente il momento in cui Platone pose ai suoi amici il problema di “salvare i fenomeni” del movimento dei pianeti3. Che la discussione tra i sette personaggi rappresentati nel mosaico riguardi un problema astronomico è provato dal quadrante solare che sta alle spalle delle figure e dalla sfera celeste che sta di fronte ad esse. Ma Gaiser è riuscito persino a individuare, con notevole probabilità, i singoli personaggi.
Al centro del mosaico, seduto sulla cattedra, con l’albero (un olivo?) alle spalle e una bacchetta in mano, con la quale indica la sfera celeste ai suoi piedi, sta Platone. Alla sua destra – per noi a sinistra – il primo personaggio in piedi a partire dalla cornice è sicuramente Eraclide Pontico, poiché il suo mantello giallo e il diadema sulla sua testa sono segni di quel lusso orientale a cui allude Diogene Laerzio, quando scrive che Eraclide vestiva con vesti morbide e aveva una figura così maestosa che gli Ateniesi, anziché Pontico, lo chiamavano “Pompico”4. Eraclide, come vedremo, formulò infatti una delle ipotesi capaci di “salvare i fenomeni” dei pianeti. Il secondo personaggio, seduto alla destra di Platone, ma rivolto verso Eraclide che gli tiene una mano sulla spalla come per proteggerlo, è quasi sicuramente Speusippo: questi era infatti il successore destinato di Platone e, sempre secondo Diogene Laerzio, si era occupato in particolare della formazione di Eraclide, probabilmente insegnandogli l’importanza della matematica.
A sinistra di Platone, in piedi e un po’ arretrato rispetto agli altri, c’è un personaggio che Gaiser propone di identificare col geografo Eratostene e Lasserre invece col pitagorico Ecfanto, ma questi sono entrambi estranei all’Accademia. Perciò io propendo a ritenere che si tratti di Filippo di Opunte, “segretario” di Platone, editore delle Leggi e autore di quell’appendice alle Leggi che è l’Epinomis (da epi nomois, “dopo le leggi”), il quale pure, come vedremo, esaltava il valore della matematica e in particolare dell’astronomia. A sinistra di quest’ultimo c’è una figura che gli studiosi unanimi identificano con Eudosso di Cnido, il grande matematico ed astronomo, che meglio di ogni altro riuscì a risolvere il problema formulato da Platone con la sua celebre teoria delle sfere omocentriche. Egli sta seduto e si regge il mento con la mano, in posizione assorta, come di chi sta pensando alla soluzione del problema.
Alla sinistra di Eudosso, e per noi il penultimo a destra, c’è un altro personaggio, pure lui seduto, che Gaiser propone di identificare con Senocrate per la posizione preminente che aveva nella scuola dopo Speusippo. Egli alza la mano destra, forse in segno di meraviglia o di spavento per la difficoltà dell’impresa proposta da Platone. Infine, all’estrema destra del mosaico (ma a sinistra di Platone, come nell’affresco di Raffaello), c’è Aristotele. Sulla sua identificazione tutti concordano: egli ha un aspetto più giovane, sta in piedi, come si addice a un giovane, e tiene in mano un rotolo, segno del suo amore per la lettura. Inoltre, appoggiato sul piede sinistro e lievemente inclinato da questa parte, sembra considerare il gruppo con un certo distacco.
Alcuni studiosi pensano che la discussione suscitata da Platone sui moti dei pianeti sia stata oggetto di un dialogo, scritto da Eraclide Pontico, poiché questi, secondo una testimonianza di Simplicio risalente al matematico Gemino, avrebbe detto che “qualcuno, sopraggiunto” (parelthôn tis), avrebbe avanzato una delle ipotesi risolutive (quella poi fatta propria dallo stesso Eraclide)5. A mio avviso non c’è bisogno di questa supposizione. Da varie fonti risulta che Platone soleva porre i problemi ai suoi scolari ed amici e che questi davano vita, insieme con lui, a dei veri e propri dibattiti, di cui poteva restare traccia in vari tipi di documenti (dialoghi, relazioni, appunti). Vediamo ora quali erano le posizioni dei vari personaggi di questo dibattito, a cominciare da quella di Platone.
2. Platone: l’universo a due sfere
In quello che forse è il suo libro migliore, La rivoluzione copernicana. L’astronomia planetaria nello sviluppo del pensiero occidentale, Thomas Kuhn ha indicato nel modello dell’“universo a due sfere” la prima teoria astronomica veramente scientifica, cioè capace di risolvere problemi quali il moto apparente del Sole di giorno e delle stelle di notte6. Come è noto, dopo la fine del positivismo ottocentesco e della storiografia ad esso ispirata, prolungatasi per un certo tratto anche nel Novecento, si è capito che anche la scienza ha una storia, la quale non è fatta solo di accumulazione progressiva di verità e conseguente eliminazione di errori, ma è fatta di teorie capaci di risolvere più o meno bene i vari problemi, cioè di spiegare più o meno bene i fenomeni. A questa consapevolezza hanno contribuito i più grandi epistemologi del Novecento, da Bachelard a Popper allo stesso Kuhn. Questi ha parlato, in un altro suo libro, di “rivoluzioni scientifiche”, mostrando che la scienza si sviluppa ora per continuità, ora per mezzo di vere e proprie rivoluzioni, cioè di mutamenti di “paradigma”, ma quella che precede le rivoluzioni è scienza allo stesso titolo di quella che ne risulta7. La teoria antica dell’universo a due sfere è dunque una teoria scientifica, anzi è probabilmente la prima teoria scientifica formulata nel campo dell’astronomia.
Come osserva Kuhn, la spiegazione più spontanea del fatto che le navi in arrivo compaiono all’orizzonte prima con la punta degli alberi e poi con l’intero scafo, o del fatto che durante le eclissi lunari la Terra proietta sulla Luna un’ombra semicircolare o circolare, è di immaginare che la Terra abbia una forma sferica. Inoltre la spiegazione più naturale del movimento apparente descritto dalle stelle nel corso della notte, le quali sembrano percorrere un arco, restando però sempre alla stessa distanza tra di loro – oggi nessuno le osserva più, ma gli antichi Greci non disponevano dei modi odierni di passare la sera, o la notte, e quindi guardavano le stelle –, è quella di immaginare che esse siano infisse in una sfera, la “volta” celeste, la quale ruota intorno ad un polo che, nell’emisfero occidentale, è la Stella Polare, la quale sembra star ferma. Nasce così, nell’antica Grecia, il modello dell’universo a due sfere, una più grande, esterna, ed una più piccola, al centro della prima. La Terra sarebbe la sfera interna, che sta ferma, e il cielo, detto cielo delle stelle fisse, perché le stelle non mutano la reciproca distanza, sarebbe la sfera esterna, la quale ruoterebbe intorno alla Terra. Questo modello spiega sufficientemente, almeno a prima vista, l’apparente movimento notturno delle stelle.
Tuttavia c’è un movimento ancor più evidente all’osservazione umana, che è il movimento apparente compiuto dal Sole ogni giorno, dal momento in cui “sorge”, cioè l’alba, al momento in cui scompare, cioè il tramonto. Poiché il Sole sembra descrivere un semicerchio, simile a quello descritto dalle stelle di notte, la spiegazione più semplice di tale movimento è di ammettere che il Sole sia trasportato anch’esso dalla volta celeste intorno alla Terra ed illumini ora l’uno ora l’altro emisfero di questa, alternandosi con le stelle. Il Sole di giorno e le stelle di notte sarebbero così trasportati, per esprimerci grossolanamente, da una stessa sfera, cioè parteciperebbero di uno stesso movimento.
Ma le cose si complicano quando si osserva che il Sole non sorge sempre dallo stesso punto dell’orizzonte e non tramonta sempre nello stesso punto, ma si sposta ogni mattina e ogni sera; inoltre il Sole non percorre sempre lo stesso arco, ma percorre d’estate un arco più alto rispetto all’orizzonte e d’inverno un arco più basso. Infine il giorno e la notte, cioè il periodo di luce e il periodo di buio che si alternano tra lor...
Indice dei contenuti
- Il sole, la luna, la terra e gli astri
- Note bibliografiche
- L’autore