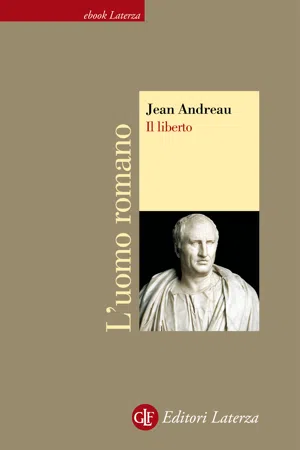Il liberto
Come ha sottolineato Moses Finley, gli storici della fine del secolo scorso esitavano a parlare della schiavitù antica. In un periodo in cui gli studi umanistici cominciavano a essere messi in discussione, gli storici non volevano correre il rischio di macchiare la memoria dell’antichità. Eduard Meyer, il celebre storico tedesco della Belle époque reagì contro questo silenzio. Insistette sull’affrancamento: l’esistenza degli schiavi affrancati e la loro condizione provavano ai suoi occhi che gli antichi offrivano agli schiavi ampie possibilità di liberazione e di avanzamento sociale, e che la schiavitù greco-romana non poteva in nessun caso essere confrontata con quella dell’America moderna.
Michail I. Rostovzev, pur ispirandosi molto a Meyer, nutriva altre preoccupazioni, ma anche lui riconobbe l’importanza dei liberti. Il liberto era ai suoi occhi il segno evidente che l’economia antica aveva conosciuto fasi capitalistiche. Certo, non tutti i liberti erano dei borghesi capitalisti, mentre molti erano gli «ingenui» (vale a dire gli uomini nati liberi), anche tra i più distinti, che si comportavano da autentici borghesi. Secondo Rostovzev, gli ex-schiavi liberati s’integravano perfettamente nella società romana e le loro possibilità economiche non erano molto diverse da quelle degli altri notabili; al tempo stesso essi rappresentavano un emblema, quello dello spirito imprenditoriale. Nel Satyricon, un liberto come Trimalcione, che vivendo in Campania aveva venduto le sue terre per consacrarsi al commercio – infatti egli badava soprattutto ad arricchirsi e restava estraneo alle gerarchie strettamente politiche – costituiva, per Rostovzev, il più bell’esempio dei cambiamenti di mentalità prodotti dall’espansione economica dell’Italia romana.
Personaggio mitico, Trimalcione ha fatto fantasticare Federico Fellini, ma anche alcuni storici, e non soltanto Rostovzev. Come quest’ultimo, Paul Veyne ne ha fatto un mito emblematico della società e dell’economia romana, interpretandolo tuttavia in maniera del tutto diversa.
Secondo Veyne, Trimalcione non è rappresentativo di tutti i liberti: con la morte del padrone, egli ha infatti ottenuto una completa indipendenza, cosa che non vale per la maggior parte dei liberti. In ogni modo, Veyne ritiene che, per comprendere la mentalità dei liberti – che siano ricchi o poveri, indipendenti o no – bisogna immergersi in un universo preindustriale, un universo di status, di categorie giuridiche strettamente definite, di legami personali e di valori aristocratici. L’universo dell’Ancien régime, se si vuole. Il ricchissimo Trimalcione, che possiede enormi beni fondiari nell’Italia del Sud, deve la propria ricchezza all’eredità del suo antico padrone, probabilmente un senatore, e quindi ai legami personali che la sua condizione di schiavo gli ha permesso di allacciare. I profitti commerciali non hanno fatto che accrescere questo patrimonio iniziale; ed è alla proprietà fondiaria che Trimalcione aspira profondamente.
Ma questo tuffo nella mentalità aristocratica, pur se doveroso, non basta. Infatti, nelle monarchie dell’Europa moderna una specie come quella dei liberti non esiste. I liberti, plebei che possono anche arricchirsi, ma che non saranno mai degli «arrivati», sono più esotici dei borghesi gentiluomini; agli occhi di Veyne, non si tratta di veri borghesi: anche se vivono in mezzo ai gentiluomini, essi non potranno mai diventarlo. Sono estranei all’epoca in cui vivono: nella gamma dei ruoli offerti dalla società romana, Trimalcione non ne trova nessuno per sé.
La figura storiografica del liberto è certo meno smagliante di quella dello schiavo (fra i liberti, stretti tra il mondo dei padroni e quello degli schiavi, non troviamo né un Euno né uno Spartaco)? Tuttavia essi sono stati oggetto di sintesi brillanti, di miti unificanti. Tra queste sintesi, quella di Veyne è probabilmente la più stimolante perché getta una luce nuova sul complesso della società romana e dei suoi valori.
Dobbiamo respingere l’interpretazione di Veyne perché si basa sul Satyricon? È questa la tesi di Florence Dupont, che ha cercato di dimostrare che il romanzo di Petronio non è una rappresentazione fedele del mondo dell’autore, ma un’opera non realista, immaginaria, da collocare nell’ambito di un genere letterario e filosofico, quello del «banchetto», che si tramuta poi in festino.
Che non siamo qui in presenza di un’opera realista, che tenda a rappresentare la vita quotidiana e sociale, è certo. Ci sono pochi dubbi in merito. Tuttavia anche il banchetto e il festino sono pratiche sociali; e non possono, in quanto tali, non essere collegati a prospettive di tipo antropologico, o, più semplicemente, di storia sociale. Il festino di Trimalcione è anche un testo satirico nel senso moderno della parola e se l’autore, attraverso la scappatoia delle citazioni e tramite l’intermediario del personaggio narrante, Encolpio, prende le distanze rispetto al proprio testo, ciò non è senza rapporto con i suoi intenti satirici. Non è indifferente che i convitati di questo festino dedicato al corpo siano dei liberti (mentre il narratore pietrificato è nato libero), che essi aspirino a realizzare un «banchetto platonico» e che siano in fin dei conti incapaci di arrivarci. Florence Dupont parla, del resto, di uno «scacco dei liberti» e aggiunge: «Essi non sanno né come si beve, né come si ama, né come si parla. Hanno bisogno di un padrone». Per comprendere le gerarchie sociali, vale la pena di notare che quel maestro del festino che s’impegna in un «banchetto burlesco», è il solo della compagnia a possedere un patrimonio da aristocratico e a giocare al senatore, benché, come gli altri, sia nato schiavo.
La lettura del Satyricon fatta da Florence Dupont non ne annulla il valore come documento di storia sociale; anzi, lo arricchisce e gli conferisce la sua vera e propria dimensione socio-culturale.
Resta il fatto che, se si presta attenzione a tutti i casi individuali offerti dai testi e dalle iscrizioni, le sintesi e i miti sociali perdono di forza e di seduzione. Ciò che s’impone allo sguardo è la giustapposizione di situazioni molto diverse o addirittura opposte. Trimalcione ha sì il cattivo gusto di un parvenu, ma molti liberti svolgevano funzioni che noi qualifichiamo come intellettuali o artistiche, o che sono proprie, nell’epoca attuale, delle professioni liberali: professori, scrittori, medici, architetti, pittori, sc...