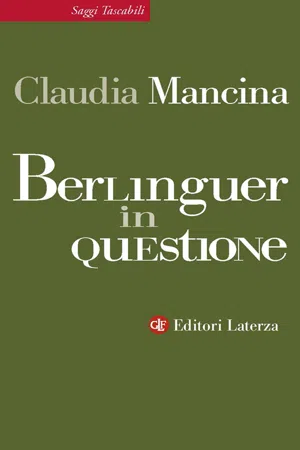1. Una strana idea di democrazia
A leggerli adesso, fanno un’impressione singolare i tre articoli di Rinascita nei quali Enrico Berlinguer, tra il settembre e l’ottobre del 1973, lanciò la proposta del compromesso storico. Anzitutto per il linguaggio: paludato e insieme fortemente ideologico, pieno di riferimenti a una costellazione di idee e a un Pantheon di figure che erano quelle dell’ortodossia comunista: l’imperialismo americano, il movimento comunista internazionale, e poi Lenin, e Gramsci e Togliatti e il «compagno Longo»... Un linguaggio oggi per noi lontanissimo. Mi chiedo che cosa capirebbe un giovane di venti anni, o anche di trenta. Niente, penso. Ma non c’è da stupirsi: con la scomparsa dell’Unione Sovietica e la fine del comunismo, è chiaro che quelle idee e quelle figure sono anch’esse scomparse dall’attualità politica.
Mi stupisce di più che allora Berlinguer usasse quel linguaggio, proprio mentre stava avanzando una proposta che, per quanto coerente con la tradizione togliattiana, rappresentava però una netta rottura con le idee dominanti nel movimento comunista, in particolare con la rappresentazione del partito come alternativo e contrapposto a quello che si usava chiamare il regime democristiano. Forse quel linguaggio serviva proprio a dissimulare e rendere più accettabili gli elementi di novità, secondo quella ispirazione continuista che accomunava i comunisti alla Chiesa cattolica. Anche loro avevano una propria storia sacra (Possieri 2007).
È vero, del resto, che quel linguaggio così intriso di leninismo non era allora una peculiarità dei comunisti. La sinistra extraparlamentare, nata dal Sessantotto, non usava un linguaggio diverso; anche quella sua parte che aveva sviluppato un atteggiamento critico verso l’Unione Sovietica e il cosiddetto «socialismo reale» si era persa in un imprudente innamoramento del maoismo e della rivoluzione culturale cinese. E non parliamo del linguaggio cupo e mortifero del terrorismo italiano e internazionale, che nei primi anni Settanta era in piena attività ed esercitava una certa influenza sugli ambienti della sinistra extraparlamentare.
Tuttavia, in quel contesto il Pci pretendeva di essere qualcosa di diverso: il partito della Costituzione e dunque della nazione, il partito della democrazia progressiva, che sarebbe evoluta nel socialismo senza smettere di essere democrazia. Era questo il nocciolo della «via italiana» che Togliatti aveva inaugurato nel 1944, al suo ritorno dall’esilio sovietico, d’accordo con Stalin. Essendo l’Italia parte del blocco occidentale, il Pci doveva adottare il metodo democratico e rinunciare alle tentazioni insurrezionali, se non voleva finire come in Grecia, con una sanguinosa guerra civile e la sconfitta dei comunisti. Nasce qui la famosa doppiezza del Pci: un partito che era insieme parte del sistema politico e antisistema, radicato nel mondo occidentale epperò legato all’Unione Sovietica; che era stato padre, con gli altri partiti antifascisti, della Costituzione repubblicana, eppure continuava a fare uso di categorie come dittatura del proletariato, Stato borghese, imperialismo, ecc.
L’uso di queste categorie rendeva inaffidabile il Pci agli occhi degli osservatori e degli elettori liberaldemocratici, ma nello stesso tempo lo esponeva alla critica dei movimenti estremisti: se lo Stato è borghese, allora si abbatte e non si cambia, come recitava lo slogan, tratto da Stato e rivoluzione di Lenin. Per questo il grande partito aveva paradossalmente la coda di paglia di fronte ai gruppetti di giovani e all’accusa di revisionismo (che, allora, equivaleva a quella di tradimento). Essendo leninisti, i comunisti dovevano giustificare – anzitutto a se stessi – la scelta democratica, e lo facevano appellandosi alla peculiarità della democrazia italiana nata dalla Resistenza, dunque da una lotta di popolo nella quale erano stati protagonisti. Come dire che lo Stato italiano non era semplicemente uno Stato borghese perché i geni comunisti erano nel suo Dna. L’antifascismo diventava così la condizione di possibilità, e insieme la garanzia, dell’adesione del Pci alla democrazia.
Berlinguer, personalmente, tutto era tranne che doppio; ma recidere il legame con il passato, se anche fosse stato possibile, era una cosa lontanissima dalle sue intenzioni. Non era nelle sue corde rinunciare a quelle categorie e tanto meno al rapporto storico e attuale con il movimento comunista internazionale e specificamente con l’Unione Sovietica. Si produsse così in un difficile equilibrio tra aspetti diversi e contrastanti dell’identità comunista. La proposta del compromesso storico è il punto massimo di questo equilibrio: una strategia che in modo «drammaticamente contraddittorio» (Barbagallo 2006) metteva insieme la volontà di collaborare al governo in un paese della Nato e quella di continuare a far parte del movimento comunista internazionale. Per giustificare in qualche modo la contraddizione, si avanzava una visione della situazione italiana come anomala e a rischio di soluzione reazionaria.
In effetti il paese viveva una stagione molto difficile, nella quale mancavano idee strategiche. La crisi economica, iniziata nel 1971 con la denuncia degli accordi di Bretton Woods e proseguita con la crisi energetica, segnava la fine di un lungo periodo di crescita. Svalutazione della lira, caduta del reddito nazionale, restrizione dei consumi, aumento della disoccupazione: lo sviluppo italiano si era arrestato.
Su questo difficile sfondo economico, la politica annaspa. La Dc chiude la fase centrista e torna al centrosinistra, ma sempre con l’esclusione pregiudiziale dei comunisti, che premono perché l’apertura a sinistra arrivi sino a loro, sulla base della convinzione che la crisi possa essere risolta solo con il loro apporto. La Dc appare sempre esposta a tentazioni di destra; il Psi, indebolito dalle sue divisioni interne, ha difficoltà a contrastare la politica deflazionistica di La Malfa. Nel frattempo, i gruppi terroristici cercavano di imporre la loro guida agli operai e agli studenti, individuando nel Pci un nemico non meno importante di quello rappresentato dai partiti di governo.
Si era dunque, secondo Berlinguer, di fronte a una crisi di sistema, che derivava dallo stesso modello di sviluppo del paese, da cui si poteva uscire solo con un nuovo modello di sviluppo. Ma per far questo ci voleva il Pci: forza di governo perché l’unica forza in grado di incanalare le lotte operaie verso obiettivi di riforma complessiva. Da quest’analisi veniva fatta derivare la proposta del compromesso storico come strategia di collaborazione tra le grandi forze popolari, che poteva cambiare l’Italia sino a introdurre nella società «elementi di socialismo». Il punto nodale, tuttavia, era la convinzione che la sinistra, se pure avesse conquistato la maggioranza assoluta dei voti (il celebre 51%), non sarebbe potuta andare al potere senza provocare una fatale spaccatura del paese e l’intervento dell’imperialismo americano, come indicava la tragica esperienza cilena.
La prima cosa da sottolineare è che questa idea strategica, pur avanzata con cautela e pur coerente con la peculiarità storica del comunismo italiano, aveva la grande ambizione di avviare una fase nuova non solo negli equilibri politici, ma nella storia profonda del paese: una nuova rivoluzione democratica, in continuità con la Resistenza e, oltre la Resistenza, con il Risorgimento. Un’ambizione coerente con l’autorappresentazione del Partito comunista da Gramsci a Togliatti. Ma perché Berlinguer pensava che ciò non potesse avvenire grazie a una vittoria alle elezioni? Perché il Pci non poteva accedere al governo, come avveniva alla sinistra in tutta Europa, passando attraverso un normale risultato elettorale?
La risposta che si trova nei tre articoli di Rinascita è quella di un profondo pessimismo sulle condizioni politiche sia interne sia internazionali. Berlinguer era angosciato dall’idea che la crisi italiana non trovasse uno sbocco politico e finisse con l’alimentare il sovversivismo delle classi dirigenti e l’estremismo. La democrazia italiana gli appariva fragile, così fragile da essere messa sullo stesso piano di quella cilena. Fino al punto da dimenticare che una cosa era per la Cia e per il cosiddetto imperialismo americano intervenire in Sudamerica; ben altra cosa sarebbe stato intervenire in un paese europeo. Certo, i tempi erano di ferro e di fuoco; tempi di gruppi terroristi sanguinari, probabilmente infiltrati dai servizi segreti interni e non solo; tempi nei quali l’ostilità degli americani e quella non minore dei sovietici alla sola idea di un ingresso dei comunisti al governo apparivano come concrete minacce.
Senza sottovalutarli, penso però che questi pericoli, che concorrevano a definire critica la situazione politica del paese, pur reali, siano stati per il segretario comunista una sorta di inconsapevole alibi per coprire in realtà una concezione anomala della democrazia, che contrastava con la fede democratica da lui così fortemente professata nella politica internazionale. Bisogna chiedersi: che significa affermare il valore universale della democrazia e il pluralismo politico, se poi si pensa che la maggioranza elettorale non basti per governare?
Sarebbe facile rispondere che i partiti socialdemocratici europei hanno tranquillamente governato con normali maggioranze elettorali (spesso assai inferiori al 51%). Ma è questo il punto: il Pci non era un partito socialdemocratico e aborriva la sola idea di diventarlo. Ecco allora che nell’asserita impossibilità della normale via democratica al governo si esprimeva una visione monca della democrazia, resa obbligata dalla impossibilità o incapacità di mettere in discussione l’identità comunista. In una democrazia l’alternanza al governo è determinata dalle maggioranze elettorali, ma i partiti comunisti non partecipavano alla normale dialettica democratica, o lo facevano in ruoli subalterni, appoggiati a un partito socialista, come in Francia. In Italia, per le proporzioni rispettive dei due partiti, questo era evidentemente impossibile. Ma altrettanto impossibile era che il Partito comunista andasse al governo da solo o con una alleanza di sinistra.
Dunque il problema era la natura extrasistema del Partito comunista: il fattore K, secondo una formula fortunata, cioè essenzialmente il suo legame con il campo sovietico (da Berlinguer molto indebolito ma non spezzato del tutto, e soprattutto non affrontato nel suo vero spessore, che coinvolgeva tutta la cultura politica del partito, il suo linguaggio, i suoi riferimenti storici). Questo legame assicurava al Pci una risorsa simbolica e politica di enorme valore: il mito dell’Urss, come esperimento di società socialista, come vincitrice della guerra, come superpotenza mondiale, come avanguardia del progresso scientifico e tecnico.
Tuttavia, proprio questo legame lo rendeva incapace di assumere il ruolo di soggetto autonomo della competizione. Il problema si poteva risolvere solo con la trasformazione dell’identità comunista: qualcosa che Berlinguer non intendeva intraprendere, per convinzione e per cultura. Il Pci era di fatto irriducibile alla fisiologica vita democratica, nonostante le tante prove di riformismo date soprattutto nelle regioni rosse. La conventio ad excludendum, tanto lamentata dai comunisti, non era una scelta politica ma una necessità derivante dalla natura contraddittoria del Pci. Il fattore K produceva d’altronde l’altra anomalia del sistema politico italiano: la centralità della Dc (da non confondere con il centrismo) e la sua inamovibilità dal potere.
In conclusione, quella che Berlinguer vedeva come una debolezza democratica del paese era in realtà la debolezza democratica del Pci. E la concezione della democrazia si indeboliva a sua volta, restava astratta, moralistica, emergenziale; non riusciva a collegarsi con la tradizione della teoria e della pratica delle democrazie occidentali. Ripensandoci bene, una spia di questo si coglie anche nella famosa frase pronunciata a Mosca nel 1977, che afferma il «valore storicamente universale» della democrazia, dove l’avverbio smorza la forza dell’aggettivo.
Del resto, quest’idea della democrazia era il massimo a cui poteva arrivare il gruppo dirigente nel suo complesso, per storia e per formazione culturale. Non a caso il vecchio Longo commenterà che quella del 51% è un’illusione democratica dura a morire, sempre combattuta dal partito.
La distanza che oggi sentiamo rileggendo queste pagine è data proprio dalla concezione della democrazia e della lotta politica democratica. Che è collocata all’interno di una lotta tra l’imperialismo e la reazione, da una parte, e le forze socialiste e democratiche, dall’altra: una lotta che conosce risultati positivi «da quando la rivoluzione russa del 1917 ha spezzato per la prima volta la dominazione esclusiva dell’imperialismo e del capitalismo». Un riferimento che esclude a priori la democrazia formale (l’unica che c’è) per pensare a una qualche democrazia sostanziale. Berlinguer si appella a una concezione dinamica e aperta della coesistenza pacifica, che, pur tenendo conto della divisione in blocchi, contrasta le politiche imperialistiche, che con la guerra e la violenza minacciano l’indipendenza delle nazioni. L’idea è che una coesistenza pacifica dinamica apra una finestra di opportunità per realizzare la «trasformazione democratica e socialista del nostro paese».
Se ci chiediamo in che consista questa trasformazione, vediamo che si tratta: a) di mutare i rapporti di forza a favore delle classi lavoratrici; b) di battere i tentativi reazionari, susseguitisi dal 1947 (l’esclusione dei comunisti dal governo) al 1953 (la legge maggioritaria, detta legge truffa), al 1964 (il mancato colpo di Stato), al 1969 (la strategia della tensione); c) di rinnovare profondamente le leggi, gli ordinamenti, le strutture e gli apparati dello Stato. Tutti obiettivi giusti e necessari, senz’altro; impressiona però che vengano presentati come parte di una trasformazione democratica e socialista, perdendo anche il senso delle differenze (il tentativo di correggere in senso maggioritario la legge elettorale non era poi un golpe reazionario).
Democrazia e socialismo possono essere così strettamente connessi, e quasi identificati, solo se si crede che la vera democrazia sia il socialismo, sia pure pensato secondo un «nuovo modello». Ed è questo in fondo il punto focale dell’identità del comunismo italiano. L’accettazione della democrazia, conseguente dalla realistica considerazione che l’Italia si trova nel blocco occidentale, si riempie di una filosofia della storia che vede nel socialismo l’inveramento della democrazia, e quindi nella democrazia nient’altro che la condizione di partenza per raggiungere il socialismo. Non stupisce la burbera obiezione dei sovietici: che l’unico socialismo reale era il loro.
La via democratica al socialismo è dunque vista come «una trasformazione progressiva dell’intera struttura economica e sociale, dei valori e delle idee guida della nazione, del sistema di potere e del blocco di forze sociali in cui esso si esprime». Non molto meno di una rivoluzione, in effetti: e Berlinguer non esita a parlare di politica rivoluzionaria. Non mancarono, nella nuova sinistra, le ironie e gli sberleffi rivolti a questa derubricazione della rivoluzione nella più anodina trasformazione. Che, in Italia, non avrebbe avuto bisogno di altro che della coerente attuazione della Costituzione antifascista, della quale i comunisti si sono sempre sentiti i principali interpreti e paladini.
Torniamo dunque, ancora e sempre, a quel momento magico nella storia del Pci e, secondo i comunisti, nella storia d’Italia che è stata l’unità antifascista. Il Pci non pensava, come oggi appare ovvio, che l’unità antifascista fosse la risposta adeguata a una fase di drammatica transizione: l’uscita dal fascismo e la realizzazione delle basi comuni dello Stato democratico. Niente di più normale che, una volta compiuta quest’opera costituente, le forze, tra loro molto diverse, che l’avevano compiuta tornassero a separarsi. Per i comunisti, invece, la rottura dell’unità appare come un trauma originario e insuperabile, attribuito alle pressioni americane e visto come una involuzione reazionaria della Dc; e il compromesso storico è pensato come il modo per sanare quella ferita (Barca 2005). Come ho già detto, era impensabile che i comunisti potessero alternarsi al governo con la Dc; erano loro i primi a non riuscire a pensarlo, cioè a pensarsi come un soggetto della competizione elettorale alla pari con gli altri. La riflessione di Berlinguer segue dunque la strada di una riedizione dell’unità democratica e antifascista, resa ancor più necessaria dalla gravità della crisi economica e dell’emergenza democratica.
«Ecco perché noi parliamo non di una ‘alternativa di sinistra’ ma di una ‘alternativa democratica’, e cioè della prospettiva politica di una collaborazione e di una intesa delle forze popolari di ispirazione comunista e socialista con le forze popolari di ispirazione cattolica, oltre che con formazioni di altro orientamento democratico». La via di soluzione che il segretario comunista offre alla grave crisi economica e politica del paese è dunque quella del nuovo compromesso storico tra le forze che rappresentano la grande maggioranza del popolo italiano: perché solo una maggioranza di questo genere può garantire che il rinnovamento e le riforme non producano una spaccatura, una scissione in due, dice addirittura Berlinguer, del paese.
Quando uscirono, questi articoli suscitarono un po’ di sconcerto, ma non furono forse compresi sino in fondo. All’interno, ci fu un generale consenso del gruppo dirigente mentre, come sempre, la base si mostrava preoccupata di un possibile cedimento, della perdita dell’antagonismo anticapitalistico e antidemocristiano. All’esterno, al solito diffidenza e critiche, ma senza la consapevolezza che la riflessione di Berlinguer voleva aprire una nuova fase politica. In sostanza restava un discorso piuttosto teorico, il disegno di una strategia politica ancora lontana dall’attuazione pratica.
Quella riflessione, e la strategia del compromesso storico che ne conseguiva, pensate dopo il risultato elettorale negativo del 1972 e dopo la tragedia cilena, diventano però attuali nel 1976, dopo la vittoria al referendum sul divorzio nel 1974, e dopo le elezioni regionali e amministrative del 1975, che videro a loro volta una grande vittoria del Pci, tanto che si cominciò a parlare di un suo possibile sorpasso sulla Dc. Il sorpasso non ci fu, anzi la Dc recuperò rispetto all’anno precedente, raggiungendo il 38,71%. Nonostante ciò, il risultato del Pci fu giustamente considerato una vittoria: il 34,37% era e rimase il massimo mai raggiunto dal partito. Comunisti e socialisti insieme toccavano il 45%, e con gli altri partiti laici avrebbero facilmente raggiunto e superato il 50%. Era un risultato che smentiva l’analisi pessimistica e angosciata fatta da Berlinguer, e apriva grandi possibilità.
Si era arrivati a questo risultato, però, grazie a processi sociali e culturali che seguivano una logica piuttosto diversa da quella della democrazia progressiva o della trasformazione democratica e socialista. Si era arrivati a questo risultato perché, mentre nelle fabbriche e nelle università infuriava la lotta di classe vera o talvolta presunta, la composizione sociale del paese era profondamente cambiata: l’Italia era ormai un paese a maggioranza di ceti medi, come aveva rivelato il saggio di Sylos Labini del 1974. Ceti medi istruiti, dinamici, curiosi, interessati a consumi più liberi e variati, che soffrivano la cappa perbenista de...