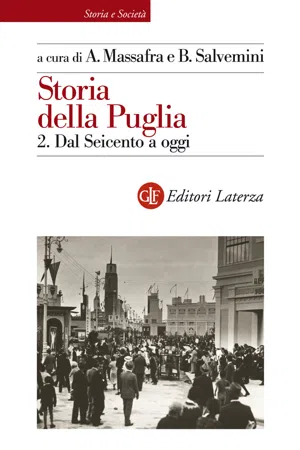Gerarchie territoriali, funzioni urbane e costruzione dello spazio regionale
di Angelo Massafra
Nei due secoli circa compresi tra la fine della dominazione spagnola sul Regno di Napoli e la crisi agraria e commerciale degli anni Ottanta dell’Ottocento, la società ed il territorio pugliesi furono investiti da alcuni processi di grande rilievo che saranno esaminati in questo capitolo e che in estrema sintesi possono essere così descritti:
a) nei primi decenni del XVIII secolo risultano sostanzialmente recuperate le perdite demografiche provocate dalla pestilenza di metà Seicento e si avvia una lunga fase di espansione demografica che in un secolo e mezzo circa (cioè tra gli anni Trenta del Settecento e i primi anni Ottanta dell’Ottocento) fa più che triplicare la popolazione pugliese, che passa da meno di mezzo milione a quasi 1.600.000 abitanti;
b) tale crescita non si distribuisce in modo uniforme nel tempo e nello spazio, ma appare largamente influenzata – nei suoi ritmi, nella sua portata e nella sua dislocazione sul territorio regionale – dalla diversa qualità ed incidenza delle trasformazioni che contemporaneamente investono gli assetti sociali e produttivi non meno che le funzioni e le caratteristiche degli insediamenti delle tre province e delle loro articolazioni subprovinciali;
c) i processi di crescita demografica e di mutamento sociale ed economico ora segnalati, in un contesto di sempre più accentuata integrazione delle strutture produttive regionali nei circuiti del mercato interno e internazionale e di più efficace e consapevole capacità del potere politico e amministrativo, a livello centrale e periferico, di organizzare il territorio e di condizionarne l’evoluzione, inducono significativi mutamenti nella dimensione e nella struttura sociale e professionale dei centri abitati. Ciò accade tanto per quelli che rivelano vocazioni ed assumono ruoli sempre più spiccatamente urbani e mercantili, quanto per quelli che, non casualmente indicati nella recente storiografia come agrotowns, pur conservando una marcata connotazione rurale, partecipano comunque, e non necessariamente in una posizione solo subordinata e passiva, alla crescita quantitativa e qualitativa di figure e funzioni sociali legate al mondo del commercio, delle professioni e della pubblica amministrazione o ad una gestione attiva e non puramente redditiera dei patrimoni fondiari;
d) un ruolo importante nella formazione e nell’evoluzione degli equilibri territoriali e delle strutture sociali e insediative della Puglia fra età moderna e contemporanea ha avuto, soprattutto nell’Ottocento, l’infrastrutturazione del territorio promossa, in un rapporto di concordia discors, dal potere centrale e dalle élites locali con la costruzione di una rete di strade rotabili e ferrovie di varia ma non trascurabile densità ed efficienza, e con la ristrutturazione e l’ampliamento di alcuni porti di particolare importanza commerciale e/o militare.
1. Gli uomini e le città: una crescita differenziata
Le variazioni nel tempo delle circoscrizioni amministrative – numerose e di un certo rilievo soprattutto quelle ai confini fra la Capitanata e le contigue province di Molise e Principato Ultra – e il diverso grado di attendibilità delle rilevazioni demografiche rendono alquanto incerti, almeno fino agli anni Sessanta del Settecento, i dati disponibili sulla consistenza e sull’evoluzione del patrimonio demografico pugliese. Non agevoli e in qualche misura opinabili possono risultare, quindi, i confronti nel tempo e nello spazio.
Con un buon margine di approssimazione, tuttavia, si può dire che subito dopo la grande carestia del 1763-64 nelle tre province pugliesi, che intorno al 1730 erano state «numerate» per poco più di 100.000 «fuochi» fiscali (grosso modo pari a 450.000 abitanti), si contavano circa 660.000 anime. Sul totale regionale la Capitanata incideva per il 25% circa, mentre Terra di Bari vi partecipava con il 36% (circa 245.000 abitanti) e solo di poco superiore (39%) era la quota coperta da Terra d’Otranto.
Ma già mezzo secolo dopo, cioè alla vigilia dell’altra grande carestia del 1816-17, si erano registrati alcuni significativi mutamenti. Mentre Terra di Bari e Capitanata avevano visto aumentare la loro popolazione, in termini relativi, grosso modo nella stessa misura (+40%), passando rispettivamente a 230.000 e a 340.000 abitanti circa, Terra d’Otranto aveva registrato un incremento demografico di appena il 15% e aveva ceduto a Terra di Bari il ruolo di provincia più popolosa della regione.
Pur senza voler stabilire rigidi rapporti di causa-effetto fra i due fenomeni, appare indubbio che le differenze nel ritmo di crescita demografica delle tre province erano la spia di una diversa velocità e profondità di trasformazione degli assetti sociali ed economici.
Dopo le crisi di sussistenza degli anni Cinquanta-Sessanta del Settecento, nel Tavoliere, sulle colline della Murgia barese centro-settentrionale e, in minor misura, di quella tarantina era cominciata una «lunga marcia» del grano, che sarebbe continuata anche nel secolo successivo, pur con differenze nel ritmo e nella distribuzione spaziale del fenomeno, e si erano intensificati gli scambi tanto sul mercato locale quanto nei rapporti con Napoli e il suo hinterland.
Nel Salento centro-meridionale, invece, i margini della crescita produttiva e commerciale e della mobilità sociale erano più rigidi e limitati da fattori sia sociali (maggiore pervasività della rendita feudale e fondiaria, minore articolazione del tessuto socio-professionale, frammentazione talora eccessiva del possesso fondiario e larga diffusione dell’autoconsumo contadino, tipologia insediativa caratterizzata dalla netta prevalenza di piccole, talora minuscole, comunità rurali) sia tecnico-ambientali (minore disponibilità di terre dissodabili, alto livello raggiunto già da molto tempo dalla presenza di colture arboree, arretratezza delle tecniche di produzione e di commercializzazione dell’olio ecc.).
Queste differenze – in parte strutturali e in parte congiunturali – nelle potenzialità di sviluppo delle tre province e delle subaree che le componevano emergono con forza ed evidenza anche maggiori nel corso dell’Ottocento, e ancora una volta i dati demografici consentono di coglierne la presenza.
Tra i primi anni della Restaurazione e il censimento del 1881 la popolazione regionale passa da 870.000 abitanti circa a poco meno di 1.600.000. L’incremento, però, è solo del 55% per la Capitanata, di poco più dell’80% per Terra d’Otranto e del 100% per Terra di Bari. In quest’ultima provincia, pertanto, all’inizio degli anni Ottanta dell’Ottocento risiedeva il 43% della popolazione regionale contro il 36% di poco più di un secolo prima (1765).
Ma i dati aggregati su scala provinciale rischiano di occultare differenze non meno rilevanti e significative all’interno delle singole province. In Capitanata, per esempio, furono soprattutto i centri del medio e basso Tavoliere (Foggia, Cerignola, San Ferdinando e gli ex «siti reali» di Orta, Ordona, Stornara e Stornarella) ed alcuni centri garganici, come Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo, a registrare i maggiori incrementi, compensando i più modesti ritmi di crescita, e talora la stagnazione, di altre aree come l’alto Tavoliere e, ancor più, il Subappennino dauno.
Anche in Terra di Bari i modi, i tempi e la distribuzione sul territorio della crescita demografica risultano tutt’altro che omogenei. Furono soprattutto i centri della Murgia nord-occidentale, alla destra dell’Ofanto, e quelli che, da Corato a Bitonto, fungevano da cerniera tra la fascia costiera dell’olivicoltura specializzata e la Murgia cerealicolo-pastorale, a registrare il maggiore incremento demografico tra la fine del XVIII secolo e gli anni Ottanta del XIX. In quell’arco di tempo, infatti, se la popolazione totale di Terra di Bari aumentava del 120% circa, per i sette comuni di Spinazzola, Minervino, Barletta, Ruvo, Canosa, Andria e Corato l’aumento sfiorò complessivamente il 170%.
Negli ultimi tre comuni, in particolare, la popolazione grosso modo triplicò. Il loro territorio, com’è noto, più di altri fu interessato da un duplice e convergente processo: da un lato, infatti, fu investito da una massiccia espansione del seminativo sui fertili pascoli delle terre già appartenute alla Dogana di Foggia, concesse a censo durante il Decennio francese, e su quelle dei demani ex feudali e comunali progressivamente, e più o meno legittimamente, «appadronate»; dall’altro registrò, soprattutto a partire dagli anni Trenta del XIX secolo, una rapida e non meno massiccia avanzata degli oliveti, dei mandorleti e dei vigneti sulle terre trasformate dal lavoro contadino con la diffusione su larga scala del contratto di miglioria.
Si trattò di un fenomeno di dimensioni e rapidità tali da far scrivere a metà Ottocento ad un osservatore attento e ben informato come Carlo De Cesare: «volgete lo sguardo alla valle dell’Ofanto presso Canosa, alle pianure di Monte Carafa presso Andria, alle campagne di Spinazzola, Corato, Ruvo, Barletta, Trani e dell’intero distretto barese, e voi vedrete milioni di viti piantate da cinque anni in qua, migliaia di alberi di ulivi e mandorli e infinite altre piante da frutto».
Più vario e contraddittorio si presentava il quadro nel resto della provincia. I centri costieri a nord-ovest di Bari e, in forme e con esiti addirittura sorprendenti, lo stesso capoluogo provinciale beneficiarono in varia, ma sempre notevole, misura della crescita demografica e produttiva dei centri situati nel loro entroterra, accentuando antiche vocazioni (commerciali, come nel caso di Barletta e ancor più di Bari, o «terziarie» come Trani) o integrando e progressivamente sostituendo precedenti attività con altre relativamente nuove (Molfetta, per es., nel corso dell’Ottocento adottava su larga scala innovative tecniche di pesca d’altura acquisendo, in questo settore, un primato che si è ulteriormente consolidato nel corso del XX secolo).
Molto più debole si rivelava, invece, la capacità di crescita dei centri costieri situati a sud-est di Bari, con tutta evidenza penalizzati dal minore dinamismo del loro entroterra, e dei centri della Murgia sud-orientale, le cui strutture economico-sociali e demografiche appaiono segnate da una maggiore continuità con il passato, con la persistente prevalenza della policoltura e dell’autoconsumo contadino. Solo dopo l’Unità forme parziali di specializzazione produttiva e di maggiore integrazione con il mercato sovralocale sarebbero state indotte dalla diffusione del vigneto, generalmente su terre concesse in enfiteusi e sempre più spesso disseminate di «trulli», peculiare forma di architettura rurale che è quasi un simbolo di insediamento sparso e di protagonismo contadino nella trasformazione del paesaggio agrario.
Nella Murgia meridionale e centro-occidentale, infine, la mancata diffusione delle colture arboree ed arbustive e la persistente preminenza, come unità aziendale tipo, della masseria cerealicolo-pastorale caratterizzata da bassi livelli di produttività, frena anche la crescita demografica che in taluni casi (per es. ad Altamura e Noci) risulta addirittura impercettibile. In un arco di tempo quasi secolare, se si escludono le positive eccezioni di Santeramo, Gioia del Colle e Gravina, che grosso modo raddoppiano la loro popolazione, nella vasta fascia di territorio compresa fra l’ultimo dei tre centri ora citati e, ad est, Turi, Putignano e Noci, l’incremento demografico fu di appena il 37%, contro una media provinciale del 100%.
Anche in Terra d’Otranto i processi di differenziazione, nel tempo e nello spazio, della crescita demografica, dello sviluppo produttivo e commerciale legato al dissodamento di terre incolte e a pascolo e alla trasformazione degli assetti colturali, determinarono significativi spostamenti negli equilibri e nelle gerarchie territoriali della provincia.
Tra gli ultimi decenni del Settecento e gli anni Ottanta dell’Ottocento fu soprattutto l’espansione della cerealicoltura sulle colline a nord e ad ovest di Taranto e nell’entroterra brindisino, peraltro interessato anche da una notevole avanzata dell’oliveto nel triangolo compreso fra Ostuni, Francavilla Fontana e San Pietro Vernotico, a creare condizioni di crescita demografica ed economica e di mobilità sociale più favorevoli che nel resto della provincia.
Taranto e Brindisi, promosse nel Decennio francese al rango di capoluoghi di circondario (dopo l’Unità, di distretto), avvantaggiate dalla scelta dei governi (borbonici prima ed italiani dopo) di farne delle munite piazzeforti militari e punti di convergenza di importanti linee stradali e ferroviarie, beneficiarie e protagoniste, infine, della crescente commercializzazione delle derrate prodotte da un entroterra agricolo sempre più esteso e meglio coltivato, segnalavano questo maggiore dinamismo registrando un incremento demografico che tra la fine del Settecento e gli anni Ottanta dell’Ottocento faceva raddoppiare la popolazione di Taranto (da 17.000 a quasi 34.000 abitanti) e quasi triplicare quella di Brindisi (da 6.000 a poco meno di 17.000 abitanti), nel frattempo diventata capolinea del collegamento ferroviario Londra-Ostenda-Verona-Brindisi su cui si muovevano uomini e merci della «Valigia delle Indie».
Di minore dinamismo davano prova, invece, i distretti di Lecce e Gallipoli, frenati da una maggiore continuità col passato nelle loro strutture sociali ed insediative e negli assetti colturali e produttivi, largamente fondati su un’olivicoltura che non riusciva ad espandersi in termini quantitativi e a migliorare sul piano qualitativo, perché continuava a produrre olio destinato prevalentemente ad uso industriale in una fase storica in cui sempre più accanita ed efficace si faceva, su questo piano, la concorrenza degli oli di semi e di prodotti chimici.
Non meraviglia constatare, quindi, che se negli ultimi decenni del Settecento da Terra d’Otranto uscivano oltre i due terzi dell’olio esportato dalla Puglia (quasi 37.000 salme su un totale di poco più di 50.000), nella prima metà degli anni Ottanta dell’Ottocento tale quota era scesa ad un terzo soltanto (83.000 salme contro quasi 160.000 esportate da Terra di Bari).
Ma non meno importante fu il mutamento dei rapporti che si registrò fra le diverse aree della provincia nella produzione e commercializzazione dell’olio, che per tutto il periodo qui considerato continuò ad essere la derrata di gran lunga più importante per l’economia provinciale.
Se, infatti, alla fine del Settecento Gallipoli esportava i due terzi dell’olio mediamente estratto ogni anno da Terra d’Otranto (22.000 salme contro le 12.000 in tutto di Brindisi e Taranto), tra gli anni Settanta e Novanta dell’Ottocento la sua quota si riduceva al 40% circa (meno di 47.000 salme a fronte delle 70.000 circa di Taranto e Brindisi considerate insieme). Non sorprende, pertanto, che nell’arco di tempo considerato Gallipoli sia stata, fra le città pugliesi capoluoghi di circondario e, poi, di distretto, quella che ha registrato il più basso tasso di incremento demografico passando, con i suoi casali, da circa 12.000 abitanti a fine Settecento a non più di 13-14.000 nei primi anni Ottanta dell’Ottocento.
Differenze sempre più marcate nel paesaggio agrario e nei modi di utilizzazione della terra, nei livelli e nelle forme della specializzazione produttiva e dello sviluppo commerciale, nel grado di articolazione e di complessità delle strutture sociali, nella crescita demografica e nelle capacità direzionali dei centri urbani disegnavano, dunque, gerarchie territoriali sempre più nette e vincolanti che spesso vennero ulteriormente, e talora consapevolmente, rafforzate dai processi di infrastrutturazione del territorio di cui diremo fra poco.
Vale la pena di soffermarsi brevemente, prima di concludere questa parte della nostra analisi, su alcuni fenomeni di crescita e di specializzazione delle funzioni urbane che contrassegnarono complessivamente, anche se ancora una volta in modo non omogeneo, l’area pugliese.
2. Un’urbanizzazione non omogenea
Fin dal tardo Medioevo caratteristica specifica dell’insediamento umano in quest’area (soprattutto in Terra di Bari, nel Salento settentrionale e nel medio ed alto Tavoliere) è stato l’alto indice di accentramento della popolazione in comunità di dimensioni superiori – talora di molto! – alla media del Regno.
Alla fine del Settecento, se nel resto del Mezzogiorno continentale (esclusa Napoli) nei centri con almeno 10.000 abitanti viveva circa il 12% della popolazione, tale percentuale saliva al 15% ...