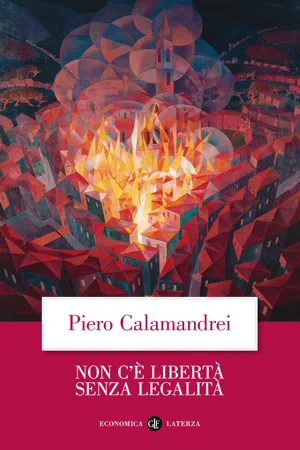Libertà e legalità
1. Libertà morale e libertà politica
Quando si sente dire che la libertà è la vita morale e che l’uomo l’ha già in sé, sicché non gli si può dare né togliere, mi pare che il ragionamento – che può essere esatto sul piano filosofico1, in cui lo spirito dell’uomo si considera isolatamente in sé – non sia valido sul piano politico, cioè pratico, in cui si tratta appunto di stabilire mediante le leggi quali sono per un certo popolo, in un certo momento della sua storia, le condizioni pratiche necessarie e sufficienti per far sì che la libertà naturalmente insita in ogni consociato possa esplicarsi senza intralci: per far sì che la vita morale di ognuno possa esercitarsi in modo da contribuire praticamente al miglioramento della società. La libertà, come fervore di vita dello spirito, come vitalità morale, non sono le leggi che possono crearla in chi non la vuole; ma per chi l’ha e vorrebbe praticamente esplicarla in opere, sono le leggi che debbono praticamente assicurargli la libertà politica di poter esplicare la sua libertà morale.
Se il principio, vero nel campo della morale individuale, che ogni uomo è libero per sua natura e che, quindi, lo Stato non può né dargli né togliergli ciò che egli ha già, fosse vero anche nel campo della politica, il partito liberale sarebbe, nel campo della politica, un non senso: come sarebbe una stoltezza un partito che si costituisse per sostenere che tutti gli uomini respirano o digeriscono. Anche sotto i regimi tirannici gli uomini sono moralmente liberi; eppure, con tutta la loro libertà interiore, vivono praticamente schiavi e anelano a un regime che permetta loro di tradurre in azione pratica esteriore questa loro congenita libertà. La libertà morale l’hanno di già, ma è alla libertà civile e politica che essi anelano.
Il partito liberale assume invece una sua ragion d’essere politica, cioè pratica, quando si mette a propugnare una serie di garanzie che debbono essere assicurate ai cittadini affinché ciascuno trovi nella società le migliori condizioni possibili per poter tradurre in azioni pratiche gli impulsi della vita morale: quando si fa propugnatore di quella che si suol chiamare la libertà politica.
La libertà – che nel campo morale individuale è un affare interno ed alla quale nel foro interno non occorrono garanzie, perché la signoria che ognuno ha del proprio spirito è per natura inviolabile e nessun tiranno può attentare ad essa – diventa dunque, nel campo politico, un affare esterno, interindividuale: libertà di tradurre in azioni esterne la propria interna libertà morale, libertà di fare o di non fare nel mondo esterno [cfr. Voltaire]. È in questo secondo e più limitato senso, esteriore e direi quasi visibile, che della libertà si parla nel campo politico.
Il problema della libertà in questo senso (che è poi il problema del diritto) nasce dalla società: è nei rapporti interindividuali, dove può esservi il pericolo di attività di un uomo che mirino ad impedire o a limitare la attività di un altro uomo, che si presenta il problema di stabilire qual è nei rapporti reciproci quell’ambito di libera attività esterna che deve essere garantita ad ogni uomo, perché possa esplicarsi nel miglior modo possibile la sua vita morale, senza mortificare e impedire la esplicazione della vita morale altrui. L’idea liberale, portata nel campo politico, significa dunque questo: asserzione delle condizioni esterne indispensabili nell’ordinamento della società per garantire che ogni uomo possa nel modo più ampio possibile, compatibilmente coll’ugual garanzia per tutti gli altri cittadini, tradurre in attività pratiche la sua vita morale: il che poi si risolve in una limitazione della libertà individuale, in quanto per garantire a ciascuno un certo campo di libera attività, bisogna arrestare ai confini di essa l’attività altrui.
La funzione del partito liberale, infatti, se ha voluto in qualche modo influire – e potentemente ha influito – nella vita pratica dei popoli, non si è limitata ad una proclamazione astratta della libertà come idea morale, ma si è svolta nella precisazione di una serie di garanzie giuridiche, cioè interindividuali, alle quali deve essere affidata nella vita dello Stato la tutela della libertà individuale: i cosiddetti diritti di libertà [Ruffini2], le cosiddette istituzioni liberali, che sono tutte quante determinazione di quello che i consociati possono fare entro la propria sfera giuridica e, reciprocamente, di quello che non possono fare per non invadere la sfera giuridica altrui.
Quell’ideale della libertà che, finché si resta nel campo morale, non soffre determinazioni aprioristiche e attentati, che suonerebbero menomazione e negazione dello stesso concetto di libertà, ha bisogno di specificazioni e di qualificazioni nel campo politico: dove, a chi propugna il programma della libertà, è naturale che l’interlocutore domandi (poiché nel campo della politica si tratta di attività pratiche): «libertà di far che?». E il liberale non potrà rispondere: «Libertà di far tutto», perché questo non sarebbe un programma di governo ma un’anarchia, ma dovrà rispondere: «Libertà di far questo e non di far quest’altro». E quindi, nel campo pratico, dovrà pure il liberale decidersi di dettare limiti pratici alla libertà, per accompagnarla con qualificazioni ed attributi ed anche (perché, necessariamente, la libertà per uno significa per l’altro divieto di violarla) per negarla quando volesse eccedere i confini segnati.
2. Il liberalismo come metodo, ossia come procedura
L’idea liberale si traduce dunque, nel campo politico, nella propugnazione di un sistema costituzionale che sia il più idoneo possibile a garantire nel modo praticamente migliore la libertà di ciascuno: sia nel senso negativo ed egoistico che la personalità di ciascuno si possa svolgere liberamente nei limiti segnati dal rispetto dovuto alla personalità altrui, sia nel senso positivo ed altruistico che la vita morale di ciascuno possa far sentire il proprio contributo pratico nella elevazione e nel miglioramento della vita sociale.
Questo ha infatti sempre fatto il partito liberale: il quale, prima di tutto, ha ritenuto giustamente che l’azione politica dei liberali si debba soprattutto esplicare nella lotta per la istituzione e la conservazione del meccanismo giuridico attraverso il quale si formulano le leggi. Il liberale non può a priori precisare un programma organico e completo di riforme economiche, perché ciò vorrebbe dire vincolare a priori e quindi negare la libertà, mentre il coerente rispetto di questa esige che i provvedimenti siano di volta in volta deliberati «dal corso degli eventi, che è sempre pieno di sorprese» [Croce], ma può a priori stabilire qual è il meccanismo costituzionale attraverso il quale è possibile che di volta in volta i provvedimenti legislativi possano essere deliberati con libertà. Il liberale, insomma, dice: «Io non mi posso impegnare a priori a votare per l’abolizione della proprietà privata, perché con questo verrei a togliermi a priori la possibilità di discutere con libertà, al momento in cui verrà messo sul tappeto questo argomento, la opportunità contingente e storica di tale abolizione; ma mi impegno a priori nel sostenere che l’ordinamento costituzionale il quale permette di discutere con libertà i provvedimenti è quello che io propongo e non altri.
(N.B. Al liberale non interessa quale sia la soluzione dei problemi, ma il metodo, il procedimento che si segue per la loro soluzione; e siccome la soluzione dei problemi politici consiste in sostanza nella creazione di un ordine, cioè del diritto, al liberalismo non interessa tanto quale sia il diritto che si crea, quanto il modo con cui si crea. Il liberalismo si può definire come il metodo per la creazione del diritto con rispetto della libertà: è prima di tutto, quindi, un partito che attiene al diritto costituzionale.)3
Il programma dei liberali non riguarda dunque tanto il contenuto delle leggi, quanto la struttura del meccanismo costituzionale che deve servire a crearle. In questo senso si può dire che al partito liberale sta a cuore più la forma che la sostanza, e si spiega l’accusa di vuotezza che, chi non ne intende a pieno la funzione, gli rivolge: nel senso che il partito liberale, nel formulare le sue premesse programmatiche, non può manifestare preferenza per l’una o l’altra soluzione di problemi politici concreti (riservandosi di volta in volta di prender posizione al momento in cui i problemi si presenteranno), ma si limita ad affermare la necessità che sia rispettato, nel deliberare di essi provvedimenti, un certo metodo, un certo ordine, una certa procedura costituzionale, che secondo esso è indispensabile affinché i problemi politici possano essere discussi e risolti con libertà. Per questo si potrebbe dire, in linguaggio forense, che ai liberali preme più la procedura del merito: essi sono dei proceduristi, i quali non si preoccupano a priori della giustezza delle deliberazioni perché sono convinti che se si rispetterà quella procedura la decisione che verrà fuori non potrà non essere giusta.
3. Idea essenziale della legalità: certezza dei limiti della legalità politica
Uno dei capisaldi fondamentali del sistema liberale è la legalità, che anche il Croce considera come «primo grado della vita pratica, condizione della vita morale e della libertà». Libertà politica e legalità non coincidono; ma l’instaurazione di questa è condizione perché quella possa proficuamente esplicarsi nella vita della società. Vi può essere, come si dirà, un ordinamento costituzionale che sia legalitario e non liberale, ma non viceversa. Colla legalità non vi è ancora libertà; ma senza legalità libertà non può esserci.
Che cosa vuol dire legalità? E perché la legalità è c...