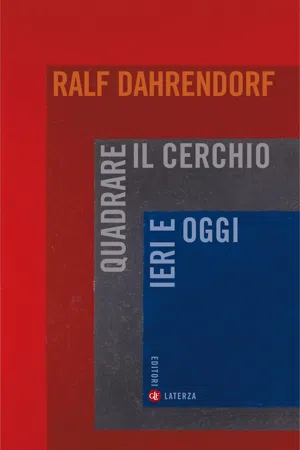1. In difesa del Primo Mondo
Nel suo momento migliore il Primo Mondo non era un posto poi tanto brutto in cui vivere
e prosperare. C’era mai stato qualcuno che l’avesse chiamato «Primo Mondo»? Oppure
quell’ordinale doveva servire solo a distinguerlo dall’innominabile «Secondo Mondo»
dell’oppressione comunista, ormai quasi scomparso, nonché dal «Terzo Mondo» (e magari
tra un po’ anche dal quarto) della miseria, della malattia e della prostrazione? Qualunque
ragione ci sia dietro il suo nome, guardiamoci bene dal liquidarlo troppo disinvoltamente.
Nel suo momento migliore esso combinava insieme tre aspetti positivi dal punto di
vista sociale:
– era fatto di economie che non si limitavano a offrire una vita decente a molti,
ma sembravano fatte apposta per crescere e dischiudere opportunità anche a coloro
che non erano ancora arrivati alla prosperità;
– constava di società che avevano compiuto il passo dallo status al contratto, da
un’inerte dipendenza a un individualismo combattivo, senza distruggere le comunità
in cui le persone vivevano;
– praticava programmi politici che combinavano il rispetto dello stato di diritto
con quelle opportunità della partecipazione politica, con quella possibilità di liquidare
e scegliere i governi, che abbiamo imparato a chiamare ‘democrazia’.
Viene voglia di chiedersi quando e dove siano esistiti paesi così ricchi, civili e
illuminati. È forte la tentazione di nascondersi dietro gli acronimi e di tirare in
ballo quello che spesso viene chiamato il mondo dell’OCSE, cioè l’insieme dei paesi
membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Ma vincerò
la tentazione e chiamerò le cose con il loro nome. Un esempio di quel mondo è costituito
dagli Stati Uniti d’America nell’arco di tempo che va da Roosevelt a Kennedy, ma anche,
sia pure non nella stessa misura, prima e dopo. Molti milioni di persone di tutti
i paesi del mondo hanno sognato di vivere in America e, pur di riuscirvi, moltissimi
uomini hanno dato fondo alle proprie risorse. La capacità di esercitare una forza
magnetica così potente sui flussi migratori è un indice tutt’altro che inaffidabile
di benessere sociale. Lo stesso si può dire anche di altri paesi. Rispetto agli Stati
Uniti il Regno Unito ha fatto registrare a lungo un saldo migratorio meno sbilanciato,
se si eccettuano irlandesi, ebrei perseguitati e, più tardi, gli abitanti delle colonie
più povere; ma per lunghi periodi di questo secolo [Il lettore tenga presente che
i riferimenti cronologici sono relativi alla data in cui scriveva Dahrendorf (N.d.R.).] certamente esso ha fatto parte di quello che qui ho chiamato «Primo Mondo». Lo
stesso si può dire di molte parti dell’ex Impero britannico, il «Commonwealth temperato»
come lo chiama qualcuno con espressione corretta nell’ambito geografico ma non altrettanto
riguardo alla politica: esso comprende infatti Australia, Nuova Zelanda, Canada e
poche altre regioni sparse in tutto il mondo. Ma sarà bene menzionare anche alcuni
paesi europei di più modeste proporzioni: la Svizzera, la Svezia e gli altri Stati
scandinavi. Negli anni Cinquanta, quando l’Organizzazione europea per la cooperazione
economica (OECE) – che significava soprattutto ricostruzione – si trasformò in Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), quasi tutti gli Stati dell’Europa
occidentale erano entrati a far parte del novero dei «pochi paesi felici».
Le loro caratteristiche erano, lo ripeto, opportunità economiche, società civile e
libertà politica. Ma limitarsi ad affermazioni così compiaciute vorrebbe dire mettere
a dura prova la benevolenza di qualunque cittadino di uno dei tanti paesi aderenti
all’ONU. In effetti, per avviare un discorso serio, occorre aggiungere subito tre
precisazioni, ognuna delle quali meriterebbe un saggio a parte.
Innanzitutto la perfezione del Primo Mondo nella stagione del suo apice aveva una
pecca: tutti i suoi membri escludevano altri dai benefici delle loro conquiste e perfino
delle loro opportunità. La storia degli Stati Uniti è una lunga sequenza di battaglie
per l’inclusione: dalla guerra civile, alle campagne per i diritti civili, fino alle
vicende del sottoproletariato di oggi. Per lo più, e la cosa merita di essere rilevata,
la battaglia è stata combattuta all’interno delle istituzioni del paese. Inoltre,
ed è un’altra circostanza degna di nota, lungi dall’essere stata combattuta solo dagli
esclusi, la battaglia ha trovato dei protagonisti anche altrove, per esempio nella
Corte Suprema. Ma la società americana non si è mai nemmeno avvicinata alla perfezione
in termini di opportunità economiche, integrazione sociale e partecipazione politica.
Ancora oggi (per menzionare solo un fatto sorprendente tra i molti che si potrebbero
ricordare) il Presidente americano probabilmente viene eletto da non più del quindici
per cento degli aventi diritto al voto.
Le imperfezioni americane sono gravi e ben visibili, ma quelle della Gran Bretagna
e dell’Australia, della Svizzera e della Svezia, non sono meno importanti. Le disuguaglianze
economiche restano per molti il segno di una promessa chimerica di cittadinanza. I
conflitti sociali che presumibilmente un secolo fa avrebbero tenuto banco in un ipotetico
convegno mondiale sullo sviluppo sociale erano laceranti; e i rappresentanti dei governi
a tale convegno immaginario del 1895 per lo più avrebbero raccomandato di sopprimere
i disordini con la forza. Ci sono voluti decenni di lotte intestine – ‘lotte di classe’,
come furono giustamente chiamate allora – per affermare l’uguaglianza fondamentale
di tutti gli esseri umani nella società. E ci sono volute anche due guerre moderne:
per quanto sia terribile a dirsi, non esiste un fattore di livellamento sociale più
efficace di una guerra moderna che coinvolga l’intera popolazione. Non è un caso che
la seconda guerra mondiale sia stata chiamata «guerra totale».
Queste guerre, naturalmente, non videro contrapposte l’una all’altra le grandi democrazie
del mondo. A schierarsi sui due fronti furono rispettivamente i paesi civili e quelli
non abbastanza (non ancora?) civili, quelli che almeno avevano cercato di allargare
la base di disponibilità per ciò che offriva quell’epoca e quelli che non avevano
ancora imboccato questa strada. Sottolineo deliberatamente questa circostanza e la
integro con una tesi generale: le minacce più serie alla pace provengono da paesi
impegnati nella transizione dal vecchio ciclo di povertà, dipendenza e illibertà alle
possibilità di vita qui descritte come caratteristiche del Primo Mondo. Quando si
profilano opportunità nuove ma la gente non riesce ancora a coglierle, quando lo sviluppo
economico conosce una forte accelerazione ma la crescita sociale e politica stenta
a decollare, matura una miscela di frustrazione e di irresponsabilità che alimenta
la violenza. Tale violenza a volte è individuale e indiretta, ma può anche diventare
collettiva e dirigersi contro vicini apparentemente più felici, contro membri particolarmente
fortunati del proprio ambiente, o anche contro entrambi. È vero che la combinazione
di sviluppo economico, democrazia politica e società civile solitamente produce un
clima di tolleranza all’interno e relazioni internazionali pacifiche, ma la strada
che porta a questo risultato è piena di tranelli e di tentazioni. Per dimostrarlo,
basterà ricordare un’opera del 1915 di Thorstein Veblen, La Germania imperiale e la rivoluzione industriale. Ogniqualvolta un paese ancora tradizionale imbocca questa strada, gli altri hanno
ragione di seguire la sua avventura con timori e speranze.
Non intendo dire che questi ultimi siano condannati alla povertà. Al contrario. La
seconda precisazione della mia tesi iniziale sul Primo Mondo è che la società civile, la cittadinanza,
è incompatibile con il privilegio. Questo vale non solo in politica interna, in un
paese dato, dove il privilegio è per definizione una negazione della cittadinanza
degli altri, ma anche sul piano internazionale. Fino a quando alcuni paesi sono poveri
e, ciò che conta ancora di più, condannati a restare tali, perché vivono del tutto
al di fuori del mercato mondiale, la prosperità resta un vantaggio ingiusto. Fino
a quando ci sono individui che non hanno diritti di partecipazione sociale e politica,
i diritti dei pochi che ne fruiscono non possono considerarsi legittimi. La disuguaglianza
sistematica – diversamente dalla disuguaglianza comparativamente accidentale all’interno
del medesimo universo di opportunità – è incompatibile con gli assunti civili del
Primo Mondo.
Questo è un giudizio morale, ma non solo: a tale riguardo è eloquente il caso dell’immigrazione.
In via di principio è inaccettabile che dei paesi civili ostacolino il libero movimento
delle persone. Tuttavia è innegabile che per la Svizzera, tanto per fare un esempio,
consentire a chiunque lo desideri di sistemarsi sul suo territorio in condizioni di
parità con i suoi cittadini vorrebbe dire mettere in pericolo la qualità di vita di
questi ultimi. Allora che fa? Accoglie coloro che possono offrire un contributo utile,
per esempio quello di evitare i lavori più sgraditi ai propri abitanti, ma rende i
primi cittadini di seconda classe: essi non solo non hanno diritto di voto, ma possono
essere rimandati «a casa loro» con breve preavviso. La maggior parte, comunque, non
vengono accolti affatto; e, per attuare questa politica, si deve creare tutta una
complessa macchina capace di presidiare non solo i confini, ma anche l’interno del
paese. Le umilianti esperienze delle persone in cerca di asilo in molti Stati del
Primo Mondo sono altrettanti atti d’accusa in contrasto con le loro pretese di civiltà;
tuttavia il problema non è di quelli che si prestino a soluzioni semplici.
O meglio: c’è una sola risposta, e non è semplice. È l’universalizzazione dei benefici
del Primo Mondo: ciò che ha finito per essere chiamato ‘sviluppo’. Ci sono persone
più qualificate di me per esprimere un’opinione su questa galassia di questioni. Oggi
noi sappiamo per certo, ammesso pure che non lo sapessimo già prima, che lo sviluppo
economico e sociale di un paese dipende dall’assistenza esterna non meno che da uno
sforzo interno. Sappiamo anche che alcuni grandi paesi, specialmente in Asia ma anche
nell’America Latina, si sono incamminati con tanto successo sulla strada dello sviluppo
almeno economico che il vecchio Primo Mondo incomincia a vedere in essi una pericolosa
concorrenza. Quando si parla di Terzo Mondo, oggi si pensa per lo più all’Africa,
con cui però non si intendono la Tunisia o il Sudafrica liberato. Lo sviluppo, quindi,
è possibile – anzi è una realtà.
Senonché è un processo non solo precario, ma anche lungo, il quale sta preparando
all’umanità il periodo più denso di minacce della sua storia. La cosiddetta esplosione
demografica; i pericoli dell’aggressione militare, aggravati dalla vasta diffusione
di armi letali o addirittura nucleari; l’intégrisme militante, ossia il «fondamentalismo» (che io preferisco chiamare con il termine francese,
che sottolinea la non-differenziazione tra religione e preoccupazioni secolari come
lo stato di diritto); il protezionismo nei confronti dei beni non meno che delle persone:
questi e altri mali sono tutti sottoprodotti possibili e, anche troppo spesso, reali
delle prime fasi dello sviluppo, destinati ad accompagnarci nel corso delle prossime
generazioni. Quante generazioni? Due? Tre? Certamente si tratterà di un periodo ben
lungo. Eppure il processo che vi troverà svolgimento è necessario, non perché a guidarlo
sia la mano invisibile della storia (questo residuo hegeliano è del tutto estraneo
alla mia prospettiva popperiana), ma perché i valori di una società «illuminata» e
civile esigono che al privilegio subentrino dei diritti generalizzati – in ultima
analisi, se non una cittadinanza cosmopolita, almeno dei diritti civili estesi a tutti
gli esseri umani nel mondo.
Aggiungiamo una terza precisazione alle due appena svolte e il quadro apparentemente sereno da cui abbiamo
preso le mosse ci sembrerà ancora più cupo. La terza precisazione è molto legata al
punto di vista di Karl Popper e, molto prima di lui, al panta rhei di Eraclito: tutto scorre, non esiste stabilità, nemmeno per le promesse della prosperità,
della società civile e della democrazia. Nel parlare delle conquiste degli Stati Uniti,
della Gran Bretagna e perfino della Svizzera e della Svezia, all’inizio di questo
saggio ho usato il passato un po’ di volte, e la cosa non era casuale: a volte si
ha l’impressione che la grande stagione stia per concludersi, o che sia quanto meno
in pericolo. Dopo aver delineato in queste prime pagine un panorama della situazione
attuale, nella parte centrale del saggio intendo concentrare l’attenzione su questi
pericoli che incombono sul Primo Mondo, per concludere poi con alcune modeste raccomandazioni
su come neutralizzarne gli effetti e, forse, le cause.
I paesi dell’OCSE, per dirla in modo molto diretto e sbrigativo, hanno raggiunto un
livello di sviluppo in cui le opportunità economiche dei loro cittadini mettono capo
a scelte drammatiche. Per restare competitivi in un mercato mondiale in crescita devono
prendere misure destinate a danneggiare irreparabilmente la coesione delle rispettive
società civili. Se sono impreparati a prendere queste misure, devono ricorrere a restrizioni
delle libertà civili e della partecipazione politica che configurano addirittura un
nuovo autoritarismo. O almeno questo sembra essere il dilemma. Il compito che incombe
sul Primo Mondo nel decennio prossimo venturo è quello di far quadrare il cerchio
fra creazione di ricchezza, coesione sociale e libertà politica. La quadratura del
cerchio è impossibile; ma ci si può forse avvicinare, e un progetto realistico di
promozione del benessere sociale probabilmente non può avere obiettivi più ambiziosi.
Forse i paesi esclusi dal cerchio incantato troveranno per primi una via d’uscita
da questo guazzabuglio, ma è difficile che ciò possa accadere a molti. Sarà così del
Messico e di altri Stati particolarmente fortunati dell’America Latina? La cosa di
gran lunga più probabile è che essi condivideranno il disagio euro-americano. Oppure
ci riusciranno i paesi dell’ex «Secondo Mondo» comunista, ora diventati post-comunisti?
Chiaramente essi sono impegnati sui tre obiettivi dell’opportunità economica, della
società civile e della libertà politica. O si dovrà pensare alle tigri e ai draghi
dell’Asia? Oppure alla Cina? Per ora quasi tutti questi paesi rimuovono il problema
nella forma in cui è stato formulato qui, in quanto sono alla ricerca di una rapida
crescita economica che si sposi con una robusta coesione sociale, senza preoccuparsi
troppo di promuovere insieme stato di diritto e democrazia politica. Così, se accettiamo
il progetto, siamo di nuovo al mondo dell’OCSE, compresi alcuni membri importanti
e lontani come il Giappone.