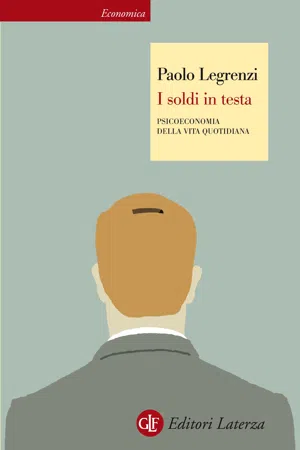L’educazione finanziaria a scuola e in famiglia
Ci sono due fatti incontrovertibili, uno negativo e l’altro positivo. Quello negativo è che quando una famiglia si scinde, padre e madre se ne vanno per conto loro e i figli in genere stanno con la madre. I dati mostrano che, il più delle volte, in questi casi le cose si mettono male sul piano economico. Non sempre, anzi raramente, la madre è economicamente autonoma, indipendente. La possibilità che le cose non vadano per il verso giusto di solito non viene tenuta esplicitamente in conto da ogni singola famiglia, al momento del suo formarsi. Purtroppo sappiamo sul piano statistico che il fenomeno di separazioni e divorzi è in aumento. Il fatto positivo invece è che le eredità, cioè i beni trasmessi da genitori e parenti, costituiranno un importante aiuto per la prossima generazione. Rispetto all’eventualità sempre più probabile di due genitori che si separano, questo è un fenomeno meno imprevedibile, a livello di singola famiglia. Anche se purtroppo un divorzio intacca molte volte anche le eredità.
Ricordo questi due fatti non perché spinto, nel caso delle famiglie, da uno spirito bigotto e dall’auspicio irrealistico che i genitori stiano sempre insieme, anche forzatamente, per mero tornaconto economico; al contrario, perché ritengo che sia proprio tale auspicio irrealistico a innescare quello spirito bigotto che continua a considerare come “normale” una tipologia di famiglia che è statisticamente eccezionale. E così va a finire che in Italia tutta la retorica per la famiglia e la maternità si traduce poi in una spesa che è l’1,2% del Pil, contro una percentuale superiore al 3% nei paesi nordici e al 2% in Germania, Francia e nella media della Unione dei quindici paesi europei.
Non ricordo il ruolo delle eredità nemmeno per un invito alla pigrizia, a una fatalistica attesa. A nessuno si può augurare di sopravvivere e arrangiarsi in attesa della trasmissione di beni intergenerazionali, un passaggio necessario e prevedibile, ma inatteso nei modi e nei tempi. Il benessere si accompagna a un’autonomia economica e psicologica, raggiunta con le proprie forze. Questi due fatti ci devono piuttosto ricordare come non siano solo fattori di ordine economico a influenzare il tenore di vita di una famiglia e a rendere difficile l’allevamento e l’educazione dei figli. Una famiglia unita può resistere alle crisi economiche, come quella in corso, può far fronte agli alti e bassi dei propri risparmi e all’altalenante tenore di vita; una famiglia disunita incontra maggiori difficoltà. Questo è ovvio. Meno ovvio è come si debba impostare l’educazione economica di un bambino, di un ragazzo o di un adolescente, in modo che da grande si trovi meno probabilmente in balia di queste contingenze avverse.
Alcune “precondizioni” – che non hanno a che fare con le conoscenze economiche – costituiscono la dotazione più efficace per affrontare, da grandi, le sfide del lavoro, del risparmio, degli investimenti e di tutte le scelte connesse all’ambito economico-finanziario, inteso in senso lato. In altre parole qui non si tratta di un problema di acquisizione di nozioni economiche, e tanto meno finanziarie, ma di educazione a forme di comportamento che costituiscono le premesse per un’autosufficienza finanziaria.
Immaginate due quindicenni. Uno ha già imparato rudimenti di economia, il funzionamento basilare dei mercati, sa cosa è una banca e come servirsene, padroneggia nozioni del tipo: conti correnti, assegni, mutui, azioni, obbligazioni e tutte le altre nozioni spicciole di finanza utili per la vita di tutti i giorni. L’altro invece non sa nulla di tutto ciò. Ha solo imparato a essere tenace, a posporre i godimenti in vista di un obiettivo, a resistere alle frustrazioni e a non scoraggiarsi, ad avere fiducia negli altri e a non interagire con il prossimo partendo con un atteggiamento iniziale di chiusura (cfr. le ricerche già citate sulla fiducia in se stessi e negli altri). Quale ragazzo è più attrezzato per la vita economica dei prossimi decenni? Di sicuro il secondo. Non è compito della famiglia impartire nozioni finanziarie, anche perché queste sono spesso ignorate dagli stessi genitori. Non è neppure compito della famiglia insegnare che cosa siano i prezzi, i costi sommersi e i costi opportunità, cioè i modi di pensare economici, e tanto meno spiegare ai figli come funziona la mente umana (a un’infarinatura di psicologia è preferibile piuttosto il buonsenso, cioè nessuna conoscenza scientifica). L’educazione in famiglia deve porre le premesse per una dotazione culturale che è la pre-condizione necessaria per rendere efficaci tali nozioni. E lo farà tenendo presente la cultura in cui il bambino dovrà vivere da grande.
Immaginate di essere un genitore e di trovarvi nelle situazioni qui descritte. Che cosa fareste?
Per ogni storiella avete quattro possibilità di risposta.
Provate a segnare con tre punti quello che vi sembrerebbe il comportamento più sensato, con due quello un po’ meno, con uno quello da evitare e infine assegnate zero punti a quello che non andrebbe mai fatto. Vi riporto i suggerimenti di Janet Bodnar, considerata, negli Stati Uniti, tra le più esperte del settore.
1) prato
Tua figlia ha tagliato l’erba del prato di casa fin da quando aveva 12 anni. Ora ne ha 14. Vorrebbe guadagnare un po’ di soldi. Vorrebbe farsi pagare da voi e si offre di occuparsi anche del prato del vicino. Le viene risposto:
A. Va bene, usa pure la nostra benzina e il tagliaerba.
B. Chiedi al piccolo del vicino di tagliare i prati di entrambi.
C. Taglia il nostro prato. È tuo dovere. Non sarai mai pagata.
D. Usa la nostra falciatrice per il vicino. Noi ti daremo, in cambio di falciatrice e benzina, metà di quanto guadagni con il vicino.
La graduatoria suggerita da Janet Bodnar è la seguente: la risposta preferita è la D, punteggio 3; segue A, punteggio 2; poi C, punteggio 1; infine B, 0.
Ora la risposta B è chiaramente poco ragionevole, se non assurda. Interessante è invece il confronto tra C e D. La risposta D viene suggerita da Bodnar: in questo modo si insegna l’uso del denaro e si premia l’imprenditorialità. Quando io ero piccolo, e curavo il nostro prato fin da quando avevo dieci anni, non avrei neppure osato fare una domanda del genere: la risposta scontata dei miei genitori sarebbe stata C.
A mio avviso questo è un caso interessante per mostrare le diversità culturali. Agli statunitensi Bodnar consiglia D, dato che comunque a 16 anni i figli vanno fuori di casa (almeno quelli del ceto medio-alto, per cui è pensato il test). In Italia invece c’è il pericolo che restino in casa fino alla fine dell’università, se non oltre: forse è meglio C! La risposta C separa chiaramente il lavoro vero, pagato da terzi sconosciuti (e non dal vicino, amico dei genitori) e i doveri domestici.
Non c’è una risposta giusta. E tuttavia, se scegliete lo stile da cui discende D, poi dovete essere coerenti, così come se preferite C. La risposta A premia l’imprenditorialità, ma non insegna l’uso dei soldi: quindi è di sicuro peggio di D.
2) acquisto vestiti
Avete deciso che vostra figlia è abbastanza grande da poter scegliersi e comprarsi i vestiti da sola. Le consegnate una certa somma e lei approfitta di una svendita. Torna e ha acquistato vestiti orrendi:
A. Le lasciate tenere i vestiti, ma poi parlate con lei sul tipo di abiti che le stanno bene e che durano a lungo.
B. Resistete con sopportazione e tolleranza: a lei i vestiti acquistati piacciono e ha speso poco.
C. Commentate: «Sapevo di non potermi fidare di te».
D. La costringete a farsi accompagnare per restituire i vestiti.
Graduatoria suggerita: A, B, D, C. Difficile non concordare (e tuttavia, una madre italiana, forse, potrebbe pensare che il buon gusto non s’insegna a freddo, ma si acquisisce in casa con gli esempi. Forse una madre italiana l’avrebbe accompagnata in un’atmosfera di divertimento e complicità).
3) auto e benzina
Vostro figlio prende l’auto e sta per uscire per un appuntamento. Inoltre vi chiede 20 euro:
A. Gli dite che non sapevate dell’appuntamento. Gli domandate dove va.
B. Gli date 20 euro e 10 euro in più per la benzina.
C. Gli dite che deve usare la sua “paga”, come già stabilito.
D. Gli date solo 10 euro per la benzina.
Graduatoria suggerita: C (3), A (1), esclusi sia B che D (0).
Qui il comportamento preferito consiste nel fissare una “paghetta mensile”, che cambierà d’importo con l’età e le circostanze, per poi osservare rigidamente il seguente criterio: il figlio deve fare tutto con la sua paghetta. Non c’è dubbio che questa è la strategia da usare se decidete di dargli una paghetta. Altrimenti è preferibile non dargli nulla, e metterlo in condizione di chiedervi ogni volta ciò di cui ha bisogno e a che scopo.
Un’educazione che vuole dare l’idea “vera” del lavoro e della paga preferisce forse questa seconda soluzione, che diventa obbligata se siete poveri.
4) lavoro e voti
Mentre frequenta l’università, vostro figlio lavora per quattro notti ogni settimana e i suoi voti ne risentono. Voi:
A. Gli date voi i soldi guadagnati lavorando.
B. Lo fate smettere di lavorare.
C. Non fate nulla: è grande.
D. Gli dite di studiare di più e di ridurre le notti oppure smettere.
Janet Bodnar preferisce D, seguita da B. Un’educazione autoritaria forse propenderebbe per C (che Bodnar però esclude), sempre che per educazione autoritaria si intenda una forma di allevamento dei figli basata su una serie di regole, valide fintantoché si sta in famiglia. Quando il figlio poi esce dalla famiglia e va nel mondo si presuppone la sua totale autonomia; a questo punto imparerà da solo a partire dai suoi errori.
Questa storiella è un altro esempio di differenze culturali. In Italia andrebbero forse incoraggiati autonomia e lavoro, inteso come lavoro vero e non come paghetta. Negli Usa è importante studiare più e meglio di altri: il titolo universitario di qualità fa accedere a posti di lavoro migliori, soprattutto in un momento di crisi. Il problema però è sempre la coerenza nello stile educativo generale in cui deve collocarsi la formazione al lavoro e all’autonomia economica.
Vi risparmio tutti e venti i quesiti del test di Janet Bodnar. Di fatto quello che lei suggerisce come comportamento ottimale consiste nel dare una paghetta, nello spingere i ragazzi a fare lavori temporanei, a casa e fuori casa (meglio), e infine nell’imparare a gestire un bilancio personale. All’università, poi, è cruciale fare molto bene. Non c’è dubbio che questa sia la migliore strategia nel contesto statunitense, se la famiglia appartiene al ceto medio. La stessa Janet Bodnar racconta come, da piccola, vivesse in una famiglia povera. Non veniva data alcuna paghetta, ma si doveva aiutare molto in casa. Gli esempi di tenacia e laboriosità dei suoi genitori hanno contato molto di più, secondo lei, di un’educazione all’uso dei soldi e alla gestione di un proprio bilancio.
In altre parole, la stessa esperta Bodnar suggerisce di usare una strategia educativa diversa in funzione del tipo di famiglia e di ambiente in cui il bambino, e poi il ragazzo, si trova a vivere. È più rilevante quel che il bambino vede rispetto a quel che gli viene detto e raccomandato. Ovviamente un bambino si confronta anche con gli altri. Un’educazione permissiva nei confronti dei soldi e dei consumi, la non comprensione dell’utilità dei sacrifici connessi al risparmio, vanno oggi valutati alla luce di quelli che saranno gli scenari futuri della prossima generazione, almeno in Italia. È interessante inoltre confrontare i tre libri statunitensi più di successo nel campo dell’educazione finanziaria con i problemi odierni dell’economia americana. Il testo più recente, quello di Bodnar, non spende neppure una riga su quello che è il problema oggi più grave negli Stati Uniti, l’indebitamento delle famiglie e dei singoli.
Tra ...