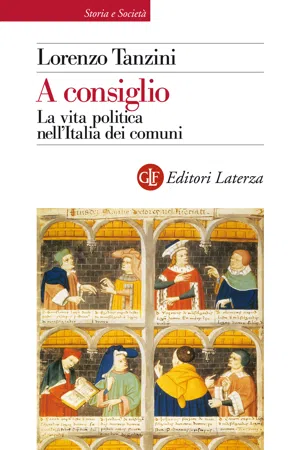1. Le assemblee alle origini del comune
Pisa, 1090 circa
Alla fine degli anni Ottanta dell’XI secolo la società pisana era attraversata da duri conflitti tra le famiglie più in vista della città. Fedeli alle loro tradizioni aristocratiche, le consorterie pisane si confrontavano in maniera violenta, innescando spesso una complicata trama di faide e vendette, e finivano per riempire la città di torri e fortificazioni, costruite per difendere i propri spazi e fornire ricetto ai propri armati nei ricorrenti episodi di guerriglia urbana. La corsa alla costruzione delle torri e al loro innalzamento cominciava ad essere pericolosa, e d’altra parte pareva che nessuno in città fosse in grado di porvi rimedio.
Pisa, in verità, stava già sperimentando una forma molto originale di autogoverno, perché da pochissimi anni un collegio di una dozzina di cittadini scelti a rotazione annuale – i cosiddetti consoli – aveva assunto l’incarico di gestire la giustizia e gli affari militari della città. Anzi, in questo senso Pisa detiene il primato del cosiddetto regime consolare, perché l’uso di affidare poteri pubblici ai consoli si sarebbe diffuso di lì a poco anche in molte altre città italiane, dando il via alla più antica forma di governo comunale: negli anni intorno al 1100 oltre a Pisa anche Lucca, Arezzo, Pistoia, Genova, Asti avevano i loro consoli. Questi però erano una magistratura a composizione sociale molto elitaria: ne facevano parte solo le famiglie dell’aristocrazia urbana, i cosiddetti milites, mentre tutto il resto della cittadinanza (l’80, forse 90% della popolazione) restava fuori da ogni rappresentanza politica. Di conseguenza, quella dei consoli si rivelava un’istituzione efficace quando si trattava di dirimere singole questioni, ma lo era molto meno quando il problema erano gli stili di vita di quella stessa aristocrazia che teneva in mano la magistratura: i consoli appartenevano alle stesse famiglie – e spesso erano anche le stesse persone – che si dedicavano con gran foga alla costruzione delle torri e alle sanguinose faide urbane. Difficile chiedere loro di limitare se stessi.
La soluzione fu trovata ricorrendo ad un soggetto terzo, al quale andava l’unanime considerazione della cittadinanza. Il vescovo Daiberto, primo nella storia pisana a portare il titolo di arcivescovo, era un ecclesiastico di grande prestigio, destinato a divenire pochi anni più tardi il primo patriarca latino di Gerusalemme liberata dai crociati. Daiberto dunque, in una data imprecisata tra il 1088 e il 1092, fu incaricato di emettere un lodo arbitrale che, noto come il «lodo delle torri», sarebbe diventato uno dei documenti più famosi nella storia dell’Italia comunale. Non tanto per il contenuto: il vescovo non faceva più di quanto richiestogli, cioè definire alcuni divieti in ordine alla costruzione e all’innalzamento delle torri, in modo che la corsa alle fortificazioni private non arrivasse a livelli intollerabili per l’ordine pubblico. La novità era piuttosto nei modi in cui Daiberto stabiliva che quelle regole fossero rispettate. A garante dell’osservanza del lodo il vescovo poneva direttamente il «popolo pisano» inteso collettivamente; e visto che un riferimento simile restava inevitabilmente generico, il testo specificava che ogni eventuale querela o reclamo dovesse essere presentato e discusso nel «comune colloquio della città», e che aggiornamenti o deroghe ai contenuti del lodo in nome della pubblica utilità fossero affidati al «comune consiglio della città», ovvero alla decisione della maggioranza dei buoni e sapienti pisani.
Per quanto si tratti di un testo breve e molto isolato, oltre che di datazione incerta, tanto è bastato per far parlare del lodo di Daiberto come della prima carta costituzionale del comune. Per la prima volta, infatti, si immaginava un sistema di governo affidato alla riunione di tutti i cittadini e al voto della maggioranza per le decisioni nelle materie più delicate. Che poi si trattasse dell’emersione di un nuovo sistema di governo, e non semplicemente di un episodio, lo testimoniano anche gli elementi materiali dell’evento. Come ricordano i documenti successivi, dal 1111 in poi, il luogo in cui consoli e cittadinanza si riunivano era a Pisa la cosiddetta curia marchionis, la corte del marchese, cioè lo spazio dove i marchesi di Toscana – gli antichi funzionari pubblici dell’impero carolingio – tenevano le loro sedute giudiziarie. ‘Occupare’ quello spazio con l’assemblea testimoniava eloquentemente la volontà delle istituzioni collegiali del comune di sostituire gli ufficiali pubblici di una tradizione ormai esausta nel loro ruolo di governo della città.
Il lodo pisano del 1088-1092, insomma, è il primissimo atto nella storia delle assemblee pubbliche delle città comunali. Il primo di cui abbiamo notizia, ovviamente; ma, se si ricorda come anche la magistratura dei consoli fosse nata proprio nello stesso torno di anni, è difficile non avere l’impressione di un sistema politico che si sta costruendo proprio in questo momento. E si sta costruendo in forma eminentemente consiliare: non si tratta di magistrati che decidono in solitudine, ma di assemblee, ristrette nel caso dei consoli, molto allargate nel caso del comune colloquium, ma pur sempre assemblee, luoghi di discussione e confronto di pareri. La tumultuosa vita sociale cittadina aveva bisogno di sedi del genere per esprimere la sua varietà di soggetti e di idee.
Venendo al concreto, non ci è dato sapere cosa fosse esattamente il comune colloquio della città, né se quel comune consiglio si debba intendere come qualcosa di distinto o solo come un modo diverso di chiamare la stessa assemblea. A proposito di parole, altre città italiane, soprattutto settentrionali, avrebbero usato per assemblee del genere il termine arengo, una parola dalle oscure ascendenze germaniche, oppure concio o semplicemente parlamentum, comunque con un riferimento insistito all’immagine del parlare, del consiglio come luogo della parola. Un’assemblea di tutti i cittadini – beninteso dei cittadini maschi e maggiorenni – senza un ruolo costituzionale preciso, a cui si poteva però ricorrere per definire situazioni di conflitto o di incertezza, o per convalidare l’incarico dei consoli, come una sorta di «punto zero» della rappresentanza del potere in città. Tutto questo, fermo restando il ruolo dei consoli, ai quali spettava la gestione più ordinaria delle faccende del comune.
L’esempio di Pisa è fortunato perché molto più precoce di qualsiasi altra città, ma nel giro di alcuni anni anche altri centri comunali ebbero i loro consigli: nel 1135 i consoli di Piacenza formularono una nuova legge su una materia molto delicata, la reversibilità delle concessioni fondiarie (affitti e locazioni a lungo termine), e il provvedimento, tra i più antichi in materia di tutta l’Italia comunale, venne «confermato dal popolo piacentino nella comune concione». Nel 1142 a Venezia, prima ancora che le fonti comincino a parlare di comune, compare la notizia di un consiglio minore, anche se poi si dovrà aspettare fino al 1172 per averne uno «maggiore». Quel nuovo stile di potere stava insomma mettendo radici in tutta Italia.
Per quel poco che ne sappiamo, un paio di elementi paiono tipici delle assemblee cittadine di questo periodo. Sono consigli in cui si vota: anche nel lodo di Daiberto si parla di maggioranza. Certo, sarà stato difficile definire con precisione la maggioranza in un consiglio di qualche migliaio di persone riunite in piazza, ma neppure dovremmo pensare a convocazioni plebiscitarie del tutto passive, perché anche una moltitudine ha i suoi modi per far intendere che un’opinione è preferita ad un’altra, a patto che qualcuno si prenda l’onere di elaborare le proposte da discutere, cosa che con ogni probabilità facevano i consoli. E oltre a questo, i vari colloquia e consilia che compaiono in questo tempo di inizi hanno già qualche forma di mediazione istituzionale. Si trattava di assemblee di tutti i cittadini, o di tutti quelli disposti a parteciparvi, ma quando le fonti parlano di boni o sapientes è difficile non immaginare una cerchia ristretta di consiglieri eletti; si può immaginare insomma che una qualche forma di embrionale organizzazione governasse la massa tumultuante dei cittadini in piazza.
Ma perché si scelse di ricorrere a forme così impegnative e originali di partecipazione? E perché proprio ora? La risposta non si può che cercare nelle circostanze particolari degli episodi che troviamo nelle fonti. A Pisa, l’abbiamo appena visto, un’esigenza di salvaguardia dell’ordine pubblico aveva convinto il vescovo a ricorrere alla cittadinanza nel suo complesso, il populus, e a forme più o meno rudimentali di espressione della collettività, in mancanza di poteri superiori in grado di far valere le proprie decisioni sulla città. L’esempio di altre città ci può aiutare a precisare il quadro. Quando nel 1148 i consoli di Genova vollero introdurre un decreto sul nuovo diritto di famiglia da applicare nelle cause cittadine, lo fecero nella chiesa di San Lorenzo, la cattedrale, «nel pubblico parlamento»; e un anno dopo, in occasione dell’appalto di un dazio sulle merci in transito dal porto, le decisioni dei consoli vennero prese «con la licenza e per volontà di tutti i consiglieri».
Il fatto è che provvedimenti come questi non erano l’applicazione di norme già scritte: Genova aveva già, è vero, un suo breve consulum, cioè una sorta di canovaccio degli obblighi solennemente assunti dai consoli al momento dell’ingresso in ufficio, redatto nel 1143, ma le norme che vi venivano espresse erano poca cosa rispetto alla varietà delle situazioni che i consoli si trovavano a gestire ogni giorno, a maggior ragione in città portuali come Pisa o Genova, piene di affari, di genti le più disparate e beninteso di conflitti di ogni tipo. Era giocoforza, insomma, creare ogni volta una regola, attingendo al serbatoio delle antiche consuetudini della città, reali o presunte tali. E nulla di meglio, per rendere presente la consuetudine, che ricorrere all’insieme dei cittadini. Proprio per questo partecipare ad assemblee come queste era, prima ancora che una opportunità, un dovere.
Restando a Genova, il 1157 conserva il più antico testo noto della Compagna, cioè la prima forma di giuramento collettivo di fedeltà all’autorità del comune. Nella formula con cui tutti i membri del comune giuravano c’era pure l’impegno a partecipare alle assemblee: «quando udrò la campana che suona per il parlamento, o la campanella che chiama il popolo per le vie della città [...] mi recherò al parlamento per confermare i consoli». Il mezzo con cui il parlamentum viene convocato non è solo una nota di colore. In un periodo in cui non esiste uno spazio riservato appositamente alle assemblee, e quindi ci si riunisce nelle piazze o, come abbiamo appena letto, nelle chiese più grandi, il carattere più materiale e riconoscibile dell’assemblea più che un luogo è il suono della campana. Il variare dei rintocchi delle campane scandiva le ore del «tempo della chiesa», il suono sinistro dei campanelli segnalava il passaggio degli infami – i lebbrosi, i condannati, le prostitute –, mentre le trombe di guerra chiamavano i cittadini alla difesa delle mura; e di nuovo il paesaggio sonoro della città si animava di un suono apposito per la vita pubblica, che interrompeva le occupazioni quotidiane per chiamare ogni uomo adulto ai suoi doveri di cittadino.
C’è poi un secondo risvolto di queste prime forme di assemblee di cittadini, quello militare. Già nel lodo di Daiberto il problema della violenza era non espresso ma comunque presente in maniera implicita. Anni dopo, quando si giunse a redigere il più antico breve dei consoli cittadini, nel 1162, la connessione tra l’assemblea e il problema della guerra era invece più che chiara. Ogni console, all’entrata in ufficio, avrebbe giurato che «non sarò in alcun consiglio né in alcuna azione intenzionale per cui il popolo pisano entri in guerra se non con il parere concorde [...] della maggior parte di coloro che saranno convocati al consiglio al suono della campana».
Quello di convocare i cittadini prima di prendere decisioni sulla guerra non era uno scrupolo, per così dir...