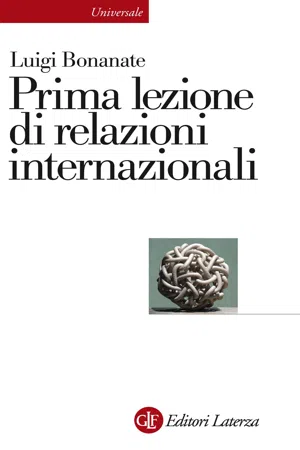I. Il mappamondo
1. Un giro del mondo
È presto detto: le relazioni internazionali sono tutto ciò che succede nel mondo e che interessa anche coloro che non ne sono direttamente coinvolti, come se qualsiasi evento, ovunque accaduto, dovesse per natura incidere sulle condizioni di tutto quanto il pianeta.
Proprio questa è la ragione che mi spinge – ogni qual volta mi trovi ad affrontare un problema empirico delle relazioni internazionali (vedremo tra poco che quest’ultima espressione è tutt’altro che ingenua o neutra) – a gettare uno sguardo sul mappamondo, o meglio ancora su un atlante che sprigiona lo straordinario fascino del vagabondaggio, dello sconfinamento, dell’immensità del pianeta, delle sue condizioni di vita (nord e sud, est, ovest, e così via) e di pluralismo storico-politico-sociale (città, confini, Stati, civiltà, culture, monumenti), in cui tutto è collegato a tutto. In termini ben più suggestivi, ce lo aveva già detto Kant alla fine dell’analisi del Terzo articolo definitivo per la pace perpetua (1795): «la violazione del diritto avvenuta in un punto della terra è avvertita in tutti i punti». Poco più di un secolo dopo (1929), lo attualizzò Valéry a modo suo: «Ormai, quando una battaglia scoppierà in qualche parte del mondo, nulla sarà più facile che farne sentire il cannone su tutta la terra» (1931, p. 942). Osservare un mappamondo o farlo ruotare sul suo asse per veder comparire pianure e montagne, mari, laghi e fiumi che da nulla sono separati se non dalla casualità delle loro contingenze telluriche, le quali tuttavia, nei secoli o nei millenni, hanno visto realizzarsi intorno a loro o dentro di loro straordinarie trasformazioni politico-sociali-organizzative: lo aveva ben capito già Erodoto! Ed è per questo che i miei occhi vagano quasi inavvertitamente sul planisfero che campeggia sulla parete del mio studio; ma è del 1870 e dunque non contiene nessuna delle indicazioni precise e aggiornate che si possono trovare invece nella più recente edizione di un atlante ricchissimo di informazioni e stampato su carta patinata multicolore. Nei più di cento anni che separano queste carte geografiche, quanti eventi hanno trasformato non tanto i loro profili materiali ma la loro collocazione «politica», i loro confini, cioè, ampliati o ristretti, i loro destini che non possono essere disgiunti dalla determinazione della posizione materiale, a nord o a sud, a est o a ovest – nulla di deterministico, sia ben chiaro, ma l’assunzione nel nostro quadro informativo dell’intreccio inestricabile tra la «natura della cosa» e la sua «storicità».
Si intuisce facilmente che lo studio di tutto ciò che ha, di per sé, portata planetaria debba essere un qualche cosa di molto importante e nello stesso tempo di grande fascino e complessità. E quindi non può non stupire che, invece, nell’ambito della distribuzione e ripartizione dei saperi (ciò che normalmente viene formalizzato attraverso la determinazione delle discipline oggetto di studio nelle università), tale consapevolezza abbia tardato non poco ad affermarsi, al punto che – e lo vedremo più precisamente più avanti – il primo insegnamento di «relazioni internazionali» è stato impartito (da Alfred Zimmern) soltanto a partire dal 1919 presso la piccola Università di Aberystwyth, nel Galles. Ciò significa che la storia di questa disciplina è breve: neppure un secolo in effetti o, appunto, all’incirca tanto. Può essere davvero una buona occasione per un suo primo bilancio.
Poiché una vita internazionale, in qualche misura e anche se con nomi variati, è sempre esistita, la sua tardiva affermazione non può non essere la testimonianza di una qualche specificità culturale, o di una qualche difficoltà storico-politica nel farla nascere. Com’è possibile che lo studio di ciò che avviene nel mondo, che ha al suo centro – tutti lo sanno – quella storica antichissima tradizione (un’abitudine, non una necessità) che si chiama guerra, sia stato tanto a lungo negletto o addirittura dimenticato o tralasciato a favore di altre prospettive o dimensioni della stessa realtà? Nel rispondere a questa domanda, potremmo trovarci ad affrontare un primissimo, semplice aspetto, tuttavia capace di conseguenze devastanti, che potremmo così riassumere. Se è vero che gli eventi internazionali riguardano gli Stati e se lo è anche che a questi ultimi succede di incontrarsi/scontrarsi per i motivi più vari, e di combattersi o di stringere armoniose e amichevoli alleanze, ebbene perché non accostarsi a tutto ciò proprio dal punto di vista degli Stati, i cui problemi saranno certamente tanti e staranno sicuramente alla base delle loro azioni, delle decisioni che i loro governanti prendono, cosicché la giustapposizione delle vicende di tutti e di ciascuno di essi possa darci la rappresentazione complessiva del mondo e dei suoi diversi «stati» (condizioni, modi di essere)?
Questa domanda è rimasta lungamente senza risposta nel mondo scientifico e ha impedito allo studio specialistico delle relazioni internazionali di affermarsi, consolidarsi e svilupparsi, trascurando la condizione assolutamente unica, esclusiva e originale della loro esistenza. Diciamolo con le parole di Raymond Aron, quello che a me continua ad apparire il massimo rappresentante di una disciplina che tuttavia egli non ha mai insegnato all’università (eleggere quest’ultimo capoclassifica può sembrare una violazione, dato che la disciplina risulta essere praticamente dominata dalla cultura anglosassone, ma si vedrà più avanti che buone ragioni per questa scelta non mancano). Il grande studioso francese così definiva sinteticamente le relazioni internazionali: esse «si svolgono all’ombra della guerra o, per servirci di un’espressione più rigorosa, le relazioni tra Stati comportano per loro essenza l’alternativa della guerra e della pace» (Aron, 1962, p. 24 trad. it.). Non basta un’affermazione così perentoria a richiamarci immediatamente all’eccezionalità assoluta del caso (chi stentasse a collocare la guerra al centro delle vicende umane ricordi, ad esempio, che la sola seconda guerra mondiale fece morire cinquanta milioni di persone)? Scorderemo addirittura di occuparci delle questioni che attengono alla vita e alla morte degli Stati nonché di tutti quegli esseri umani che di tempo in tempo si trovano a calpestare il territorio di questo o quel paese? Trascureremo che ciascuno di essi abbia un regime politico, un disegno o una missione storica, una società e uno sviluppo intellettuale e ideale, che si interroghi sul bene e sul male, il giusto e l’ingiusto? E che cosa diremo dei diritti individuali dei loro cittadini, così frequentemente piegati alla volontà di potenti e prepotenti come canne al vento, senza che reali progressi democratici siano mai riusciti davvero a cambiare il mondo (Bobbio, 1991, ult. cap.)?
È comprensibile, dunque, che il benvenuto che do all’inizio dell’anno accademico alle matricole che frequentano il mio corso consista proprio nell’informarli che stanno iniziando a studiare quella che è la materia (lo dico un po’ enfaticamente, ma il resto di questa nostra Lezione lo dimostrerà) più importante e affascinante che esista al mondo! E come negare che capire come funzioni politicamente il mondo, quali siano le ragioni che lo tengono in pace o in guerra (o in una di quelle situazioni intermedie che nella storia si danno), e che fanno sì che la ricchezza materiale così come la salute dei popoli e delle persone, delle masse oppure di ristrettissime élite, sia proprio quanto di più interessante (e gravido di conseguenze) esista al mondo? Non foss’altro che in termini di dimensioni materiali (l’intero pianeta) si tratta di un’affermazione ben difficilmente controvertibile. Potremmo ridirlo osservando che se non si introducono le dimensioni internazionali nella realtà complessiva che vogliamo comprendere e di cui vogliamo svelare i meccanismi e le caratteristiche non se ne capirà mai nulla, e che, addirittura, a trascurarle si rischia non soltanto di non capire, ma anche di causare dei danni, a noi stessi e a chiunque altro, per l’incapacità che denoteremmo di graduare l’importanza dei fatti che contraddistinguono le vicende degli abitanti della terra.
Come si sarà intuito, le fasi iniziali della disciplina sono state tutt’altro che facili, il che mi suggerisce, in limine, di offrire alcuni rapidissimi scorci su ciò che essa avrebbe potuto essere, è stata e potrà in futuro essere.
2. Guide, maestri e modelli
Senza eccedere in esoterismo, giustifico subito la ragione per cui ho fatto fin dall’inizio riferimento, invece che ad alcuni grandi e riconosciuti classici della disciplina, ad alcune personalità (e alle loro opere) che hanno avuto un ruolo decisivo nella formazione di chi sta scrivendo queste note – ciò che sarebbe del tutto insignificante se non fosse che quelle sono anche tra le più rilevanti dell’intero ventesimo secolo e quindi sono ben note non soltanto a me ma a tutti – e possono testimoniare che la storia delle relazioni internazionali trascende, in se stessa, qualsiasi specializzazione, avendo a che fare (come ebbe a dire il filosofo austriaco Günther Anders) con «il ramo fine del mondo» (1959, p. 110 trad. it.).
Si tratta di Paul Valéry (1871-1945), Raymond Aron (1905-1993) e Norberto Bobbio (1909-2004). Sento già il coro di proteste che potrebbe provenire non soltanto dagli Stati Uniti – la sola, unica, esclusiva e riconosciuta patria della disciplina – ma anche dall’Italia, dove nessun elenco dei classici delle relazioni internazionali comprende opere di questi tre autori. Ma, introduttivamente, si legga questo passo (e se ne coglierà immediatamente la straordinaria suggestione):
Considerate un planisfero e, su questo planisfero, l’insieme delle terre abitabili. Questo insieme si divide in regioni e, in ogni regione, vi è una certa densità di abitanti, una certa quantità di uomini. A ciascuna di queste regioni corrisponde anche una certa ricchezza naturale, un suolo più o meno fertile, un sottosuolo più o meno ricco, un territorio più o meno irrigato, più o meno facile da attrezzare per i trasporti, ecc.
Tutte queste caratteristiche permettono, in qualsiasi epoca, di classificare le regioni di cui ci occupiamo, in modo che, in qualsiasi epoca, lo stato della terra vivente possa essere definito attraverso un sistema di disuguaglianze fra le regioni abitate della sua superficie (Valéry, 1919, p. 35 trad. it.; corsivo aggiunto).
Pochi oramai sanno che nel 1931 il famosissimo poeta Paul Valéry pubblicava anche dei Regards sur le monde actuel che, letti oggi, ci direbbero sullo stato del mondo e in particolare sull’Europa e le sue vicende ben più di quanto gli studi attualmente correnti non dicano – un’ottica saggistica, certo, ma densa di suggestioni e di spunti di riflessione capaci di suscitare quella curiosità e quello spirito di investigazione che stanno alla base di ogni impresa scientifica. Valéry potrebbe essere una vera e propria «guida» nel viaggio tra le complessità e gli scogli dell’analisi internazionalistica, mentre nessuno più di Aron potrebbe essere considerato il nostro «modello» sia per la sistematicità dell’impianto interpretativo con cui affrontava l’analisi dei grandi problemi planetari, sia per l’incisività delle interpretazioni e la sua straordinaria capacità poligrafica (filosofo, sociologo, politologo, economista, editorialista, ecc.), che gli permise di toccare, della guerra e delle relazioni internazionali, tutti e ogni aspetto rilevante. Paix et guerre entre les nations è il più vasto, ampio, vario trattato di relazioni internazionali che sia stato finora scritto, capace di spaziare dalle condizioni demografiche delle società mondiali alle determinanti geografiche ed economiche, dalla teoria strategica alle questioni etiche sollevate dall’apparizione dell’arma atomica, dalla modernizzazione delle forme di sistema internazionale alla teoria delle alleanze come dei giochi. Tanto, e tanto a lungo, si è sporto sul problema della guerra che infine, quasi paradossalmente, conclude: «Se parliamo della guerra [...] ci troviamo dinanzi a un argomento fino a un certo punto scoraggiante, in quanto il fenomeno è endemico e conserva in ultima analisi qualcosa di misterioso» (Aron, 1967, p. 170 trad. it.), come ammonendoci sull’immensa difficoltà di penetrare a fondo in quello che rimane il fenomeno più importante e sconvolgente della storia umana, la guerra. Oggi l’opera risulta inevitabilmente datata dalla trasformazione radicale fortunatamente intervenuta nella politica nucleare delle grandi potenze, cosicché una certa parte dell’opera è obsoleta e superata, ciò che non succede invece al terzo dei nostri autori, Norberto Bobbio (un vero «maestro»), i cui scritti (quasi mai specificamente legati alla dimensione delle relazioni internazionali) sulla natura della guerra, sulla sua teoria, le sue giustificazioni e le sue cause offrono ancora oggi la più profonda e illuminante introduzione ai problemi della convivenza internazionale (Bobbio, 1979) a cui possiamo riferirci, di volta in volta, quando grandi e frequentemente drammatici avvenimenti incombono su noi, introducendo un innovativo nesso tra rifiuto della violenza e democrazia (anche internazionale): «Che cosa è la democrazia se non la prima introduzione del metodo nonviolento per risolvere i conflitti politici?» (Bobbio, 1981, p. 137).
3. Un’introduzione vera e propria
Ben consapevole della trasgressione appena operata non collocando alcuno studioso anglosassone nello scaffale assegnato ai massimi specialisti della nostra disciplina, tornerò ora nei ranghi, più convenzionali ma tutt’altro che banali o fuorvianti, della ricerca dei fondamenti delle relazioni internazionali radicandoli nella loro stessa storia, muovendomi su due diversi e complementari piani: quello della storia vera e propria della disciplina, strettamente diacronica, interna alla disciplina, che ripercorre le sue fasi di sviluppo e di crisi (che in nessuna disciplina sono mai mancate); per poi affrontare invece quella sincronica, della collocazione di una disciplina nuova che irrompe in un ambito strutturato e ordinato di saperi consolidati e «normali» (come direbbe Thomas Kuhn, nel fare riferimento al patrimonio dato e condiviso delle conoscenze standard ritenute comuni ed essenziali per tutti coloro che si rifanno a un qualche determinato ambito del sapere), tra i quali non dovrebbe trovarsi alcuna lacuna che una volta scoperta destabilizzi la loro armonia prestabilita.
Incominceremo da questa seconda dimensione, per affrontare la quale mi si dovrà concedere – come prima di un duello si fa con colui che appare fin dall’inizio il più fragile – la scelta delle armi: in tal caso chiederei di ricorrere, piuttosto che al fioretto, all’accetta! Non per sete di violenza né tanto meno per farmi giustizia da solo, ma per mettere bene in chiaro che non soltanto le origini ma anche lo sviluppo e le fasi mature della disciplina continuano a essere discusse e contestate sulla base di schematismi talmente rozzi e aprioristici che davvero l’esigenza di stabilire con chiarezza confini, competenze, limiti rispettivi, interdipendenze e incroci, accumulazioni o differenziazioni richiede prepotentemente di essere rispettata. Sarà utile, l’accetta, anche per districarsi nella selva delle specializzazioni disciplinari che – intorno alla nostra disciplina – si sono lungamente aggrovigliate. Due buone ragioni spiegano queste difficoltà iniziali.
La prima è totalmente nominalistica: se davvero nomina sunt consequentia rerum (Giustiniano, Institutiones, II, 7, 3) si dovrà ammettere che la confusione iniziale abbia avuto un suo peso. Che cosa vuol dire in effetti l’espressione «relazioni internazionali»? Essa ha due diversi significati: fa riferimento in prima istanza a una «cosa», cioè all’insieme degli eventi della vita internazionale così come si succedono giorno per giorno o nei secoli – si tratta di fatti, insomma. Ma quando in una università, in qualsiasi parte del mondo, uno studente si accinge a sostenere un esame di «relazioni internazionali», egli sta invero muovendosi nell’ambito disciplinare del più ampio settore della scienza politica del quale le relazioni internazionali sono soltanto una parte! Ma il mistero è presto sciolto: convenzionalmente la «scienza politica» è un’etichetta, dato che essa ricomprende: a) lo studio della politica; b) quello delle amministrazioni pubbliche e delle burocrazie (oggi prevalentemente ci si riferisce ad esse con la formula «organizzazioni complesse»); c) le relazioni internazionali, rectius la politica internazionale. Storicamente le cose si sono stabilizzate di modo che il primo nome (sub a) è rimasto retaggio della prima sottodisciplina, diventata così «scienza politica» tout court; la seconda è diventata «scienza dell’amministrazione» e la terza – ecco l’equivoco – è rimasta con lo stesso nome, «relazioni internazionali», cosicché – ora appare chiaro a tutti – è proprio vero che uno stesso nome significa due cose sostanzialmente diverse: a) la «realtà materiale» che è, b) oggetto di «ricerca scientifica» (potremmo aggiungere: politologica). Le relazioni internazionali sono dunque nello stesso tempo la cosa e la disciplina che la studia! È un po’ come se la disciplina scientifica che studia la società si chiamasse... società e non sociologia, e quella che studia la politica si chiamasse politica e non scienza politica (o politologia).
Non è il caso di insistere, ma a nessuno sfuggirà che la mancata chiarezza sul nome stesso della disciplina non poteva non aumentare le difficoltà di un settore di studio che per mille motivi (lo vedremo tra poco) già stentava a farsi largo tra gli altri e specialmente i più vicini. Si potrebbe tuttavia estendere la portata di questo equivoco fino a un punto estremo, simbolico di tutte queste difficoltà: non mancherebbe infatti (e nei secoli non mancò davvero) chi sostenesse che i rapporti tra entità statuali distinte siano talmente circoscritti alle contingenze della guerra e della pace che non ci sarebbe proprio nulla da studiare o da capire, cosicché non varrebbe neppure la pena scomodare altre più paludate e tradizionali discipline (come la storia o il diritto) per raccontare o spiegare tutto ciò. Ma chi ha creato ancor più confusione in tutto questo problema fu, involontariamente, il filosofo inglese Jeremy Bentham con il ricorso che fece, nell’Introduction to the Principles of Morals and Legislation (pubblicata nel 1789, lo stesso anno della rivoluzione francese), alla parola «internazionale» per distinguere la giurisprudenza «interna» da quella relativa a «membri di Stati diversi». Egli poi in una nota (che può esser considerata l’atto di nascita della parola) commenta:
La parola internazionale, bisogna riconoscerlo, è nuova, per quanto, si spera, sufficientemente confacente ed intelligibile. È adatta ad esprimere in un modo più espressivo il ramo del diritto che va comunemente sotto il nome di diritto delle nazioni, un appellativo così poco indicativo, che, se non fosse per la forza dell’abitudine, sembrerebbe riferirsi piuttosto alla giurisprudenza interna. Leggo che il cancelliere D’Aguessau ha già fatto una simile osservazione, dicendo che quel che comunemente viene chiamato droit des gens, dovrebbe essere chiamato piuttosto droit entre les gens (Bentham, 1789, pp. 437-38 trad. it.).
È vero che Bentham si riferisce al diritto e non alla politica, ma la simmetria tra le due dimensioni, in questo caso, è assolutamente evidente. Grazie alle sue parole possiamo persino seguire il ragionamento che lo guidò. Fino ai suoi tempi, tutto ciò che riguardava i rapporti tra collettività distinte, tra popoli lontani e differenti e poi, da quando se ne formeranno, tra Stati sovrani, veniva riportato sotto la formula latina dello ius gentium, e più raramente dello ius inter gentes. Ma è ovvio che, da un lato, con il passar del tempo il riferimento alle varie gentes perde di consistenza, perché sudditi e poi cittadini non sono sempre e soltanto persone nate nello stesso posto, come sarebbe secondo l’originaria formula latina (la gens è il gruppo sociale dal quale si discende), e, dall’altro, che quando una parola nuova tende ad affermarsi è, come in questo caso, per cogliere un aspetto nuovo e originale della realtà (o che quanto meno non era ancora stato sottoposto a una riflessione consapevole e attenta). Nomen omen, diremo con Plauto, ovvero il nome è un presagio, indica il destino di una cosa – ed è proprio ciò che successe con il dato dell’internazionalità, dove ciò che rileva massimamente è il prefisso «inter», che è quella intorno a cui si gioca tutta l’importanza della novità. Quando i rapporti tra collettività distinte si fanno tanto frequenti e costanti da poter essere considerati una delle cure principali degli statisti, ecco che balza al primo posto dell’attenzione il dato dell’inter-dipendenza tra gli Stati, fondato non soltanto sulla loro coesistenza ma sul gioco delle loro...