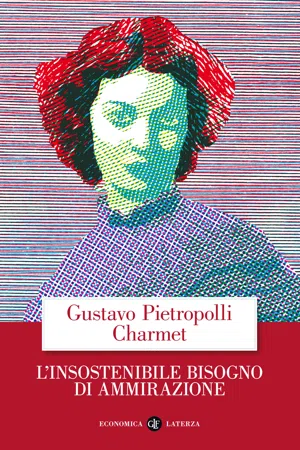1.
Un illimitato bisogno di ammirazione
1. All’origine del bisogno di ammirazione
Nel corso di una peregrinazione sprezzante e sfiduciata nella terminologia psichiatrica e psicologica per intercettare un termine che rendesse ragione di ciò che mi sembra perseguiti tutti coloro che cercano di mettersi in salvo dal rischio di vergognarsi del corpo e dell’imbarazzante scarsità di fascino che riescono a sprigionare, mi sono imbattuto con meraviglia nel termine non tecnico «ammirazione». Questo termine ha saturato quasi del tutto il bisogno di raccontare gli incantesimi della spasmodica ricerca di catturare lo sguardo dell’altro, senza rischiare di connotarla come una condizione psicopatologica o una banalissima moda effimera e superficiale.
La ricerca di ammirazione ritengo sia una vicenda da chiunque comprensibile, persino dai bambini più piccoli, anzi forse da loro dovremmo farci spiegare l’origine remota del bisogno di essere teneramente rispecchiati mentre si cerca di crescere ma si soffre dei limiti e delle difficoltà frapposte dalla cultura degli adulti e dai rituali educativi vecchi di millenni oltre che dei limiti imposti dal corpo ancora fragile e debole.
Lo sguardo dell’altro e in generale lo sguardo sociale comunque somministrato, anche virtualmente, è il regista indiscusso dell’eventualità di cadere in vergogna o viceversa di assurgere al godimento dell’ammirazione, anche se fulminea, effimera, e spesso notata e apprezzata solo dall’interessato che è lì apposta per misurare gli effetti della propria fatica e dei mille sacrifici autoimposti.
L’ammirazione consiste concretamente in una sorta di aggancio visivo, un abbordaggio reciproco degli sguardi che si incontrano come raggi di luce nel buio: l’aggancio visivo alla base dell’ammirazione è confrontabile con quello che si realizza al debutto della vicenda amorosa o nella sfida satura di odio e di bisogno di violenza radicale e immediata di due contendenti furibondi. Lo sguardo dell’ammirazione è molto meno penetrante, più rapido ed effimero, sfiora la mente e l’anima del ricercatore di ammirazione ma lambisce senza penetrare, non modifica e non nutre, è solo un segnale, un timbro che certifica l’esistenza e la sua relativa dignità di accesso allo spazio sociale. Da quel momento essere lì e partecipare al lavoro, allo studio, al gioco o alla guerra è praticabile, legittimo e non ha più bisogno di convalida, ormai si fa parte della task force deputata a salvare quello che rimane del senso. Poi naturalmente sono necessarie ulteriori convalide non solo del valore ma soprattutto della necessità e utilità della propria presenza: manifestazioni quali l’applauso, che oggi si spreca persino ai funerali oltre che ai matrimoni, gli abbracci e le strette di mano, quelle ricche di sottintesi che grondano approvazione e bisogno di contatto per poter dire di aver addirittura toccato l’idolo, che era lì a portata non solo di sguardo ma anche di mano.
Questi preliminari non sono una condizione destinata a durare a lungo, sono solo il trampolino da cui decollano altri fenomeni cruciali perché servono a convalidare l’evento iniziale che ha sancito l’esistenza sociale del soggetto. Non c’entrano la stima, l’amore, la devozione e altri stati affettivi che caratterizzano le relazioni sociali dotate di specifica intensità, in questo caso si tratta solo di un’atmosfera di compiacente copresenza nel medesimo spazio sociale, di una allusione a una speciale comune appartenenza che consente di capire il valore al di là della prestazione, è solo un’utile premessa per potersi intendere.
L’ammirazione incrementa blandamente l’autostima, ma è difficile da acquisire ed è talmente traumatica, allorché sopraggiunge, che crea dipendenza, cioè nostalgia acuta dell’evento meraviglioso nel corso del quale si sono accese finalmente le luci e il soggetto è uscito di scatto dal cono d’ombra in cui consumava l’attesa della convocazione da parte della vita e delle luci dei riflettori sociali.
Poiché si tratta di un evento relazionale che aggancia due sguardi e comunica contenuti ineffabili e difficilmente verbalizzabili è utile chiedersi quale sia il funzionamento mentale dell’erogatore di ammirazione e cosa promuova in lui il decollo dei fenomeni destinati eventualmente ad essere percepiti ed utilizzati dal destinatario come documento segreto di ammirazione. Ciò che funziona da motorino di avviamento della costruzione dell’ammirazione è effettivamente una sorta di riconoscimento nel soggetto di qualche caratteristica che affascina non eroticamente ma antropologicamente, uno stimolo all’interesse per la persona e il suo misterioso portato, l’impressione che si tratti di un altro da sé che però conserva e accenna a una comunanza non tanto di competenze ma di motivazioni, di talenti acerbi che stentano a diventare vera capacità espressiva e capacità di simbolizzazione.
Altre volte si tratta di risonanze empatiche, l’impressione di una condivisione remota e profondissima di una condizione simile di partenza, di una difficoltà vissuta e forse in parte superata, di un dolore sperimentato e ancora presente nella memoria e nella storia vivente della persona. L’ammirazione non è né amore né desiderio di conoscenza ma contemplazione, curiosità positiva, bisogno di lasciar parlare, di sentire raccontare, di immaginare futuri possibili, una piccola invidia nel sentirsi esclusi e nel non potere né essere né condividere appieno.
L’arrivo di un nuovo compagno di classe in una scuola superiore può suscitare diverse reazioni ma anche attizzare in qualche sconosciuto coetaneo l’impressione di una strana ammirazione, di una curiosità benevola, di un’accoglienza rispettosa, di un’apertura di credito positivo in attesa delle inevitabili verifiche. L’ammirazione ha una parentela stretta con la meraviglia: è perché il soggetto suscita meraviglia che si accende l’ammirazione, ma si tratta di esperienze emotive fulminee, di attimi fuggenti; per chi sperimenta i precursori dell’ammirazione non si tratta di una esperienza forte che entra a far parte dell’identità affettiva del soggetto, ma rimane in superficie, e in fondo non si tratta neppure di un’emozione veramente gradevole e positiva poiché l’ammirazione prevede la non condivisione e la non appartenenza iniziale e quindi somministra la dolorosa esperienza dell’esclusione ontologica da ciò che si ammira, che rimane circonfuso da un alone di magia ineffabile. Poi si vedrà e dal caos emotivo del primo sguardo si diraderanno le nebbie e si scorgerà il profilo del soggetto e si misurerà il suo valore per così dire reale.
Recarsi a un incontro mondano, a una festa organizzata, a una cena con molti sconosciuti e pochi amici o parenti, pone dolorosamente con impeto la questione dell’essere riusciti o meno a suscitare almeno stille di ammirazione curiosa e benevolente, col rischio di avvertire il dolore della trasparenza, dell’ombra in cui si vive e che accompagna ovunque rendendo la propria presenza insignificante, lontana dalla capacità di suscitare un secondo invito, un rilancio motivato dal bisogno di capire meglio il segreto. Nella complessità estrema della vita sociale, a qualsiasi livello il soggetto si muova e sia collocato, il bisogno di riconoscimento, di rispecchiamento della propria non inutile esistenza, il desiderio di sentirsi parte del cerchio magico magari con funzioni modeste, è diventato molto forte e quindi doloroso. Precorre la delusione del non riuscire neppure a pronunciare il proprio nome e rimanere quindi sconosciuto, riconoscibile solo dall’evidenza di essere sempre lì, allo stesso posto, intento a compiere più o meno i medesimi gesti, se pure segretamente arricchiti da una forte intenzione comunicativa, per riuscire a far comparire la persona sepolta sotto la coltre del ruolo sociale e della funzione che si è costretti a svolgere.
L’ammirazione, quella autentica e difficile, non coinvolge la dimensione della bravura, della più o meno straordinaria competenza sviluppata in un’arte o mestiere; l’ammirazione riguarda il Sé e non il ruolo sociale, l’arte o il mestiere che si è chiamati a svolgere. È il Sé profondo, la persona che cerca l’ammirazione, che ha bisogno dello sguardo empatico, della meraviglia e della sorpresa, non è l’operaio, l’artigiano, l’impiegato o il professionista che ha sete di ammirazione ma la persona che porta in giro per le strade del mondo il proprio mestiere. Fare bene o in modo mirabile il proprio mestiere può diventare lo strumento che il soggetto utilizza per far intravedere la persona e la sua specificità, quella sì desiderosa di riconoscimento e di donazione di valore e di senso. Non è ciò che si sa fare, non è la bravura che deve suscitare ammirazione, ma è la straordinaria persona che recita quella parte che ha bisogno di applausi: essere bravi è un’altra faccenda, l’idolo non è mai l’attore o il famosissimo cantante bensì la persona che recita o canta quella parte e che si intuisce essere del tutto speciale anche per come recita o canta, ma lo sarebbe lo stesso anche se non lo sapesse fare perché la sua arte non è in discussione, ciò di cui si discute al tavolo della vita e del valore è la persona e le sue ineffabili caratteristiche.
È diventata davvero importante la complicata questione dell’ammirazione perché ciò che conta socialmente sono le imprese e le azioni compiute al fine di riuscire ad ottenere anche dosi omeopatiche di ammirazione. Ciò che sorprende maggiormente è la qualità e la quantità di violenza, il numero elevato di reati che vengono consumati e la diffusione inarrestabile di corruzione che sembra finalizzata ad acquisire ingiusti profitti, ed è senz’altro vero, ma spesso è anche l’espressione del bisogno di comperare a qualsiasi prezzo un po’ di luce, di notorietà, di ricchezza sorprendente, di attenzione sbigottita da parte del pubblico riluttante, che non ha mai voluto mantenere la promessa del successo e del riconoscimento anche economico.
Dal punto di vista della mia disciplina le vicissitudini innescate dal bisogno di ammirazione e dalla conseguente fuga dalla vergogna sono relativamente comprensibili, quantomeno da un certo punto in poi; la causa prima della crisi, invece, non si riesce a chiarirla se non cumulando una congerie di motivazioni di tutti i tipi, economici, antropologici, politici, sociologici, anche se la mia impressione, che poi riferirò, tende a una semplificazione radicale che mi sembra utile quanto meno per cominciare a discutere sulle misure da intraprendere per bilanciare il culto del Sé con il rispetto del bene comune.
Ciò che è successo negli ultimi decenni, con una accelerazione imprevedibile e mai sperimentata dalla collettività, è la frana degli ideali e dei valori condivisi da qualche secolo: era tempo che succedesse, lo avvertivano tutti che era anacronistica tutta l’impalcatura moralistica che sovrastava la vita individuale e collettiva. La si conservava per amore e soprattutto per timore di Dio, per rispetto formale del potere del padre e quindi della Patria e dello Stato, della Legge e della Costituzione, ma nel frattempo gli stili di vita e le consuetudini dei cittadini cambiavano alla velocità della luce.
La liberazione dei costumi sessuali non è una conseguenza della crisi etica ma una delle sue cause, le pari opportunità fra maschi e femmine e quindi una vita di coppia finalmente intima e condivisa, la diminuzione delle nascite, la contraccezione e il conseguente rispetto radicale della natura del bambino e la sua idealizzazione, l’avvento sulla scena sociale degli adolescenti e delle masse giovanili, delle loro musiche e danze e la loro idiosincrasia nei confronti del tempo passato, se non per ciò che concerne alcuni eterni gruppi musicali, l’immane libertà della coppia finalmente libera di nascere e morire in base ai tempi degli affetti e della natura dei legami, la riflessione critica delle donne e mille altri cambiamenti di forma e di contenuto delle relazioni intime, amorose, amicali hanno contribuito a scavare il terreno sotto ai piedi del patriarcato che ad un certo punto si è inabissato con quasi tutto il suo cerimoniale serioso, solenne, ma noiosissimo e ormai non utilizzabile nel nuovo contesto delle relazioni fra gli adulti e i bambini, gli uomini e le donne, i gruppi e le persone singole, anche quelle apparentemente isolate, ma anch’esse contaminate dalle radiazioni del nuovo.
In sostanza il grande cambiamento è consistito nella rottamazione del patriarcato, quindi dell’esercito, della guerra, della dittatura, dell’autoritarismo nelle sue molteplici forme e nella presa del potere da parte dei giovani, delle donne e dei bambini, notoriamente inesperti nella gestione della cosa pubblica, ma esperti mondiali di relazioni affettive, di benessere, di felicità, di creatività, di pace. Naturalmente il patriarcato per un po’ è rimasto a guardare e si è interessato di finanza e globalizzazione, ma poi ha capito che il mondo faceva sul serio e che il processo era irreversibile. Ne è derivata l’apertura dell’attuale conflitto fra le generazioni con le ricadute che sono sotto gli occhi di tutti: i vecchi hanno i soldi e il lavoro, i giovani hanno davanti a loro un mare di tempo libero e quindi sono invidiati dai vecchi che hanno il denaro ma non hanno più tempo ed è evidente chi dei due è più ricco; avere il futuro è meglio che avere solo il passato ed un terribile presente in cui i soldi non servono più a nulla e sono solo una possibile eredità.
Di fatto, per ciò che riguarda la riflessione centrale di questo saggio, al posto del padre non siede più nessuno: le madri hanno rifiutato l’incarico di formare il nuovo governo, alle donne il potere non interessa, se non quello che deriva dalle relazioni, i giovani fanno chiasso ma non sono ancora organizzati per comandare e fare le leggi, i bambini sono al potere ma attraverso dei reggenti cialtroni che non interpretano bene la loro ispirazione geniale, giocosa, creativa e pacifista e così succede che neppure le scuole finalmente in mano ai bambini funzionino modernamente perché lì l’ultima resistenza del patriarcato tiene alta la bandiera del sacrificio, della disciplina, dell’immobilità del corpo, del silenzio e dell’importanza esclusiva del passato rispetto al futuro che non si può insegnare perché non si sa più cosa sia.
Al posto del padre c’è un vuoto che per alcuni è preoccupante, ma se si osserva bene il suo posto è stato occupato dal Sé individuale: è lui che comanda, che sancisce cosa è giusto e cosa è ingiusto. Il fatto che, invece che nei confronti del padre, la venerazione e il rispetto siano ora diretti nei confronti dello sviluppo e centralità del Sé, del suo potere e della sua felicità, della sua crescita e visibilità, delle sue relazioni e del suo habitat ha delle conseguenze enormi perché fra la legge del padre e il desiderio del Sé c’è sempre stato un abisso. Oggi siamo socialmente confrontati con l’intreccio inestricabile delle istanze di realizzazione del Sé che rendono impossibile formulare una legge che vada bene alla collettività poiché essa non ha più voce e si alza verso il cielo l’urlo di milioni di Sé ognuno dei quali ritiene di avere ragione a reclamare una regola che sia a lui favorevole e lo sostenga nella crescita in ricchezza, benessere e potere sociale: è difficile riuscire a piantare un albero e sradicarne uno è impossibile, così come è difficile scavare un buco nel monte o un sottopasso in città, mentre è molto più facile legittimare le unioni civili fra omosessuali poiché quando si tratta di relazioni fra Sé qualcuno alza un po’ la voce, ma è fioca rispetto all’applauso che come al solito sancisce col linguaggio della televisione commerciale la naturalità delle scelte fatte che vanno in direzione della felicità.
Il problema nasce dal fatto che il Sé non ha limiti etici, morali, collettivi: la frana dell’etica condivisa a favore dei diritti del Sé ha creato nella mente individuale e collettiva un vuoto che si riempie delle istanze del Sé libere dal confronto con valori, regole, norme che pure ci sono e sono notissime ma non sono decisive nel processo decisionale poiché ciò che tiene banco è l’interesse del Sé individuale o familiare o di gruppo. Ciò fa sì che l’istanza più profonda e naturale del Sé, il bisogno di ammirazione, se incontra degli ostacoli o se viene addirittura rinnegata e attaccata scateni nella mente individuale o collettiva una reazione di incalcolabile violenza poiché c’è di mezzo la sopravvivenza psichica, narcisistica, sociale del Sé, che ha bisogno di luce sociale, di un brusio di riconoscimento, di una continua legittimazione ad esistere e vedere riconosciuto il diritto alla bellezza, all’eterna giovinezza, alla visibilità almeno virtuale. Ciò non giustifica naturalmente la violenza e i reati ma ne indica le motivazioni e le origini e soprattutto rende ragione del dilagare della corruzione piccola e grande, dai furbetti del cartellino alle immani truffe consumate all’ombra delle banche e dei grandi investitori finanziari, non c’è più il limite etico neppure nel mondo degli affari in cui era già pallido ma ora è quasi del tutto assente e si disputa sulla furbizia e non sulla bravura e competenza che sono categorie finite nell’universo obsoleto dell’etica.
L’inseguimento dell’ammirazione in un universo senza regole è ciò che vedo dal mio osservatorio: mi rendo conto che la sociologia, l’economia e persino la criminologia hanno ampiamente da ridire su queste chiavi di lettura di indole psicologica che, almeno nel mio caso, sovvertono l’ordine dei fattori fino a sostenere che la crisi che stiamo attraversando abbia un’origine e un determinismo affettivo e simbolico che comincia con la crisi del patriarcato e che spedisce al potere i diritti del Sé individuale che sono prevalentemente di indole affettiva e narcisistica. Credo davvero che vada tenuto presente che l’accelerazione di cui tutti parlano sia dovuta al potere di diffondere mode e sottocultura della televisione e alla planetaria connessione regalata da internet, ma non credo che le macchine e le nuove tecnologie siano in grado di inventare assolutamente nulla: possono però informare a modo loro tutti gli abitanti del pianeta che Dio è zitto e il padre è stato sepolto e che per il momento ciò che succede è che tutti sono finalmente liberi di realizzare il proprio sogno che ovviamente si infrange sugli scogli della realtà immutabile...