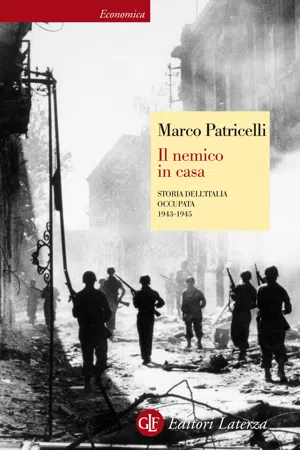1.
L’alleanza ineguale
L’inaffidabilità italiana era un pregiudizio diffuso nel Reich. Il nazismo e i proclami della propaganda orchestrata da Joseph Goebbels avevano ricoperto di brillante vernice ideologica ma non scalfito tra i tedeschi l’opaca valutazione degli alleati latini e della loro propensione all’intrigo. Lo stesso Goebbels era tra i primi a pensarla così. Un retaggio della storia. Anche il timore verso i tedeschi, in Italia, era un pregiudizio diffuso, nonostante il martellamento del Minculpop che non perdeva mai occasione per lodare il camerata germanico e il suo valore in battaglia. Anche questa era un’eredità della storia. Né Benito Mussolini né i gerarchi erano riusciti a far accettare convintamente quell’Asse con Berlino che aveva trascinato il Paese alla guerra. D’altronde il Duce non aveva mai voluto ascoltare Gabriele D’Annunzio che lo esortava a diffidare dei tedeschi e, soprattutto, dell’«Attila imbianchino» e «Charlot dei nibelunghi». Il Vate aveva coniato quest’ultima definizione nel 1934, con abbondante anticipo sul Grande dittatore di Charlie Chaplin che avrebbe ridicolizzato Hitler al cinema. Quando D’Annunzio era morto nel 1938, Goebbels nel suo Diario aveva riportato che l’Italia era in lutto ma aveva anche chiosato che il Reich non aveva alcun motivo per dolersi di quella dipartita.
Gli italiani conoscevano un volto dei tedeschi che ispirava un’istintiva presa di distanze, e non solo per la lunga e sofferta epopea risorgimentale. I soldati del Regio Esercito avevano avuto eloquenti riprove del modo tutto diverso di intendere la guerra da parte dei loro camerati, soprattutto in Russia, dove l’odio razziale verso gli slavi e gli ebrei si era manifestato con un’acredine e con eccessi incomprensibili e ingiustificabili per il loro diffuso sentimento umanitario. I soldati delle SS e della Wehrmacht disprezzavano la mancanza di durezza degli italiani verso il nemico e verso i civili, e per loro questo comportamento era un segnale di debolezza e di inidoneità a disegnare il “nuovo ordine” mondiale che Hitler indicava con la spinta e la forza della “razza eletta” ariana e delle sue Panzerdivisionen. Quando la grande e apparentemente irresistibile Operazione Barbarossa che aveva spinto il Duce a mandare le sue truppe sul fronte orientale si era incarnita in una purulenta ritirata, gli italiani avevano visto con i loro occhi anche in che modo i commilitoni della Wehrmacht intendevano la fratellanza d’armi. Sui camion non c’era posto per i disperati in grigioverde in marcia nella neve: le mani protese a sottrarsi dall’inferno di ghiaccio venivano percosse con i calci dei fucili. Fino ad allora erano stati tollerati, difficilmente apprezzati, quasi mai stimati in combattimento e nella vita di tutti i giorni in trincea o sul campo di battaglia. Tra i due alleati il rapporto era squilibrato, minato nella credibilità dal germe di una diffidenza che arrivava da lontano. In Germania, nel 1940, circolava una barzelletta che faceva più o meno così, nelle mille varianti di strada e di salotto. Il 10 giugno una riunione dell’Oberkommando der Wehrmacht impegnato nei piani operativi contro la Francia viene interrotta da un ufficiale di ordinanza che ha una notizia urgente per i generali. «Hanno appena comunicato che l’Italia è entrata in guerra!»; i generali, senza scomporsi e senza sollevare lo sguardo dalla cartina sul tavolo, osservano: «Dovremo mandarle contro una decina di divisioni»; l’ufficiale, sorpreso, interviene: «No, no, l’Italia non è in guerra contro di noi, ma con noi»; e i generali di rimando: «Allora di divisioni dovremo mandarne venti».
Un camerata ingombrante
Quando il 26 agosto 1939 Mussolini gli aveva fatto recapitare la cosiddetta “lista del molibdeno” per giustificare l’impossibilità dell’Italia di attenersi al Patto d’acciaio e di marciare contro la povera Polonia, Adolf Hitler aveva commentato sprezzante: «Gli italiani si stanno comportando con noi come nel 1914». Quando, cioè, l’Italia si era chiamata fuori dalla Triplice alleanza con Germania e Austria, per poi cambiare fronte l’anno dopo. Che gli italiani avessero le loro buone ragioni nell’uno e nell’altro caso ai tedeschi poco importava, perché la parola “tradimento” era per loro facilmente declinabile. Come il senso di vendetta. Hitler non aveva avuto bisogno degli italiani per vincere la guerra e solo con fastidio li aveva dovuti vedere in campo quando Mussolini il 10 giugno 1940 aveva infranto la non belligeranza per lanciarsi in un’avventura che riteneva breve e vittoriosa.
Se il Führer quando stava collezionando successi non voleva gli italiani neppure a prendersi le briciole della gloria di cui si copriva la Wehrmacht, nel 1943 aveva bisogno che non si sganciassero perché tutti sapevano che Winston Churchill aveva ragione quando il 14 gennaio, alla Conferenza di Casablanca, aveva definito l’Italia «ventre molle d’Europa»: il punto debole dell’Asse dove sferrare il colpo, nell’impossibilità di farlo per il momento contro la Germania. Se gli Alleati passati alla controffensiva si fossero impadroniti della Penisola, avrebbero potuto martellare il Reich dal cielo ancora peggio di quanto già facevano. La disponibilità degli aeroporti italiani avrebbe trasformato in una passeggiata la rotta verso la Germania, anche se poi sui cieli tedeschi si scatenava l’inferno. Un inferno peggiore veniva scatenato dai bombardieri americani di giorno e inglesi di notte sulle fabbriche e sulle città tedesche. La strategia adottata dagli Alleati di colpire duro l’Italia e nello stesso tempo far intravedere al popolo italiano che c’era una via d’uscita per quella guerra persa, purché scindesse le sue responsabilità dal fascismo, aveva scavato un fossato col regime nonostante si pretendesse la resa incondizionata. Infatti la reazione delle popolazioni bombardate era stata diversa e opposta a quella suscitata nel Reich: in Italia la “colpa” delle distruzioni e dei lutti non era degli Alleati che li apportavano materialmente, ma di Mussolini che aveva portato a questo; in Germania il nazismo coagulava invece il fronte interno contro il nemico esterno che arrivava per ora solo dal cielo, ma lo faceva sistematicamente. I rapporti che pervenivano dall’Italia sul malcontento della popolazione, la crescente avversione verso Mussolini e il fascismo e il desiderio di farla finita con quella guerra erano altrettanti campanelli d’allarme per il Reich. Se quell’assai probabile defezione non poteva scongiurarsi, andava allora neutralizzata. I comandi tedeschi nella settimana dal 10 al 16 maggio 1943 avevano teorizzato le linee di intervento in caso di uscita dell’Italia dal conflitto, linee che il feldmaresciallo Wilhelm Keitel mette in fase di pre-operatività il 21. L’intero scacchiere mediterraneo era a rischio. Tutta la presenza militare tedesca andava ridisegnata per coprire i vuoti lasciati dagli italiani, dove gli Alleati si sarebbero potuti proiettare, se non addirittura vedersi consegnare senza colpo ferire dal Regio Esercito ogni zona da esso presidiata. Mussolini annaspava nei marosi della bufera militare e politica. Caduta Pantelleria l’11 giugno, fa sua la richiesta del Comando supremo e chiede a Hitler con urgenza due divisioni corazzate di rinforzo, poi ci ripensa e aderisce all’idea del capo di Stato maggiore generale Vittorio Ambrosio di fare da sé richiamando in Italia le truppe di stanza in Francia e nei Balcani. Hitler non può che insospettirsi ulteriormente e dà ordine affinché tre divisioni passino le Alpi.
Il 10 luglio 1943 gli angloamericani erano sbarcati in Sicilia. L’Africa orientale era stata persa subito, la Libia da pochi mesi e ai manifesti di propaganda col gigantesco «Ritorneremo!» nelle colonie dell’effimero impero non credeva nessuno. L’isola più grande del Mediterraneo era caduta nella tenaglia angloamericana di Bernard Law Montgomery e George S. Patton e solo un’abilissima ritirata coordinata dai tedeschi aveva evitato un disastro ancora maggiore. Poi sarebbe toccato alla Penisola, ed era questione di giorni, il tempo di tirare il fiato. Gli italiani non s’erano battuti bene o male, ma come potevano: per i tedeschi questo non era sufficiente neppure a riabilitarli nella guerra in casa. Non si spiegavano perché dovessero essere loro a impedire alla marea alleata di tracimare di fronte alle incertezze italiane. Mussolini ci aveva messo di suo, dapprima con la fanfaronata del patetico “discorso del bagnasciuga”, poi mandando a combattere in Sicilia i soldati di origine siciliana: il suo ragionamento a senso unico era che avrebbero difeso le case e le cose, ma sorvolava sul fatto che il modo migliore era proprio di non opporsi a chi poteva distruggerle. L’apporto della mafia e della massoneria, nemiche giurate del fascismo, per spianare la strada all’invasione era un altro discorso, ma quella non era una battaglia che si combatteva sul campo. Per i tedeschi era difficile comprendere tutto ciò: se c’era da combattere, loro combattevano e lo facevano bene, anche se fino a Stalingrado non avevano mai perso e dopo non riuscivano più a vincere. Ma una guerra in quel modo, con un alleato che li “azzoppava” ogni volta che li chiamava giocoforza in soccorso, non poteva continuare. La “guerra parallela” di Mussolini aveva creato problemi a non finire all’Okw e si era rivelata strategicamente disastrosa: aveva costretto i tedeschi a intervenire in Jugoslavia per impedire la ricacciata degli italiani dalla Grecia, ma costringendoli a posticipare l’Operazione Barbarossa contro l’Unione Sovietica, madre di tutte le sciagure; aveva obbligato a mandare l’Afrika Korps in Libia e a supportare un Regio Esercito mal strutturato, mal equipaggiato e mal comandato. I tedeschi avevano dovuto far ricorso a giravolte diplomatiche per far capire a Mussolini che non volevano i suoi aerei antiquati nella battaglia d’Inghilterra e, dopo il tragicomico esordio sui cieli inglesi di Fiat CR42, G50, BR20, Macchi 200, erano riusciti a sbarazzarsene e rimandarli a casa. E non volevano neppure il corpo di spedizione italiano in Russia quando le cose sembravano andare in maniera travolgente, salvo poi rimpolpare le perdite con un’intera armata italiana, l’Armir, destinata alla distruzione. Il ministro della Propaganda Joseph Goebbels non aveva mancato di tacciare quell’alleato inutile e militarmente incapace di essere un peso morto nella conduzione della guerra.
Quello che i soldati tedeschi mandati in fretta e furia sul fronte meridionale non sapevano (ma forse lo speravano) è che il loro alto comando aveva previsto il cedimento italiano e aveva studiato come sostituirsi all’alleato nella conduzione del conflitto. Persino lo scenario peggiore era passato al vaglio degli strateghi dell’Okw, in un momento in cui le cose erano incoraggianti per l’Asse. Nel 1942 alcuni ufficiali avevano visitato il Belpaese come turisti: erano talmente affascinati dal territorio dell’Italia centrale che ne studiavano le peculiarità e prendevano appunti su tutto con la meticolosità dei cartografi. Infatti erano proprio cartografi. Il crollo di un eventuale fronte meridionale poteva essere arrestato in una zona ben determinata, ed era quella che prenderà il nome di Linea Gustav, nel punto più stretto della Penisola tra Tirreno e Adriatico: da Gaeta a Ortona. Il loro lavoro si vedrà sulla Truppenkarte in dotazione ai soldati tedeschi nel 1943, dettagliatissima persino sui tipi di cespugli della macchia mediterranea: una manna anche per gli Alleati quando ne cadeva una nelle loro mani, perché quelle in loro dotazione erano molto più approssimative e in scala più piccola.
A maggio del 1943 le fibrillazioni tedesche andavano di pari passo con i balbettii militari italiani. Hitler aveva già rotto gli indugi e con magniloquenza wagneriana aveva trovato anche il nome giusto per l’occupazione dell’Italia, riesumando la figura del re visigoto Alarico. Che fosse un barbaro poco importava: l’essenziale era che avesse sbaragliato le legioni del decadente impero romano e portato i suoi uomini a bivaccare nella Città Eterna. In questo non sbagliava, anche se il differente quadro storico di civiltà non lo sfiorava affatto. L’Okw partiva dal presupposto che l’Italia da sola non avrebbe saputo difendere se stessa e che quindi gli angloamericani andassero tenuti il più lontano possibile dalla Germania. Il vertice militare del piano strategico era il feldmaresciallo Erwin Rommel che ai suoi ordini, dal 22 maggio, aveva alcune divisioni in assetto di guerra pronte in Austria e Baviera da far infiltrare in tempi brevissimi e in profondità sul territorio del riottoso e sempre più diffidente alleato. Quattro giorni prima era stato lo stesso Hitler ad affidargli l’incarico di studiare le misure per occupare la Penisola e le contromisure in caso di invasione angloamericana. Se l’Italia avesse cercato di tirarsi fuori dal Patto d’acciaio e dalla guerra, tutto sommato era meglio: sarebbe terminata quella situazione amorfa fluttuante nel mare dell’ipocrisia reciproca e finalmente i tedeschi avrebbero riacquistato l’esclusività nella conduzione del conflitto, a modo loro e con i loro obiettivi. Erano loro a condurre il gioco e volevano avere le mani libere. L’Italia poteva essere una risorsa bellica importante se fosse finita nell’orbita nazista non politicamente, come era già, ma come preda. Allora le sue fabbriche del Nord avrebbero potuto essere spogliate e la popolazione idonea mandata a lavorare coattivamente in Germania, per rinsanguare così la Wehrmacht di soldati, perché le perdite sul fronte orientale erano immani e quei vuoti spaventosi andavano colmati. C’era adesso la possibilità di mettere le mani sul potenziale industriale da sfruttare e su manodopera in abbondanza, se solo quell’alleanza non fosse stata tale e nominalmente paritaria. Il pensiero di Goebbels era condiviso dai gerarchi del Terzo Reich e da alcuni vertici militari. Italia tout court come preda bellica, altro che cameratismo di facciata. Il problema era come arrivare a quel punto senza troppi scossoni che provocassero il rischio di un rovesciamento di alleanze, in quel momento insostenibile. Il Regio Esercito, per quanto svalutato e scarsamente considerato, aveva sotto le armi, seppur sulla carta, tre milioni di uomini. E se la Regia Aeronautica si era spremuta oltre ogni possibilità e gli aerei moderni erano prodotti con ritmi artigianali invece che industriali, la Regia Marina inchiodata nei porti dalla mancanza di carburante era ancora grande e temibile: il suo passaggio nelle file alleate avrebbe estromesso la Germania dal Mediterraneo e dall’area balcanica senza alcuna possibilità di opporvisi. Questo, i tedeschi, non se lo potevano permettere: se andava fatto il bottino, si doveva agire con maestria. Il primo atto era stato quello di cercare di mettere sotto amministrazione controllata la restante forza militare italiana. Ma questo neppure Mussolini avrebbe mai potuto permetterlo.
Ogni cauto sondaggio in tal senso si era scontrato contro un muro. Si doveva trovare un’altra strada per aggirare l’ostacolo. Tutte le accortezze possibili erano adoperate per non dare l’idea di un’occupazione larvata e neppure l’occasione all’Italia per denunciare il comportamento tedesco: quando era stata Roma a chiedere soldati e mezzi, Berlino aveva nicchiato sostenendo che non ce n’erano perché occorrevano sul fronte russo; adesso che erano stati trovati, per quanto in un disegno egemonico tutto tedesco, al di qua delle Alpi nessuno li voleva. Era sin troppo facile capire perché. Il coordinamento militare non esisteva più e la subordinazione totale del Regio Esercito alla Wehrmacht era il solo desiderio di Hitler e dei suoi generali. Sembrava una ripicca tra ex innamorati la richiesta avanzata da Mussolini di avere le batterie contraeree tedesche per difendere le città italiane semi-indifese e martoriate dai bombardieri e la risposta di Hitler che le avrebbe avute solo se gestite da personale tedesco. Il che era un modo per non consegnarle e per non farle accettare.
La carta della disperazione
Mussolini non sapeva come uscire dall’angolo. Aveva proibito la pubblicazione mensile dell’Albo della gloria sui giornali, perché quell’elenco di caduti deprimeva il morale degli italiani e aumentava il malcontento verso il regime. Alla vista degli italiani aveva sottratto anche i reduci della Campagna di Russia, che erano stati fatti transitare di notte e senza fermate nelle stazioni ferroviarie più importanti. Non aveva potuto impedire, però, che parlassero e raccontassero, in casa e tra amici, quello che avevano visto e vissuto, della guerra di Mussolini e di quella di Hitler, delle cui atrocità erano stati a volte testimoni. Il Duce si era riservato di giocarsi la carta della disperazione in un incontro a tu per tu col Führer. Aveva il polso del Paese, nonostante cercassero di addolcirgli la pillola con rapporti di polizia addomesticati, e sapeva che gli italiani volevano farla finita con quella guerra. I suoi vertici militari gliel’avevano detto al di là di ogni possibile fraintendimento: l’Italia era stremata e non si capiva più perché combattere, se non per un “favore” all’alleato. I tedeschi volevano fare il punto della situazione e l’avevano chiesto espressamente il 17 luglio, perché i rapporti che arrivavano da Roma erano allarmanti: gli italiani oscillavano tra il pessimismo e le inattuabili richieste di rinforzi; la tenuta del Regio Esercito non convinceva nessuno. Il vertice fissato a Feltre per il 19 non aveva nulla di amichevole, il clima era teso e le delegazioni militari non trovavano convergenze su nulla. Non potevano, poiché partivano da posizioni inconciliabili. Mussolini credeva che fosse quella l’occasione giusta per dire chiaramente come stavano le cose. Ambrosio gli aveva strappato una mezza promessa di attenersi alla concretezza: illustrare il quadro politico-militare e l’eventualità di doversi chiamare fuori da quella guerra. Ma poi la presenza magnetica di Hitler aveva paralizzato il Duce che, al primo tentativo di affrontare il discorso, era stato travolto dalla retorica sulla resistenza a oltranza. Mussolini non sa che gli inglesi avevano elaborato un ardito piano, l’Operazione Dux, mirato a ucciderlo con un bombardamento chirurgico e dare al popolo italiano una leva per uscire dalla guerra sbarazzandolo del dittatore. Il piano era stato annullato da Churchill in persona, ma se questo probabilmente salva la vita a Mussolini, sicuramente non lo salva politicamente ...