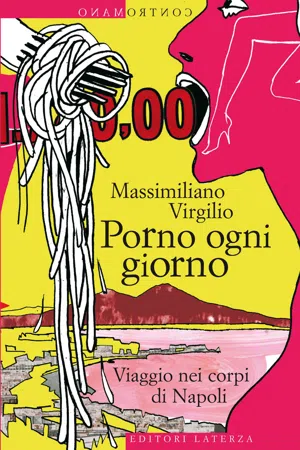Il culo di una chiesa si chiama abside
Ritorno a Sandomenico un sabato mattina di inizio autunno. C’è il sole. La temperatura è in quella dolce terra di mezzo nella quale caldo e freddo non esistono, o coesistono, fronteggiandosi senza vincitori.
Parcheggio nelle vicinanze e attraverso la piazza, inoltrandomi lungo l’ultimo pezzo di Spaccanapoli, in via Benedetto Croce. Dopo una sosta in libreria, dove, circospetto, acquisto un paio di classici della letteratura russa che ho sempre finto di aver letto, mi sposto da Gay Odin per acquistare una tavoletta gigante di fondente e un pezzo di foresta. A volte mi chiedo se avrei comunque scelto di continuare a vivere in questa città senza la mia razione quotidiana di cioccolato foresta.
Dopo aver scambiato quattro chiacchiere con la commessa, nell’ormai vano e quasi decennale tentativo di sembrarle interessante, arrivo in piazza del Gesù, compro il giornale e lì casualmente mi imbatto in due amici che non vedevo da un po’. Uno fa l’avvocato e si sta preparando per il concorso in magistratura, l’altro è ingegnere delle telecomunicazioni. Mi chiedono se ho già fatto colazione e se ho voglia di unirmi a loro. Non esco mai di casa senza la mia dose di caffè e qualche biscotto, in ogni caso dico che no, non ho fatto colazione, sediamoci pure da qualche parte. I miei amici, che danno l’impressione di essersi visti di recente, mi convincono a ritornare in piazza San Domenico Maggiore.
«Perché non qui?» domando.
«Perché non batte il sole» risponde l’avvocato, ma è solo la prontezza del civilista a permettergli di essere in anticipo sull’altro. Ha ragione. In piazza del Gesù non batte il sole. O almeno, non batte nella zona bar.
«I tempi sono cambiati» fa l’ingegnere dopo aver ordinato. «In questo bar venivamo a fare pipì quando eravamo pieni di birra. Quando mai avremmo pensato di sederci a prendere un caffè?».
«Non tenevamo soldi per fare altro» aggiunge l’avvocato.
«Sì, ma i tempi sono cambiati, non siete d’accordo?».
È così. Anche se mi fa un po’ tristezza quest’idea di tre trentenni già vecchi, già pieni di ricordi, e soprattutto già consapevoli di quanto siano cambiati i tempi. Probabilmente, è una consapevolezza obbligata. Una maturità a cui ci costringe l’epoca in cui viviamo. In effetti, in poco più di dieci anni ne sono successe così tante che nemmeno varrebbe la pena confrontarle con quelle accadute prima di noi. Questa costante e ipertrofica trasformazione, chiedo, in cosa si è vista?
La diffusione di internet, la deregolamentazione del mercato del lavoro, lo sviluppo della telefonia cellulare. I miei amici elencano almeno tre settori in cui i cambiamenti sono stati rivoluzionari e giornalieri.
Dal tavolino a cui siamo seduti non possiamo non ammirare quello che abbiamo sotto i nostri occhi. Il retro del complesso di San Domenico Maggiore, o meglio, il culo di una chiesa, campeggia orgoglioso nella piazza con il suo disegno frastagliato, ricco di gotico e di tutto quanto è stato aggiunto epoca dopo epoca, una ricostruzione dopo l’altra, esempio perfetto di quanto possa essere fluttuante l’identità di un luogo.
«I tempi sono proprio cambiati» dico. «Vi ricordate come lo chiamavamo?».
I miei amici fanno di sì con la testa, senza fiatare. Non capisco se disinteressati o imbarazzati dalla mia domanda, poi uno ritorna a sorseggiare il cappuccino, l’altro a smanettare con il cellulare.
Molti anni fa, al liceo, gli insegnanti ci portarono a una rappresentazione di Ditegli sempre di sì di Eduardo De Filippo, messa in scena per l’occasione da una compagnia di attori amatoriali. A un certo punto, durante il primo atto, il protagonista, appena uscito da un manicomio, rimbrotta i presenti sulla scena affermando: «C’è la parola adatta, perché non la dobbiamo usare?».
Ripensando ai giorni in cui popolavamo questa piazza per socializzare con altri ragazzi come noi, a quelli in cui si parlava di rinascimento, in cui si recuperava piazza del Plebiscito e si faceva largo l’idea di una città-vetrina, fantasmagorica proiezione della città reale, ripensando a tutto questo non posso fare a meno di considerare centrale la questione dell’imprecisione nel nostro linguaggio. Soprattutto perché quest’imprecisione non ha contribuito a creare nuovi e più fecondi linguaggi metropolitani, ma si è fermata a una sterile riproposizione di parole vecchie e logore, impigrendoci, privandoci della possibilità di esprimerci in modo corretto e, in definitiva, portandoci a commettere il peccato capitale di mitizzarla.
Ma l’imprecisione e l’incoerenza regnavano sovrane in tutto. Andavamo ai cortei contro la camorra e poi, sgombrata la piazza, ci dirigevamo solerti nel vicolo a comprare il fumo dai camorristi. Andavamo a una retrospettiva di cinema tedesco, ma a fine film ci alzavamo di scatto per non doverci sorbire il dibattito. Andavamo in biblioteca, ma dopo aver occupato una postazione con sciarpe e borse, trascorrevamo gran parte del tempo sulle scale a bere caffè, fumare e parlare con qualche ragazza. Di imprecisione in imprecisione, c’era rimasto spazio solo per una vaga e cialtronesca voglia di divertirsi, accanto a una presunta dimensione civile. Per alcuni il termine preferito era (e tuttora è): militanza.
La piazza con il culo di una chiesa. Sorridevamo alla parola culo. Sorridevamo all’idea di aver aggiunto un culo a una chiesa. Sorridevamo all’idea di essere storti, capovolti, eccezionali, e così facendo, impelagati con l’ennesimo vuoto di birra, non abbiamo mai veramente messo piede in quella magnifica basilica gotica. Se l’avessimo fatto avremmo scoperto che quel punto che noi definivamo ‘il culo’, invece, costituisce l’esterno dell’abside. Dunque, le parole adatte esistono. Non ci resta che usarle.
Dopo aver salutato i miei amici, con la promessa di rivederci presto, faccio un giro in piazza. C’è una certa animazione. Palazzo Corigliano, sede dell’Università «L’Orientale», in questi giorni è occupato dagli studenti in segno di protesta contro i tagli programmati dal governo in carica. Dentro di me ho un sussulto. Forse, mi dico, grazie a quest’occupazione Sandomenico tornerà allo splendore di qualche anno fa.
Decido di entrare nella basilica. Il tempo di fare una breve ricognizione e incappo in un custode che sta sfogliando un quotidiano seduto nella sagrestia. Subito iniziamo una chiacchierata sulla storia della basilica. In verità, la discussione scaturisce da una mia domanda sulla sorte toccata al tesoro di San Domenico. Il custode mi guarda di sbieco.
«Tesista?» chiede.
«No, sto scrivendo un libro».
A quelle parole, come tutti coloro che scrivono libri sanno benissimo, il mio interlocutore ha iniziato a guardarmi con sospetto. Un sospetto frutto dello stupore piuttosto che dell’inimicizia.
«Su San Domenico?» mi chiede.
«Non proprio».
«Su Napoli?».
«Anche sì».
Il custode mi guarda, vorrebbe chiedermi: «Insomma, di cosa parla questo libro?», passo quindi i successivi cinque minuti a spiegarglielo e chissà come, da tutto quel discorso che credevo articolato e complesso, il custode decide di soffermarsi su una parola: ‘corpi’. Di corpi quindi, ritenendo di dover fornire il suo contributo narrativo, inizia a raccontare. Dei corpi che conosce, innanzitutto di quelli sepolti nelle casse da morto che affollano il ballatoio della sagrestia di cui è il responsabile.
Oltre vent’anni fa, racconta, i feretri sono stati aperti. All’interno, quasi intatti, c’erano i corpi di molti reali napoletani. Gli studi hanno accertato l’identità di quelle mummie – alcune delle quali conservatesi senza subire alcun processo di imbalsamazione – nonché le cause del decesso. Pare che Ferrante i sia morto con un tumore al colon, mentre Maria d’Aragona di sifilide. Tra i vari corpi, poi, è stata rinvenuta una mummia priva di testa, secondo alcuni appartenente alla famiglia Petrucci, cospiratrice nella famosa Congiura dei Baroni. Antonello Petrucci, segretario del re Ferrante, dal quale aveva ricevuto in dono un palazzo in piazza San Domenico Maggiore, fu uno dei principali congiurati contro il monarca. È una storia di promiscuità molto napoletana. Il fidato amico che tradisce, e che per questo è stato giustiziato, riposa da oltre cinque secoli poche casse più in là di colui che l’ha fatto decapitare, nella chiesa accanto al palazzo in cui ha vissuto. C’è stato un tempo, a Napoli, in cui congiurati e vittime della congiura vivevano a braccetto, in perfetto stile faida criminale dei giorni nostri.
«Per non parlare della promiscuità sessuale» aggiunge il custode. «Le malattie erano diffusissime».
Tutti andavano a letto con tutti. Sifilide, gonorrea, figli illegittimi, congiure, nepotismi, titoli nobiliari regalati. Non so se si tratta di notizie storicamente accertate, ma il custode sembra esserne così convinto da fiaccare in me ogni pretesa di documentazione diversa dalle sue parole.
«Se i francesi non l’avessero rubato assieme al prezioso ostensorio, avreste ammirato il cuore di Carlo d’Angiò» dice con rammarico.
Nel decennio murattiano all’inizio del Diciannovesimo secolo, i francesi stabilitisi a Napoli fecero razzia di molti tesori in città. Il complesso di San Domenico fu adibito a caserma militare e alcuni edifici religiosi vennero abbattuti. Non so perché, ma il fastidio con cui il custode pronuncia la parola ‘francesi’, e il tono seccato con cui narra di ogni momento della discontinuità politica, ricorda lo stesso irritato atteggiamento che molti napoletani nutrono nei confronti dei politici al governo della città. Un atteggiamento misto di disillusione e disprezzo, un caleidoscopio di speranze infrante, di profezie che si autoavverano e di io l’avevo detto. Quasi a sottolineare una costante sfiducia nel futuro, a cui però non corrisponde un vero amore per il passato. Insomma, reazionari sì, ma volendo anche no. Il problema è che da un po’ di tempo a questa parte parlare di speranze in città è diventato un esercizio pericoloso. D’altro canto, è noto come a Napoli spesso l’idea di speranza sia stata confusa con quella di maquillage, cioè di un rifacimento superficiale di abiti e colori che non intacca le vere ragioni di un’arretratezza cosmica.
Più o meno da quando è iniziata la fase acuta del suo declino politico, e per un certo periodo di tempo, Antonio Bassolino – prima sindaco di Napoli e poi presidente della Regione Campania – si è tinto i capelli. Che cosa strana. Un personaggio così in vista, nell’occhio del ciclone per l’opinione pubblica, la magistratura, i suoi avversari politici, i compagni di partito e via dicendo, un bel giorno manda a chiamare il parrucchiere e decide di ritoccare la sua immagine in modo così radicale. Senza considerare la derisione popolare che una scelta del genere gli attirerà, visto che i napoletani sono un popolo dallo sviluppato sentimento del ridicolo. Cosa che Bassolino sa bene. Per l’imprudenza della scelta quasi m’intenerisco.
Li conosco questi parrucchieri. Essendo un intero ramo della mia famiglia impiegato nel settore, posso dirlo con una certa cognizione di causa: è stata tutta colpa del coiffeur.
«Presidente, la facciamo come Simona Ventura. Vedrà, una cosa leggera» deve aver detto l’abile acconciatore, mentre il presidente chinava il capo davanti alle sue insistenze.
Che bella metafora della città. L’uomo che, nel bene e nel male, ha dominato gli ultimi sedici anni della vita politica campana, decide di cambiare look e darsi alla macchia nel momento in cui il sistema di potere che ha creato sta sprofondando. Anche se alla macchia non ci si dà del tutto, visto che continua a restare in posizione di comando. Il tentativo di rifarsi l’aspetto assomiglia un po’ a quello delle star americane che dopo le solite disavventure con droga, alcol e giustizia, risorgono dando alle stampe la loro autobiografia, incidendo un nuovo disco, realizzando un altro film. Il problema è che un politico non è, o almeno non dovrebbe essere, una star. Non dovrebbe essergli consentito cadere e risorgere. O almeno, tra la caduta e la resurrezione dovrebbero quantomeno esserci di mezzo le dimissioni. Napoli è lo stesso. Sepolta e poi misteriosamente sgomberata dai suoi rifiuti, ma ben lontana dal risorgere, continua a sprofondare nell’indifferenza dei suoi stessi abitanti, al massimo dandosi una ripulita di tanto in tanto, cercando di cambiare look, ma sempre risultando ridicola.
Come Bassolino, anche noi napoletani ci siamo fatti la tintura, abbiamo chinato la testa rassegnandoci al volere del nostro parrucchiere. Chissà che non abbia un po’ esagerato.
A vederle dal vivo (si fa per dire), mummie aragonesi e apparati cardiaci indebitamente sottratti faranno certamente impressione. Intanto noi napoletani, un po’ cultori dei morti, un po’ sanfedisti, vegliamo sui corpi della città facendo la faccia storta al cambiamento, anche se la modernità prima o poi si avvera. Senza violenza, strisciando tra le facce storte, adagiandosi intorno al dialetto, conducendoci docilmente dove vuole arrivare.
Oggi la città della pornografia quotidiana è diventata un laboratorio avanzato di capitalismo che a merci e servizi ha sostituito corpi umani. Quelli della Serata Caraibica, dei concerti in piazza del Plebiscito, i corpi di veline, attori e cantanti d’importazione ed esportazione, i corpi che strusciano lungo le strade di periferia e quelli che tirano coca nei locali più in vista.
Pop porno si intitola uno degli ultimi tormentoni musicali. Interpretata dal duo leccese Il Genio, la canzone mette furbescamente alla berlina i nostri tempi «un po’ porno», divertendosi a stigmatizzare i comportamenti del maschio italico che si sveglia «alle tre per guardare quei film un po’ porno», a cui «piace sognare quei tipi di donna un po’ porno» e che quando cala la notte e rientra a casa guarda negli occhi la sua amata facendola «sentire davvero una donna un po’ porno». Naturalmente, la scaltrezza insita nel reiterato utilizzo di un suadente erotismo non è sfuggita a un altro genio dei nostri tempi, Simona Ventura, che ha adottato il brano usandolo a man bassa nello show Quelli che il calcio e..., storico programma della domenica pomeriggio. Pop porno è un brano che non fa male: non aggressivo, non volgare, non corre il rischio di incappare in nessuna censu...