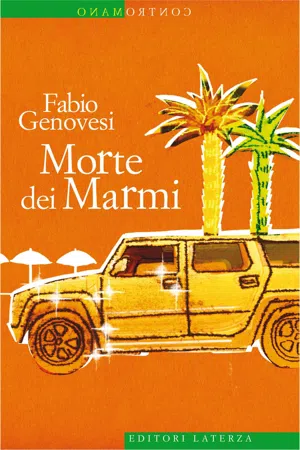E invece non si muore mica
Spettri e uno stinco di maiale
La nebbia che tutto mangia
Lago di Porta
Finalone carico e ridondante
Una sera, l’anno scorso, mi è successa questa cosa che mi ha commosso. O forse erano due anni fa.
Io e Stefano eravamo impegnati a mangiare uno stinco di maiale con le posate di plastica, che è come cercare di uccidere un alligatore con uno spazzolino da denti. Era ottobre ma sembrava già inverno, soprattutto lì a Seravezza che è il primo paese sulle Alpi Apuane, in una gola dove il sole passa solo per sbaglio e quando se ne accorge scappa subito via.
Stavamo in un locale lungo il fiume, proprio sull’argine, in quelle zone dove l’alluvione del ’96 ha portato via tutto, case e persone, ma dopo ci si è ricostruito in abbondanza, così non si rischia che la prossima passi senza farsi notare.
Per tanti anni il fiume è stato bianco. Sembrava fatto di latte, anche se era latte andato a male, un effetto speciale offerto dalle segherie che ci buttavano dentro la polvere del marmo. Per me il fiume era sempre stato così, però il mio babbo mi diceva Ma lo sai che una volta l’acqua era trasparente e il fiume era uno spettacolo e c’erano dentro certe trote che sembravano arcobaleni colle squame? Io mi immaginavo la scena e mi struggevo e gli chiedevo se sarebbe mai stato possibile rivederlo così, e il babbo mi rispondeva che lui di sicuro non l’avrebbe più rivisto, e forse nemmeno io, ma magari i miei figli... e allora, anche se avevo sette anni, io li invidiavo i miei figli, che erano destinati a godersi una favola del genere. Ma non c’è stato bisogno di aspettare così tanto, qualche anno fa è stato bloccato lo scarico selvaggio e adesso il fiume è di nuovo trasparente, e fa una musica speciale quando scende strusciando sui sassi. E dietro quei sassi ci sono delle trote da sogno, lì scintillanti per farsi vedere da me e pure dal mio babbo, e il fiume e i torrenti che gli danno acqua sono tornati a essere una meraviglia dentro questa enorme meraviglia che sono le Alpi Apuane, là a dieci minuti scarsi dalla costa, che c’è gente assurda che viene in vacanza al Forte da decenni e non c’è salita mai.
E insomma, io e Stefano quella sera stavamo là a Seravezza e continuavamo a lasciare pezzi rotti di plastica nello stinco di maiale. E intanto litigavamo sulla spinosa questione di quanti membri originali servono perché una band storica si possa ancora considerare in attività: c’è chi applica la regola della metà più uno, e cioè che se per esempio il gruppo era di cinque elementi, serve che sul palco ci siano almeno tre musicisti originali. Ma c’è anche una scuola anti-quantitativa che si basa sulla qualità dei singoli membri, e fa notare che i Thin Lizzy potrebbero essere pure al completo, ma senza Phil Lynott (pace all’immensa anima sua) niente ha più senso, così come la Jimi Hendrix Experience senza Jimi Hendrix.
Da più di un’ora ci scaldavamo in questi soliti litigi, quando di colpo mi ritrovo un bimbo sui quattro o cinque anni lì in piedi accanto a me, in mano un ghiacciolo alla menta, che mi fissa con gli occhioni seri e non dice nulla.
Mi blocco, lo guardo, gli chiedo cosa vuole.
Sorride appena, mi fa Ciao Capello, come stai?
Ora, l’ultima volta che mi hanno chiamato Capello stavo alle elementari. Era il mio soprannome, per via della chioma riccia che mi stava perennemente gonfia sulla testa in un involontario stile afro. Ma le elementari sono passate da un bel pezzo, com’è che questo bimbo conosce il mio soprannome? Forse è un nano che stava in classe mia e porta benissimo la sua età? Forse è un fantasma tornato a ossessionarmi dall’oltretomba?
Lo fisso, lo fissa Stefano, nessuno dice altro e io sto quasi per chiedere allo spettro-nano cosa ci aspetta dopo la morte. Ma poi mi accorgo di queste sei persone che arrivano dietro di lui, mi indicano e ridono e vengono a salutarmi. Io sorrido, saluto pure, guardo Stefano per capire se sono amici suoi, ma lui continua a mangiare lo stinco e basta.
“Fabio, ma insomma, non ci riconosci proprio?”.
Sorrido da ebete con le mani che mi grondano di maiale cotto, e in effetti no, non li riconosco. Mi sembrano assai più vecchi di me, e quindi vuol dire che hanno la mia età. Si indicano uno per uno e si presentano: Mirko, Dito, il Giannini, la Chicca...
Ma certo che li conosco, ci ho fatto le elementari insieme, o le medie, o ci ho servito la messa o ci siamo tirati i sassi per gioco quando non c’era altro da fare. Con queste persone ci sono cresciuto, vivevamo nelle stesse strade, eravamo i bimbi di Vittoria Apuana e passavamo insieme ogni giornata. Poi è arrivato il liceo, e i motorini, e la possibilità di girare un po’ più in là del bar Giari, e allora ci siamo persi di vista. Ma adesso capisco che in realtà mi sono perso solo io, perché loro sono qua tutti insieme, allo stesso tavolo, con tanto di mogli e mariti e fidanzati e due bimbi piccoli, di cui uno è il fantasma col ghiacciolo alla menta che mi è venuto a chiamare Capello.
Mi alzo e cerco di abbracciarli senza sporcarli di sugo di stinco, la Chicca mi blocca, tira fuori un fazzoletto di carta e me lo dà, poi un altro, poi un altro ancora, e alla fine ci abbracciamo.
“O ragazzi, ma dov’eravate finiti?”.
E loro mi guardano come un matto: “Veramente dov’eri finito te!”.
Perché loro vivono tutti qua. Due a Seravezza, uno a Azzano, poi Pomezzana, Ruosina, Ponte Stazzemese. Si sentono sempre, si vedono spesso, i bimbi vanno alla stessa scuola, quando ci sono le partite più importanti le guardano a casa di Dito che ha il megaschermo e ognuno porta qualcosa da mangiare.
“E te?”, mi chiedono, “te dove stai?”.
“Esatto”, ci si mette pure Stefano, che lui si lascia sempre trasportare dalle situazioni e già si sente uno di loro, “te dove cazzo sei finito?”.
“Io... io sto al Forte”, dico. E mi guardano straniti, come se gli avessi detto che faccio il guardiano del faro sull’isola del Tino. Le facce vorrebbero sorridere ma il sorriso proprio non viene, e allora sulle labbra gli resta una paresi tremolante che si sforza di essere spontanea.
“Ah, sì, beh, è chiaro”, dice Dito. “Te scrivi”. Che è una reazione abbastanza diffusa: se uno scrive, allora per forza deve fare delle robe strane. Va in giro in pigiama, o parla con gli alberi, o raccoglie la spazzatura e se la porta a casa. La mia stranezza però è che vivo nel mio paese, è così assurdo?
Mi sa di sì, da come mi fissano. Ma piano piano si abituano all’idea, e si siedono con noi quando Stefano gli dice Sedetevi qui, su ragazzi, è una vita che non ci si vede.
E siamo rimasti così un paio d’ore, a ricordare e raccontarci, e mi sono pure commosso quando il bimbo della Chicca dal nulla mi ha chiesto ma te sei Fabio, quello che era cascato in una vasca piena di concime e ci stavi per morire?
Io ho risposto di sì, anche un po’ fiero, e lui mi ha detto sei un grande, e io ho riso e mi sono voltato per fare finta di studiare le birre esposte sul bancone, ma in realtà avevo l’umido agli occhi.
E poi nulla. Poi siamo tornati ognuno a casa sua. Dopo esserci scambiati i telefoni, e promessi di rivederci presto, anzi prima di presto, praticamente subito. A casa mia, no a casa mia, no a casa mia... No, a casa mia! ha detto Stefano tutto convinto. E alla fine ha vinto lui. Ma tanto era una gara inutile, perché poi non è che ci siamo rivisti davvero, e nemmeno telefonati. La vita degli adulti è questa, si dicono cose che non si pensano, se ne promettono altre che non manterremo, e questo funziona perché è un gioco chiaro a chi parla e a chi ascolta, è un tacito accordo per potersi dire addio e fare finta che sia un arrivederci, ti volti di là e te ne vai e tutto è archiviato per sempre in busta chiusa nel magazzino del passato.
Ma quella sera no. Quella sera ho accompagnato Stefano a Pietrasanta e mi sono rimesso in strada verso casa, e nella testa mi rigiravano pensieri misti a ricordi misti a progetti, si incrociavano e si mescolavano e a un certo punto non sapevo più cos’era passato e cosa futuro. Ricordavo progetti, pianificavo ricordi, nella mia macchina non c’erano più un davanti e un dietro, un prima e un dopo, quella sera era tutto un brodo di tempo e spazio. E così alla fine mi sono pure perso.
Dovevo tornare a Vittoria Apuana, e invece ho preso lo stradone che da Querceta porta giù fino in centro. Ma non è tutta colpa mia. Il fatto è che si trattava di una di quelle notti che monta il nebbione, una specie di bruma pastosa che è tipica nostra, e certe sere sale su dal mare e si mischia con l’umido dei monti per coprire tutto. Gli ingredienti perché venga bene sono guazza, salmastro e un goccio di resina di pino, e si tratta di una miscela perfetta per devastare qualsiasi creazione dell’uomo, dal legno verniciato delle persiane alle cromature delle auto. Monta e si spande e struscia su ogni cosa e la avvolge in una stretta letale, un anaconda di umidità che arriva e ti stritola, lento, inesorabile, micidiale. Lo sanno bene i collezionisti, quelli che ammassano in casa fumetti, dischi, vecchie vhs o qualsiasi altra serie di oggetti tu decida di accumulare, tentando così di dare ordine e completezza alla tua esistenza. In Versilia puoi custodire i tuoi tesori in buste speciali o sotto vuoto spinto, ma prima o poi le macchie di umido salato gli saranno addosso senza pietà. Il filmino del matrimonio, quello delle vacanze a Sharm el-Sheikh dove fai il bagno coi pesci tropicali, ti conviene non affezionartici troppo perché non dureranno, nessun ricordo materiale sopravvive alla morsa dell’umido versiliese.
E quella sera ci guidavo in mezzo, potevo sentirlo che si appiccicava alla macchina e rosicchiava la carrozzeria e la gomma delle guarnizioni. E forse è proprio questo il trucco della famosa nostalgia fortemarmìna, il segreto di questo paese che vive del tuo passato: l’umido assassino sgranocchia ogni cosa, la gratta via e poi ne mantiene l’essenza, se la porta dentro per secoli, e quando di notte torna a spandersi sul paese te ne riporta l’odore.
Ecco, forse è proprio così, forse ho capito finalmente qualcosa di Forte dei Marmi. O forse è solo che questa è una di quelle notti che ti monta dentro un sentimento strano, e tutto ti sembra così chiaro e significativo, pensi di capire un sacco di cose e di essere più profondo che mai. Càpitano, queste sere, e non so mai se conviene sfruttarle fino in fondo oppure è meglio infilarti a letto e lasciarle scorrere con gli occhi chiusi fino al mattino dopo.
Nel dubbio guido lento, lentissimo, sullo stradone vuoto non incontro un’auto, una persona, una finestra accesa. Solo i tigli sul ciglio della strada, alternati ai lampioni, e sembrano guardie dritte in piedi, una grossa una smilza, una grossa una smilza, che sorvegliano la via d’accesso a un paese fantasma. Le case intorno sono sperse nella nebbia, ma intuisco i portoni sbarrati, le persiane chiuse, i cancelli coi mille bigliettini lasciati dalla vigilanza privata che fa il giro di notte. E, appena accennati nel grigio della foschia, questi villoni alla Beverly Hills, questi templi simil-dorici, questi spogliatoi per piscine a forma di otto, finalmente li riconosco per quello che sono: muri, solo una serie infinita di muri costruiti in lungo e in largo, che si incastrano tra loro a formare un sacco di edifici che non puoi chiamare case, perché non c’è mai nessuno che ci viva, che le scaldi di voci, di urla, di risate e di incazzature, di tv al massimo e bicchieri che si spaccano o letti che cigolano mentre ci fai l’amore.
E penso a Dito, alla Chicca, a tutti gli amici che adesso sono dei simpatici sconosciuti, nati e cresciuti qua, e poi siccome volevano costruirsi una famiglia se ne sono dovuti andare lassù sui monti. Perché nel loro paese andare in affitto è follia e comprare è impossibile. Perché nel loro paese pieno di costruzioni non c’è una casa per loro. Perché a Forte dei Marmi succede questa cosa qua, che più ville si tirano su e più il posto si svuota. Un paese desertificato dall’abbondanza, seccato dalla prosperità.
E stanotte il Forte è vuoto più che mai. Guido quasi a zero all’ora, e avvicinandomi al mare il nebbione diventa ancora più fitto. Ma ai bordi della strada riesco a intuire il grosso fondo che una volta era una sala giochi, dove ho perso la salute a forza di partite a un giochino che non mi ricordo il nome ma c’era un ninja che doveva liberare la fidanzata e intanto ammazzava un monte di persone. Poco più avanti, dall’altra parte della strada, c’è ancora la videoteca dove ogni pomeriggio io Marco e Alessandro noleggiavamo un porno e ce lo guardavamo invece di studiare. E ne potevamo vedere un milione, ma tanto il più bello restava sempre quello tedesco dove c’era un vecchio che aveva una libreria, e arrivavano delle donne che gli dicevano Cerco qualcosa che mi dia passione e mi emozioni, e allora lui invece di consigliargli un libro le accompagnava nel magazzino sul retro, dove c’erano degli uomini che forse erano i suoi figli, già nudi e pronti per dare a quelle donne tutta la passione che cercavano. Questo film io lo tengo sempre in mente perché mi ha dato una lezione importantissima, e cioè che i libri sono favolosi ma la realtà sta sempre un passo avanti: se ti metti contro di lei duri mezzo minuto, e l’unico modo per viverla bene è starci in mezzo, andando di qua e di là dove ti porta lei, cercando di stare a galla il più possibile. Ecco cosa mi ha insegnato, in qualche modo, un film porno tedesco con protagonista un vecchio che gestiva una libreria, e quando gli chiedevi la passione ti portava in magazzino.
Stanotte passo davanti alla videoteca e ci ripenso, e continuo a pensarci superando il distributore e la caserma dei carabinieri e la curva per il cimitero, che giustamente sta in via del Paradiso. Ma io non curvo, io tiro dritto, e comincia il centro più centro, dove i tigli cedono il passo alle palme. Nella...