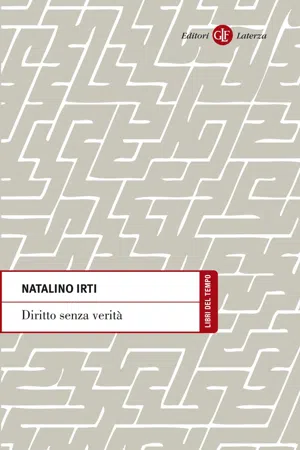
- 192 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Diritto senza verità
Informazioni su questo libro
Il declino di tutti i fondamenti, metafisici e terreni, consegna il diritto alla decisione individuale.
La scelta del singolo – che risponde all'interrogativo 'quale è il mio posto nel mondo del diritto?' – costituisce l'unica ed esclusiva verità.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Argomento
LawCategoria
Legal HistoryTramonto della sovranità e diffusione del potere
[Queste pagine svolgono temi proposti nel 55° Convegno di Studi amministrativi di Varenna (24-26 settembre 2009) dedicato a Nuovi poteri e dialettica degli interessi. Già in «Diritto e società», 2009, pp. 465-480.]
1. Un secolo ci divide dal discorso Lo Stato moderno e la sua crisi, con cui Santi Romano inaugurava l’anno accademico 1909-10 nella Regia Università di Pisa127. Pagine lontane, che, pur fedeli alla tradizione rigorosa del diritto pubblico, già percepiscono movimenti di interessi economici, formarsi di gruppi, tensioni interne, e ‘non lieti presagi’ per la sovranità statale. ‘Stupenda creazione del diritto’ è per il Romano lo Stato moderno, «un ente a sé che riduce ad unità gli svariati elementi di cui consta, ma non si confonde con nessuno di essi, di fronte ai quali si erge con una personalità propria, dotato di un potere, che non ripete se non dalla sua stessa natura e dalla sua forza, che è la forza del diritto». Accanto o di contro a questo ente, «si moltiplicano e fioriscono con vita rigogliosa di effettiva potenza, una serie di organizzazioni ed associazioni, che, alla loro volta, tendono ad unirsi e collegarsi fra loro. Sono federazioni o sindacati di operai, sindacati patronali, industriali, mercantili, di agrari, di funzionari, sono società cooperative, istituzioni di mutualità, camere del lavoro, leghe di resistenza o di previdenza, tutte costituite sul principio indicato, dal quale ricavano la loro effettiva fisionomia».
La sovranità dello Stato unitario non spiega questi fenomeni, che si svolgono all’esterno di esso, e si danno regole proprie, e denunciano la debolezza o insufficienza della rappresentanza politica. Santi Romano affida la capacità unificatrice ad uno Stato corporativo, che tragga dentro di sé interessi di categorie e gruppi sindacali, e così riaffermi o restauri la propria comprensiva ed esclusiva personalità128.
2. La diagnosi di Romano – del più grande fra i giuristi italiani del Novecento – ci sembra insieme lucida e remota, come il primo capitolo d’un libro di cui oggi scriviamo le ultime o penultime pagine.
La sovranità non appartiene più allo Stato come ente giuridico, come persona a sé stante, ma al popolo, che – proclama l’art. 1, 2° comma, della Carta repubblicana – «la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». C’è un singolare, e non avvertito, ritorno storico: la sovranità, scioltasi dal vincolo personale del monarca e dalla legittimazione dinastica, si era resa impersonale e astratta nel corpo normativo, agganciata, per così dire, all’unico ed esclusivo sostegno del diritto. Lo Stato come persona giuridica segnava il grado più alto di impersonalità. La nostra Costituzione, al pari di altre democratiche, attribuisce la sovranità al popolo: il popolo, deliberando la Costituzione, detta forme e limiti di esercizio della sovranità. Non la Costituzione istituisce il popolo; ma il popolo fonda la Costituzione, e così disciplina l’esercizio della sovranità. Sovranità popolare è sovranità giuridica, sovranità nel diritto e mediante il diritto posto dal popolo stesso.
È un profilo di straordinaria importanza. La sovranità si fa di nuovo concreta e personale: non appartiene più a un ente fittizio, a un soggetto logico, ma a un corpo reale e determinato. A questo popolo, che trae da sé, dalla propria volontà, il contenuto di ogni norma (norma costituzionale o ordinaria), e stabilisce competenze e poteri, e disegna la fisionomia dello Stato e di qualsiasi altro ente. Forme e limiti di esercizio, di che parla il secondo comma dell’art. 1, non sono stabiliti dal di fuori, ma dall’interno stesso della sovranità popolare, la quale, nel produrre leggi, anche dà legge a se stessa129.
3. Tramonto della sovranità – come suona il titolo di questa relazione – non è dunque problema concettuale, ma problema storiografico; non crisi di uno schema logico, che sia comune e identico in tutti gli Stati, ma crisi di questa volontà popolare a cui appartiene la sovranità. Il giurista non può non farsi storico; e non dubitare delle stesse categorie interpretative di ‘tramonto’ o ‘crisi’, le quali implicherebbero una legge necessaria o un destino inviolabile. E qui, invece, si tratta di un processo storico, di volontà che scelgono, di uomini che decidono forme e modi della loro vita. È rovesciata la prospettiva di Santi Romano: non confronto tra concetto di sovranità e realtà del tempo, ma radicale storicizzazione della sovranità.
Cominciamo con l’osservare che la sovranità del popolo si esercita nelle forme rappresentative, e, dunque, che Parlamento e partiti ne sono l’indispensabile struttura. Il principio democratico, o principio di autodeterminazione politica, vuole che il governato scelga il governante, e perciò, obbedendo alla legge, obbedisca soltanto a se stesso. Il processo storico della sovranità popolare finisce per identificarsi con il processo storico delle strutture parlamentari, cioè degli istituti elettivo-rappresentativi. La sovranità popolare si esprime nelle norme, costituzionali o ordinarie, deliberate dal Parlamento.
4. È questo il quadro in cui si collocano due fenomeni, che si suole additare come segni di tramonto o crisi della sovranità: il diritto europeo e il federalismo (parola qui assunta nell’accezione consueta alla politica italiana).
Il diritto europeo è ricondotto all’art. 11 della Costituzione, dove si prevede che l’Italia consenta «alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni». Taccio qui il dubbio se l’economia di mercato – che è l’economia della lotta più impietosa e crudele – giovi a garantire la pace e la giustizia fra le nazioni; e mi restringo a notare che la sovranità del popolo ha deciso di auto-limitarsi, di istituire unioni di Stati, e di affidare ad organi comuni talune frazioni di potestà legislativa. Questa decisione è stata tratta a conseguenze, che possono dirsi lesive della sovranità popolare: il diritto europeo, scioltosi dalle volontà fondatrici, si è attribuito forza propria e carattere originario. Un esempio – direbbe Gunther Teubner – di autopoiesi giuridica, che vede la creatura farsi creatore, e negare o dimenticare il rapporto di derivazione da altrui volontà. Si è giunti a tanto che ai regolamenti comunitarî si assegna l’efficacia di travolgere o, con delicato eufemismo, di determinare la disapplicazione delle stesse norme costituzionali fino all’estremo confine dei principî fondamentali e dei diritti inviolabili della persona umana. Che è una sintesi di mitologia europea e di arcaico giusnaturalismo130.
5. A codesto indebolimento di sovranità verso l’alto fa riscontro il fenomeno del ‘federalismo’, cioè di larga attribuzione di poteri agli enti regionali. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – che è, anch’essa, espressione di volontà popolare – ha colpito la vecchia fisionomia dello Stato in modo grave e violento. Il 2001 rompe la storia costituzionale del dopoguerra, e determina un’altra figura di Stato. Il nuovo art. 114 colloca lo Stato, parte fra le parti, all’interno della Repubblica: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato». «Spetta alle Regioni – soggiunge l’art. 117, 4° comma – la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato». L’espressa riserva alla legislazione statale riduce l’àmbito della potestà legislativa regionale, che dunque non è eccezione alla regola, ma regola all’eccezione. Non più lo Stato attribuisce poteri alla Regione, ma Regione e Stato ricevono, l’una accanto all’altro, poteri dalla Costituzione. Ancora un caso di autopoiesi giuridica.
In questo federalismo o regionalismo confluiscono due fattori: l’uno, proprio della storia d’Italia; l’altro, carattere generale del nostro tempo. Lo Stato nazionale unitario ha serbato dentro di sé, a lungo taciuto e irrisolto, il problema delle piccole patrie, quel problema che Carlo Cattaneo indicava nel saggio del 1858 La città considerata come principio ideale delle istorie italiane. La ‘molteplicità di storie cittadine’131, la robusta autonomia dei municipî, la varietà di tradizioni e costumi durati nei secoli, gli interessi di ceti e gruppi locali: tutto questo terreno, così ricco e insieme così frantumato e diviso, fu dal nuovo Stato ridotto ad uniformità amministrativa e legislativa. Anche uomini severi della Destra storica come Marco Minghetti, e poi, sul finire del secolo decimonono, figure eminenti come il Di Rudinì, avvertirono che la conquista sabauda portava in sé un’ombra di discordia e un germe di crisi132. Grande risultato storico, lo Stato unitario e nazionale, che elevava l’Italia al rango delle altre potenze europee, ma che recava un interno malessere, un ritornante, e mai estinto, impulso di autonomia territoriale. Il nostro paese è ancora segnato dai problemi e dalle interpretazioni del Risorgimento.
Questo fattore, proprio della nostra storia, si è risvegliato o rinvigorito dinanzi al carattere planetario della tecno-economia. Mentre tecnica ed economia non conoscono frontiere di Stati, e si espandono impetuose nel mondo intero, prive di storia e di luoghi, anonime e impersonali, ecco che l’individuo, il fragile e povero individuo, ha bisogno di antichi rifugî, di spazî familiari e determinati. Lo smarrimento nel mondo della tecno-economia è compensato dalle piccole patrie, dalle mura conchiuse che ci videro nascere ed in cui vogliamo morire. Si spiega così che proprio le regioni più avanzate nel progresso tecnico ed economico (dal Piemonte alla Lombardia, al Veneto) siano più gelose delle loro tradizioni di autonomia e più impazienti di riconquistarle ed esercitarle133. La modernità, per una dialettica non ignota ad altri periodi storici, suscita o ridesta la strenua fedeltà alla terra, il vincolo ai luoghi nativi, che così placano la paura e lo smarrimento provocati dalla gabbia tecnologica.
Il confluire di questi fattori ha risvegliato il regionalismo, che è diventato il più grave e acuto problema dell’odierna fase storica.
6. Questi fenomeni di indebolimento, che abbiamo non tanto ricostruiti quanto appena accennati, non toccherebbero in alcun modo la sovranità e il principio di autodeterminazione se il popolo, cioè i cittadini titolari del diritto di voto, prendessero assidua parte alla vita politica e dunque fossero loro a decidere le scelte dell’europeismo e del regionalismo. Le quali apparirebbero anzi, non come infiacchimento e perdita di sovranità, ma piuttosto mutevole e sciolta espansione di essa.
Il tramonto della sovranità – se proprio di tramonto, o di altra declinante ora, voglia parlarsi – non è segnato dalla dispersione di potestà legislativa, ma piuttosto dal difetto di autonomia politica, cioè dalla scarsa o nulla partecipazione alla vita politica. La democrazia indiretta si affida all’esercizio del voto; e l’esercizio del voto, alle leggi elettorali e alla mediazione dei partiti politici. Se la legge elettorale riduce o vanifica il potere di scelta del cittadino, e se i partiti politici si lasciano dominare dalla ‘legge ferrea delle oligarchie’ (come piacque di denominarla al suo scopritore, il sociologo tedesco Robert Michels134), se tutto questo avviene, e i cittadini, resi impotenti ed inutili, si allontanano dalla cosa pubblica, allora sì la sovranità si tinge dei colori del tramonto, colori sempre più cupi e tragici.
Qui, ancora una volta, si discopre che il problema della sovranità è essenzialmente problema storico, e perciò da impostare nella singolarità e determinatezza di ciascuna situazione. Sicché ora, volgendo lo sguardo all’Italia, non possiamo non avvertire l’infiacchimento dello spirito civico e l’estraneità, sempre più pro...
Indice dei contenuti
- Prefazione
- Prima parte
- Diritto senza verità
- Ciascuno sceglie il proprio diritto
- La scelta del fondamento (tra Kelsen e Weber)
- Onnicentrismo giuridico
- Vita giuridica e problema dell’inizio
- Il mondo e lo sguardo giuridificante
- Il terzo decide la causa
- Diritto della contemporaneità
- Seconda parte
- La filosofia di una generazione
- Tramonto della sovranità e diffusione del potere
- Crisi mondiale e diritto europeo
- Stato moderno e Stato contemporaneo (rileggendo un libro di Arturo Carlo Jemolo)
- Storicismo e nichilismo giuridico in un’orazione di Ugo Foscolo
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Diritto senza verità di Natalino Irti in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Law e Legal History. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.