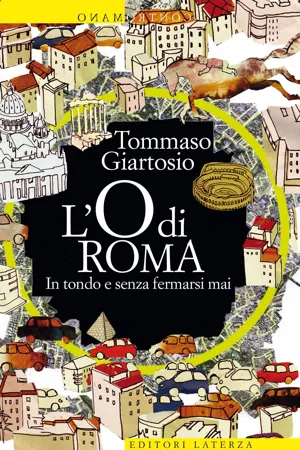Il Paradiso
41°52’46.71”N 12°29’59.44”E, 34m slm, 317° dell’O
Ci sono due Monti d’Oro a Roma. Il più famoso è il Gianicolo, un tempo Mons Aureus, che ancora ospita la chiesa di San Pietro in Montorio. L’altro è qui, tra Porta Metronia e Porta Latina, dove le mura aureliane si insaccano a sud-est formando un polmone verdissimo i cui sfoghi sono la via Latina, l’Appia, la Colombo.
A Roma si possono trovare una Borgata Giardino (Garbatella), una Città Giardino (Montesacro) e una borgata Giardinetti (Torrenova), ma il vero regno del verde è qui, a Monte d’Oro. E questo puzzle di parchi pubblici e privati punteggiati di rare costruzioni io devo tranciarlo da una parte all’altra, fino a valicare le mura per l’ultima volta (l’undicesima!).
Un vero paradiso, e questo non facilita le cose. Il paradiso è il paradeisos, in greco il “giardino”: per questo è sempre artificiale. Prima ancora, in iranico, è il giardino in quanto pairi-daeza, “circondato da un muro”: per questo è sempre proibito. Monte d’Oro, comunque, ne è il primo contrafforte: una collina di venti metri d’altezza che poggia contro l’interno di questa parte della cerchia, a nord, e digrada verso via di Porta Latina.
Perciò le stesse mura che viste da fuori si innalzavano imponenti, all’interno spiccano appena dal terrapieno. O dovrebbero. In realtà lungo il bastione è stato scavato un profondo fossato.
E così si è messo nuovamente a nudo il cammino di ronda. Si può percorrerlo, in teoria. Tutta la cinta muraria potrebbe un giorno diventare percorribile. Non saprei pensare un’immagine più felice; e non sto parlando di archeologia ma di cittadini che si riappropriano del confine sanguinoso della loro città (le Aureliane, ma anche le Leonine) e ne fanno un luogo di sospensione, di pensiero lineare. Marisa Cinciari, di cui dirò tra poco, racconta nella sua bellissima autobiografia Del mutare dei tempi le passeggiate da innamorata con Franco Rodano nel ’38 lungo questo tratto di mura:
La campagna romana le lambiva e non esisteva ancora la cosiddetta strada “del pomerio”, sempre piena di traffico, né i fornici aperti nelle mura per far passare la via Cristoforo Colombo; all’interno si stendeva un’area di pascoli e orti, dove fiorivano grandi mandorli che io tentavo di dipingere con lo sfondo degli inquieti cieli primaverili. Esplorammo le mura, diroccate, piene di anfratti, camminamenti e scalette. Sdraiati al sole sul tappeto erboso in cima ai torrioni facevamo infinite discussioni su tutto: morale, religione, filosofia, arte, politica. Si intende che, dicendo politica, alludo a appassionati dibattiti su Bruto e Cesare, su Federico II o sul Duca Valentino, su Robespierre e Danton, su Cromwell e sui padri pellegrini, sulla Comune e sulla guerra di secessione; oppure sui primi principi e sui massimi sistemi: la libertà, l’eguaglianza, la giustizia, la proprietà, la famiglia. E, ovviamente, di letteratura e di poesia. Fu in quel luogo che Franco mi lesse alcune sue composizioni letterarie...
Io però il fossato lo conosco solo dalle fotografie. Si trova nei terreni di Villa Grandi: l’ennesima residenza consolare, stavolta del Canada. La cortesia dei funzionari si è spinta fino ai limiti del credibile (– Guardi, l’ambasciatore vorrebbe davvero! È proprio che non può! –), ma il rifiuto è stato fermo.
Un ristorante
Da via di Porta Latina cerco almeno di risalire verso le mura tenendomi più vicino possibile alla mia O. Entro nel ristorante “Orazio a Caracalla”. Lo si direbbe un vero e proprio country club del generone, con sale interne e terrazze e parcheggi e alle spalle un grande prato all’inglese che risale tutto il pendio di Monte d’Oro, interrotto da brevi gradinate ornamentali e punteggiato di alberelli snodati e vispi per gli innumerevoli bicchieri di Frascati Superiore rovesciati sulle loro radici all’annuncio del pranzo di nozze servito.
In cima arrivo a qualche decina di metri dalle mura. Ma a sbarrarmi la strada c’è la recinzione di una villa, e non saprei dove trovare l’ingresso. Lo spazio smeraldino che sulle mappe porta il nome di “Parco Egerio” nella realtà è smangiato dalle proprietà private. Non sono tutte dimore sontuose: tra il ristorante e Villa Grandi trova posto (ma anche qui, purtroppo, nessuno risponde al campanello) una fettuccia di terreno con casetta, pollaio, pergola di vite, panni stesi, sedie di plastica triturate dal sole. Questo sì sembra un luogo oraziano.
Il prato no. Lo attraverso tornando sui miei passi. Svetta in posizione maestosa. Sembra quasi di piombare addosso alle Terme di Caracalla.
Ma c’è qualcosa di sinistro: nel bel mezzo, le rovine di un casolare cinte da un reticolato sanatoriale; grida di corvi in planata; cenere nell’aria. L’uomo atticciato che mi ha fatto entrare (Orazio?) mi spiega che prima qui c’era “un ritrovo di barboni e drogati”. – Noi l’abbiamo... l’abbiamo... – cerca la parola giusta, la trova: – bonificato. – Perché la gente ritiene di potermi dire con aria complice le cose più odiose? Ho forse il modo di fare, la cadenza, i vestiti, i sorrisi, del reazionario?
Mi viene il dubbio che sia proprio così. Non è forse per questo che mi affascina Villa Grandi?
I terreni della zona erano probabilmente proprietà di Riccardo Gualino, il grande imprenditore osteggiato dal fascismo. Venduti dopo il suo tracollo finanziario nel ’27, vengono acquisiti da pezzi grossi del regime: Alessandro Chiavolini, segretario particolare del Duce, Bernardo Attolico, ambasciatore a Berlino, Dino Grandi, ministro degli Esteri. Nel decennio successivo, mentre Gualino viene confinato a Lipari (più tardi lascerà l’Italia), i gerarchi affidano la realizzazione delle loro ville ai soliti Busiri Vici. Stavolta Clemente e suo fratello Michele – che pochi anni prima disegnavano le ville di Gualino a Torino e Sestri Levante.
Un ribaltamento a suo modo esemplare. La cacciata dall’Eden. Poi, di nuovo tutto cambia. Nel ’42 muore Attolico. Nel ’43, dopo aver causato la caduta di Mussolini Grandi fugge in Spagna: tornerà in Italia solo negli anni sessanta. Nel ’44 Chiavolini, meno abile, fonda il “Gruppo Onore”, una quinta colonna repubblichina a Roma. L’anno dopo viene condannato a quattordici anni di carcere.
Nel primo brogliaccio della Pelle di Curzio Malaparte, il romanzo doveva iniziare qui, “con un pranzo in casa Attolico, la sera della liberazione di Roma... La sera rotta di spari remoti e sparsi... Soggetto della conversazione? Forse Mussolini?”.
A via di Porta Latina mi aspetto di trovare una traccia di questo avvicendamento. Un sentore filosofico o qualunquista della cadenza ciclica del potere, una friabilità autunnale. O i segni del permanere dell’arte. Mentre le dimore d’epoca fascista trovavano nuovi padroni, i Busiri Vici passavano a disegnare le ville (bellissime) del Circeo e della Costa Smeralda.
L’aria è ancora piena di fumo e cenere. A Porta Latina questo odore mi fa tremare. Pochi lo sanno, io non lo scordo mai: qui vicino nel 1578 vennero bruciati sul rogo i cadaveri di otto uomini torturati e impiccati. La loro colpa la racconta Montaigne, che ne sentì ancora parlare a Roma tre anni dopo: “Si sposavano maschi con maschi alla messa, con le medesime cerimonie che noi usiamo per il matrimonio: facevano comunione insieme, leggevano il vangelo stesso delle nozze, e poi dormivano e abitavano insieme”. Qualche studioso si è poi adoperato per cancellare il ricordo di quell’episodio, e così il fumo della persecuzione è stato disperso da secoli. Quello che invece ho nelle narici ha un’origine più innocente: siamo in paradiso, no? – Viene dalla villa qui sotto – spiega il ristoratore. – Ci sta un onorevole. –
– Di che partito? –
– Io non faccio politica. –
Non c’è nulla di più politico della posizione che si esprime in questa risposta.
Una casa d’artista
Così riprendo l’O e con lei attraverso la via, fin sotto al muro di cinta. Lei scavalca con noncuranza. Io devo risalire sottocosta questo rettilineo lungo e angusto tra due muretti quasi privi di varchi sopra i quali gli alberi delle ville intrecciano una galleria di verzura. Le auto sono pochissime, velocissime.
So che quasi in parallelo, pochi metri alla mia destra, scorre una via identica a questa. Anch’essa vola verso una Porta e da essa prende il nome. Via di Porta Latina, via di Porta San Sebastiano. A volte nel silenzio dell’una sento un bolide sfrecciare nell’altra. La villa in cui cerco di entrare riempie per sei-settemila metri quadri, come un’isola o uno spartiacque o come una villa in un racconto di Borges, lo stretto cuneo tra le due vie.
Finalmente una porticina. Il citofono dice solo: Int. 7. Ma dev’essere questa, la casa di Sartorio.
Era famoso, Giulio Aristide Sartorio, tra fine Ottocento e primo Novecento. Paesaggi marini, quadretti veristi, ritratti. Ma soprattutto grandi tele simboliste, miti classici, e nudi splendidamente disegnati, stirati in pose inattese. Sartorio: così si chiama anche un muscolo, il più lungo e flessuoso del corpo umano.
Quella che sto aggirando era un tempo la sua villa-studio. Quando ero ragazzo, Sartorio era considerato imbarazzante. Più tardi è stato rivalutato, come Annigoni (che gli somiglia), chiamando in causa la maestria tecnica che si accompagna al suo accademismo. Ma non è solo questione di tecnica. La “Sirena” ora alla Galleria d’Arte Moderna di Torino, donna-gorgo che attira un pescatore affusolato e bronzeo, è un potente emblema erotico – e razzista. Certe immagini, penso mentre trovo finalmente una porticina, hanno una loro forza, appartengono alla storia che ci ha fatti, nel bene e nel male. Sono noi. Eppure noi cambiamo.
Esito a suonare. Poi mi decido. Tanto non mi faranno entrare – in casa di un onorevole, figurarsi.
Mi apre una donna anziana, cortese, un po’ incerta. Chiede un documento, esita, è ben contenta di lasciare la decisione a un nuovo arrivato. L’onorevole. Che spunta in giacca da casa, corta barba bianca e folte sopracciglia nere attorno a una faccia da orsetto, molto seria. Ha un libro in mano, tiene il segno col dito. Un onorevole che legge.
Cauto, ma non maldisposto.
Mi pare di riconoscerlo. Ma non dev’essere uno che va molto sui giornali.
Solo al momento di separarci gli chiederò al volo con arte di piazzista: – Lei è il signor...? – E lui che finora è stato così gentile ribatterà per la prima volta con tono secco (sperava di venire riconosciuto? o forse di non venire riconosciuto): – Falomi. –
Falomi, Falomi. Un dirigente storico della sinistra, se non sbaglio. La memoria latita perché qui mi sarei aspettato un missino doc. Sartorio era un volontario della Grande Guerra, amico intimo di D’Annunzio, convinto fascista e accademico d’Italia. Quando morì tra questi cipressi nel ’32, attorno fervevano i lavori dei Busiri Vici al servizio del regime. E ben presto la villa andò in mano a un altro fascista di rango: Francesco Cinciari, imprenditore e podestà di Civitavecchia.
Poi tutto cambia. La discendenza genetica è una carta matta, un’O feconda di accostamenti inattesi. Gli amici dei fascisti sono perlopiù altri fascisti ma la figlia di uno di loro può entrare nella Resistenza. Marisa Cinciari non si ferma qui: contribuisce a fondare l’Unione Donne Italiane, è senatrice, deputata, europarlamentare. Ebrea per parte di madre, sposa Franco Rodano e diventa con lui una voce essenziale del cattolicesimo comunista. Sarà lei che mi ha aperto? La figlia Giulia Rodano, assessore regionale, è moglie di Falomi: che intanto mi sta raccontando di aver dovuto far tagliare due pini che minacciavano la pubblica via. Indica il punto esatto usando il libro come freccia. Avvito il collo, ma non mi...