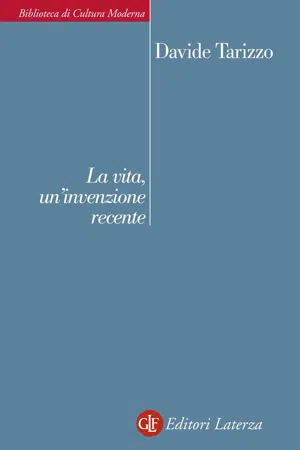
- 240 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
La vita, un'invenzione recente
Informazioni su questo libro
Il nostro è il tempo della vita. Dalle bioscienze alla biopolitica, il problema che la nostra civiltà si ritrova ad affrontare giorno dopo giorno, con una sensazione di crescente spaesamento, è quello della gestione e prima ancora della definizione della vita stessa: l'ultimo dio della modernità. Tarizzo affronta un tema quanto mai attuale facendone vedere la terza dimensione, la profondità storica e teorica. Remo Bodei
In un orizzonte culturale spesso indeterminato nei suoi presupposti, Tarizzo individua con rara efficacia il punto enigmatico in cui metafisica, scienza e politica ingaggiano una battaglia dagli esiti tuttora incerti. Roberto Esposito
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a La vita, un'invenzione recente di Davide Tarizzo in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Filosofia e Saggi di filosofia. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
FilosofiaCategoria
Saggi di filosofiaII. Vita: genesi di un paradigma metafisico
1. L’a priori metafisico della modernità è: la libertà è l’autonomia del volere umano.
1.1. Da questo a priori discendono tre possibili declinazioni dell’autonomia: il diritto, il lavoro, la vita.
1.2. Il diritto è espressione negativa, il lavoro e la vita sono espressioni positive della forza dell’autonomia. La libertà moderna può dirsi dunque in tre modi diversi: come libertà negativa, il suo nome è diritto; come libertà positiva, il suo nome è lavoro oppure vita.
1.2.1. Nella modernità, la Storia appare come la manifestazione positiva della forza dell’autonomia. Il lavoro e la vita dispiegano dinamicamente la spinta propulsiva dell’autonomia secondo due vettori alternativi, che tracciano il corso della Storia sociale e il corso della Storia naturale.
1.2.2. Il diritto moderno, quale manifestazione negativa della forza dell’autonomia, viceversa non ha Storia. Né naturale (innato) né sociale (acquisito), il diritto dei moderni si lascia afferrare più propriamente, alla radice, come uno spoglio diritto «fondamentale», arcano e inderogabile.
2. Lo schema metafisico della vita moderna ne fa l’espressione veridica della volontà moderna. La Storia naturale è il luogo di questa anamorfosi, che avvera la volontà autonoma nella vita autonoma. Le proprietà essenziali della vita, nel mondo moderno, sono tre. La vita è individuazione di Sé: ciò significa che la vita individua se stessa in forme in cui si individua la forza, altrimenti amorfa, del Sé. La vita è lotta per la vita: ciò significa che la vita si estrinseca nelle forme-di-vita, ma non c’è forma-di-vita che possa contenerne la forza selvaggia, non c’è profilo vivente che possa trattenere e addomesticare l’intensità della vita. La vita è volontà di salute: ciò significa che il vivente tende di per sé a guarire, a sanare il divario, incolmabile, tra la sua generica forza vitale e la sua specifica forma vitale. La vita, come forza latente che eccede ogni forma, arretra allo stato di mera potenza che eccede ogni atto. La vita sopravvive a se stessa.
2.1. La vita moderna è il Factum della volontà moderna. Cercheremo di illustrare il senso di questa definizione basandoci su alcuni testi del nostro canone e costruendo, a partire da essi, un’argomentazione filosofica. Le analisi testuali non saranno esaustive, pertanto, ma volte a gettar luce, elettivamente, su quei gesti speculativi da cui traspare la figura di un mondo, il nostro, promesso all’invisibilità.
2.1.1. Se l’interrogativo metafisico da cui prende le mosse la Critica della ragion pratica di Kant è «cos’è la volontà?», l’interrogativo da cui prende le mosse la Critica del giudizio è «cos’è uno scopo?». Due interrogativi tra i quali c’è continuità. Mettiamo infatti di chiederci cosa sia uno scopo. La risposta che, non solo Kant ma chiunque dovrà dare, è che lo scopo è un oggetto della volontà, è una risposta alla domanda: cosa vuoi? Interrogandoci sulla natura dello scopo noi continuiamo, quindi, a interrogarci sulla natura della volontà, poiché vi può essere scopo solo là dove vi sia già volontà, o desiderio, proposito, bisogno – termini che in prima battuta possiamo rubricare tutti come varianti del concetto metafisico di volontà.
2.1.1.1. Soffermiamoci sulla variante più equivoca, il bisogno. Poniamo di chiederci se la condotta di un’entità non-umana possa essere finalizzata a uno scopo, se la condotta di un animale, per esempio, si possa interpretare in termini di finalità. Potremmo descrivere il comportamento di quell’animale come uno schema d’azione che risponde a un bisogno organico e potremmo scorgere nella soddisfazione del bisogno uno scopo del suo comportamento, mosso, deciso, orientato dalla volontà (o dal desiderio, dal proposito) di soddisfarlo. Questa, però, sarebbe già un’interpretazione umana, troppo umana, del comportamento animale, sarebbe un’interpretazione che intravede dietro il comportamento dell’animale un’invisibile intelaiatura metafisica, l’intelaiatura della volontà, che non è escluso, ma neppure assodato, gli appartenga davvero. Potremmo dunque interpretare il suo comportamento in maniera diversa. Potremmo interpretarlo magari in maniera meccanica (Fichte, 1798, pp. 27, 32-35). Sembra così che siamo costretti a oscillare, nell’interpretazione della condotta degli animali e più in generale dei viventi non umani, tra l’antropomorfismo e il meccanicismo.
2.1.2. Chiediamoci daccapo: cos’è uno scopo? È un oggetto della volontà, si è risposto. Da ciò consegue che esso possiede specifiche proprietà ontologiche. In primo luogo, lo scopo non è una realtà, bensì una mera possibilità (prima proprietà). A differenza dell’oggetto di conoscenza, lo scopo non deve esistere da qualche parte, non è qualcosa di cui noi affermiamo o presumiamo la realtà, ma è qualcosa di cui noi enunciamo la possibilità non ancora realizzata. In secondo luogo, la possibilità indicizzata dallo scopo è una possibilità che entra in lizza con altre e viene selezionata dalla volontà. In tal senso, è la volontà a generare simultaneamente lo scopo e la possibilità. Dentro l’orizzonte complessivo delle possibilità, la volontà ne sceglie una ed è questa sua scelta a disegnare lo sfondo di possibilità alternative, che vengono scartate. Dunque, lo scopo è una possibilità tra le tante ed è la volontà a tracciare come un compasso il cerchio delle possibilità, al cui centro sta il suo scopo, la sua scelta, la singola volizione (seconda proprietà). In terzo luogo, la possibilità dello scopo è un principio di subordinazione di possibilità ulteriori. Scelgo di mangiarmi una mela, anziché una pera, e in funzione di questa possibili tà, prescelta dalla volontà come suo scopo, si profilano ulteriori possibilità – come scendere per strada, andare dal fruttivendolo, comprare il frutto – che possono condurmi alla realizzazione di quel certo scopo. Abbiamo così da un lato la possibilità ultima e finale, quella di mangiare una mela, dall’altro una serie più o meno lunga di possibilità subordinate, che rappresentano altrettante tappe intermedie verso la realizzazione dello scopo che mi sono prefissato. L’intero campo delle possibilità è disegnato dalla volontà, ma non tutte le possibilità si dispongono sullo stesso piano. Il campo delle possibilità si spartisce in mezzi e fini, a partire dalla scelta capitale dello scopo (terza proprietà).
2.1.3. Ricapitolando, non tutte le possibilità sono scopi, ma ogni scopo è una possibilità. Il territorio della finalità si ritaglia dal territorio della possibilità, e l’orizzonte di entrambi i territori è tracciato, a monte, dalla volontà. Ciò significa che la volontà è anteriore a ogni possibilità, e di riflesso a ogni scelta, per cui non la possiamo identificare con nessuna possibilità, e di riflesso con nessuna scelta. Ogni tentativo di assimilare la volontà a una singola volizione, che persegue un singolo scopo, è votato al fallimento. In termini kantiani, la volontà pura, autonoma, non è riducibile alla volontà spuria, etero noma. La seconda presuppone la prima, la volontà è presupposta dalla volizione. È questa, in definitiva, la cruciale proprietà metafisica del concetto di volontà ed è questa l’autentica scoperta di Kant: la «volontà pura», la volontà autonoma irriducibile alla volontà eteronoma, la volontà che non si può risolvere nel proprio scopo, la volontà che precede e fonda la possibilità stessa di uno scopo. In questa prospettiva, è lecito proclamare che la volontà è la «forma» dello scopo, o la «forma» della finalità priva ancora di contenuto, come fa Kant. Ma è lecito pure chiedersi come si possa manifestare questa volontà pura. Quale potrà essere l’espressione sensibile, fenomenica di una volontà ancora vuota, di una volontà che è la «forma» della finalità, priva della materialità di uno scopo? Dove trovare tracce, nel mondo, della volontà autonoma, che è una pura volontà di volontà, una pura volontà di sé, a monte di ogni possibilità e di ogni scopo? La risposta di Kant è offerta nella terza Critica. La manifestazione della volontà qua volontà nella sfera sensibile e fenomenica è il problema di fondo dell’intera opera. E l’ipotesi kantiana, com’è noto, è bipartita. Da una parte, l’espressione della volontà pura, intesa come «forma» della finalità priva ancora di contenuto, è il «bello», inteso come «finalità senza scopo», o «finalità secondo la forma», o mera «forma finale» dell’opera d’arte (o dell’oggetto naturale giudicato «bello»). «Un oggetto, o uno stato d’animo, o anche un’azione, è detto finalistico anche se la sua possibilità non presuppone necessariamente la rappresentazione di uno scopo, e per il semplice fatto che la sua possibilità non può essere spiegata e concepita da noi, se non ammettendo come principio di essa una causalità secondo fini, cioè una volontà che l’abbia così ordinata secondo la rappresentazione di una certa regola. La finalità dunque può essere senza scopo, quando non possiamo porre in una volontà la causa di quella forma, e tuttavia non possiamo concepire la spiegazione della sua possibilità se non derivandola da una volontà» (Kant, 1790, pp. 63-64). È questo il versante di quella che Kant chiama la «finalità soggettiva» dell’oggetto, di cui si occupa la Critica del giudizio estetico. Dall’altra parte troviamo invece quella che Kant definisce la «finalità oggettiva» della natura, di cui si occupa la Critica del giudizio teleologico. È qui che ci imbattiamo nel problema della vita. La finalità oggettiva può essere esterna o interna, afferma Kant, e ciò consente di parlare, a ruota, di una «utilità» esterna o di una «perfezione» interna della cosa che di volta in volta giudichiamo. Esterna è la finalità di un oggetto visto come scopo di qualcos’altro, e si tratta in questo caso di un rapporto di «utilità» di una cosa per qualcosa di diverso. Interna è la finalità di un oggetto visto come scopo di se stesso, e si tratta in questo caso di un rapporto di «perfezione» tra le parti e il tutto di una sola e medesima cosa. Ora, questo secondo tipo di finalità oggettiva, la finalità interna, è tipico, scrive Kant, degli organismi viventi o di quelli che all’epoca si è soliti denominare «esseri organizzati». «La perfezione interna della natura [...] la posseggono quelle cose che sono possibili soltanto come fini della natura, e si chiamano perciò esseri organizzati» (ivi, p. 244). Un «essere organizzato» è dunque un «fine della natura». Ma cosa vuol dire «organizzato»? Come Kant precisa, «è un prodotto organizzato della natura quello in cui tutto è, reciprocamente, scopo e mezzo» (ivi, p. 245). In altre parole, un organismo è uno scopo, un «fine della natura», poiché in esso ogni parte esiste come mezzo e scopo per ogni altra parte. Si può parlare di organismo «quando le parti si leghino a formare l’unità del tutto in modo da essere reciprocamente causa ed effetto della loro forma» (ivi, p. 241). Causa che andrà intesa, a questo punto, non soltanto come causa efficiente, ma anche e soprattutto come causa finale. Le varie parti dell’organismo intrattengono infatti tra loro un rapporto di finalità, il cui rovescio è un rapporto di reciproca strumentalità. Una parte serve a ogni altra e tutte servono all’organizzazione dell’organismo, sono finalizzate alla produzione di un essere organizzato. Un organismo è così un tutto la cui unità, la cui integrazione, la cui organizzazione è la causa finale di sé. Ciò detto, puntualizza ancora Kant, non si dà conoscenza di cause finali in natura, poiché la nostra conoscenza è circoscritta alle cause efficienti, per cui noi non conosciamo effettivamente quel «fine della natura» che è la totalità organica; ci limitiamo a giudicare che di fronte a noi abbiamo un «fine della natura», senza poter dare un contenuto epistemico al nostro giudizio, senza riuscire a determinarlo ulteriormente. Ciò che giudichiamo è che esiste un «fine della natura», esiste un organismo, senza però conoscerlo, senza riuscire ad afferrarne e a concepirne lo scopo. La finalità oggettiva interna del vivente non vuol dire altro. È una finalità che ci interdice, paradossalmente, la determinazione del fine, la qualificazione dello scopo di questo o quel vivente. È una finalità che potremmo definire, per questo, assoluta e astratta da ogni scopo determinato, o «ideale» come la designa Kant. Una finalità che ci fa scivolare dal giudizio «determinante», fonte di conoscenza, al giudizio «riflettente», che si rassegna a riflettere l’astratta finalità della volontà autonoma nell’astratta finalità dell’essere vivente. A noi è permesso solo giudicare, senza mai saperlo veramente, che «una cosa esiste come fine della natura quando è la causa e l’effetto di se stessa» (ivi, p. 238). L’organismo, la forma vivente, il «fine della natura» è una causa finale, di cui ai nostri occhi resta «impenetrabile» lo scopo. L’unica aggiunta che si può ancora fare è che, se l’organismo è causa ed effetto di se stesso, allora l’organismo è «un essere che si organizza da sé» (ivi, p. 242). Il che lo rende oggettivamente un «fine della natura», ossia un essere che si produce, si organizza, si forma da sé, essendo perciò dotato di una singolare «forza formatrice» (bildende Kraft). Definito in tal modo, «un essere organizzato non è una semplice macchina, che non ha altro che la forza motrice: possiede una forza formatrice, tale che la comunica alle materie che non la hanno (le organizza): una forza formatrice che si propaga e non può essere spiegata con la sola facoltà del movimento (il meccanismo)» (ivi, p. 243). L’organismo, pertanto, è scopo di se stesso poiché si forma di continuo, esprimendo e manifestando senza posa un’impenetrabile «forza formatrice» di sé, che lo anima e lo rende qualcosa di vivo, qualcosa di completamente diverso da un meccanismo inerte. Non solo, ma l’organismo resta in vita, da questo punto di vista, proprio nella misura in cui esprime e manifesta una simile forza formatrice di sé, proprio nella misura in cui continua a formarsi, continua a organizzarsi, facendo coincidere la sua vitalità con la sua finalità oggettiva interna. La tesi di Kant, in tal senso, è che la finalità oggettiva interna dell’essere organizzato si estrinsechi, non in una forma compiuta e statica, bensì in un processo di interminabile auto-formazione del vivente, di cui non si può conoscere, determinare lo scopo sul piano epistemico (dell’intelletto). La finalità della forma vivente esiste, sì, ma non si può qualificare. La perfezione o la finalità del vivente è una finalità astratta da ogni fine. Una finalità astratta che viene a combaciare con una vitalità altrettanto astratta, che a sua volta «riflette» l’astratta volontarietà della volontà autonoma, della volontà pura, che Kant per primo scopre e che pulsa, invisibile, dietro ogni scopo.
2.1.4. Ma cosa resta della «perfezione» dell’organismo in una prospettiva del genere? Resta tutto, a patto di afferrare bene cosa significa «perfezione» in un contesto simile. Se sul piano morale della persona umana la perfezione della volontà autonoma si rivela, per Kant, un’infinita perfettibilità della volontà, soggetta a un imperativo categorico di purezza e autonomia che si avvita su se stesso, sul piano vitale dell’«essere organizzato» la perfezione si rovescia anch’essa in un’infinita perfettibilità dell’organizzazione, che non cessa mai di organizzarsi. Ragion per cui la perfezione interna dell’organismo non corrisponde più, in quest’ottica, alla configurazione immota di una forma statica, ma corrisponde al mobile configurarsi di una forma dinamica, all’incessante organizzarsi dell’«essere organizzato». Di qui una prima conseguenza, strana eppure logica, di questa visione del vivente. La conseguenza è che, a conti fatti, l’organismo non sarà mai definitivamente organizzato, non sarà mai compiuto; l’organismo, invece, si formerà e si compirà di continuo, senza conoscere lo scopo della propria attività. Il vivente, secondo Kant, vuole se stesso. È questa la sua finalità, la sua volontarietà. È la pura volontà di sé a rendere vivo un organismo. Dunque, così come l’individuo morale si dimostra «perfetto» solo nella misura in cui si dimostra perfettibile, l’essere vivente si dimostra «perfetto» solo nella misura in cui si dimostra perfettibile, continuando a organizzarsi, continuando a formarsi, continuando a vivere. La perfezione del vivente non fa che «riflettere», in tal modo, la perfezione della volontà. La dinamica è la stessa e il risultato è identico – l’autonomia del vivente in un caso, l’autonomia della volontà nell’altro. Possiamo del resto scomporre il concetto kantiano di volontà autonoma in due definizioni che si implicano a vicenda. Da un lato, la volontà autonoma è una volontà pura, vale a dire una volontà vuota, priva di uno scopo determinato. Dall’altro, la volontà autonoma è una volontà di sé, vale a dire una volontà di volontà, una volontà che vuole soltanto se stessa. A questi due versanti noumenici della volontà autonoma corrispondono due espressioni sensibili, fenomeniche, empiriche della volontà. Da un lato abbiamo il «bello», inteso da Kant come finalità senza scopo dell’oggetto: è l’espressione della volontà autonoma nell’accezione della volontà pura, della volontà priva di scopo. Dall’altro abbiamo l’«organismo», inteso da Kant come mezzo e scopo di se stesso: è l’espressione della volontà autonoma nel senso della volontà di sé, della volontà che vuole se stessa. In quest’ultimo caso il concetto di volontà finisce per «riflettersi», anche nel senso prettamente kantiano dell’espressione, nel fenomeno della vita. La metafisica della volontà finisce per «riflettersi» in una metafisica della vita, di una vita che d’ora innanzi andrà vista come un’occulta, impenetrabile proprietà dell’organismo. «Forse ci si avvicina di più a questa proprietà impenetrabile quando la si chiama un analogo della vita» (ivi, p. 243). Per capire meglio il senso di questo passaggio riflessivo dalla volontà alla vita, torniamo alla «perfezione» dell’essere organizzato. Kant insiste a più riprese sul fatto (in latente contraddizione con le tesi della prima Critica) che il nexus finalis, il nesso di causa finale, appare in natura là dove il nexus effectivus, il nesso di causa efficiente, non basta ad afferrare l’intreccio fenomenico che si para davanti ai nostri occhi (Tarizzo, 2004, pp. 39-58). Ci troviamo in quel caso al cospetto di una «contingenza», al cospetto di qualcosa di cui non si può rendere ragione con l’intelletto (e le relative categorie). Ma la ragione tende comunque a rendere ragione, tale è il suo ufficio per vocazione intima, di questa eventualità. E l’unico modo in cui può ancora farlo, a questo punto, è quello di scorgere dietro di essa l’operato di una volontà. «Questa contingenza della forma in tutte le leggi empiriche relativamente alla ragione [...] è di per se stessa un argomento per considerare la sua causalità come possibile soltanto mediante la ragione; ma la ragione è sempre la facoltà di agire secondo fini (una volontà); e l’oggetto, che è rappresentato come possibile solo per mezzo di questa facoltà, sarebbe rappresentato come possibile solamente in quanto fine» (Kant, 1790, pp. 237-238). È questa la prima tappa del processo di «riflessione» della volontà nella vita. L’organismo naturale, l’essere organizzato, in virtù della sua impenetrabile contingenza agli occhi della ragione, reca per ciò stesso traccia di una volontà, di una finalità. La seconda tappa non è meno importante. La finalità dell’essere organizzato è una finalità interna, non una finalità esterna. L’organismo non è lo scopo di qualcos’altro, ma è lo scopo di se stesso. Ciò significa che la volontà (al pari della finalità) di cui esso porta il conio non è una volontà esterna, bensì interna. L’organismo esprime, insomma, una sua propria volontà, che è per l’appunto una volontà di sé, una volon tà di appropriazione di se stesso. Il che ci porta alla terza, ultima tappa della «riflessione» del concetto di volontà nel fenomeno della vita. Se l’organismo, inteso come uno scopo di se stesso, esprime una finalità interna, ossia una recondita volontà di sé, ciò significa che l’organismo non cessa mai, né può cessare, di volersi. In ciò consiste il suo segreto più profondo, che lo innalza a «fine» (della natura). L’organismo può essere in sé un «fine» (della natura) solo nella misura in cui tende in sé alla realizzazione di sé, al compimento di sé, senza mai realizzarsi, senza mai compiersi in via definitiva. Ecco perché Kant parla di una «forza formatrice» dell’organismo ed ecco perché intravede in questa forza un «analogo della vita». Perché la vita (organica, organizzata) diventa per lui l’espressione di un’enigmatica volontà di sé, che riproduce nel regno della natura l’enigma insondabile del volere soggettivo. Se la volontà autonoma della persona kantiana è una volontà che si ritrae da ogni contenuto empirico, fenomenico, sensibile, per ridursi a una volontà pura, a una semplice volontà di sé, a una anonima volontà di volontà, la vita organica non è che l’espressione naturale di questa stessa volontà, non è che l’incessante «riflessione» di questa volontà nella natura. Di qui due ulteriori conseguenze: primo, la vita organica diventa a questo punto una vita intrisa di soggettività, di aseità, una vita sempre alla ricerca di sé; secondo, questa ricerca imbocca il vicolo cieco di una pura volontà di sé, priva di contenuto, di una pura volontà di vita, priva di determinazioni. La vita affiora dalla natura come una «forza formatrice» che, proprio in quanto tale, proprio in quanto formatrice, non possiede alcuna forma in sé, ma sta a monte di ogni forma, alimentando il processo di continua formazione (o continua organizzazione) degli esseri viventi. La vita arretra al di qua di ogni forma naturale, venendo a coincidere col processo di incessante ...
Indice dei contenuti
- Introduzione. L’ontologia selvaggia
- I. Modernità: la soglia dell’autonomia
- II. Vita: genesi di un paradigma metafisico
- III. Noi: sull’utilità e il danno della vita per la storia
- Bibliografia