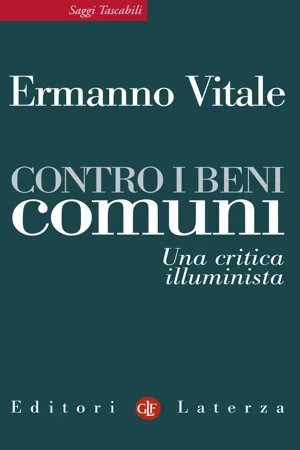II. La fiaba stinge in “vaudeville”
1. Quattro domande
Hardin e Ostrom, la vicenda inglese ed europea delle enclosures come esemplare della scomparsa di quel bel mondo antico ad opera dei pionieri del capitalismo borghese. Ma questi punti di riferimento – forse piegati alla causa dei beni comuni, come ho cercato di mostrare – non esauriscono certo l’armamentario concettuale di una ben più ambiziosa dottrina benecomunista. Nel suo Manifesto Mattei indica infatti la via di un mondo “nuovo” da raggiungere mediante – e già questa sarebbe materia di discussione – un riformismo autentico e radicale e/o una vera e propria rivoluzione. La pagina finale è tutto un fuoco di retorica, ma non dirime la questione. Si afferma che “la proprietà privata, catalizzatore di profitto e di rendita, vera cellula cancerogena della diseguaglianza, deve essere riportata immediatamente sotto rigoroso controllo pubblico e drasticamente limitata sul piano quantitativo con ogni mezzo prima che sia troppo tardi” (M, 106).
Condivido in buona misura – a parte il lessico sopra le righe: la metafora della “cellula cancerogena” è analoga a quella della “metastasi” che fioriva sulle bocche dei politici di centrodestra quando parlavano della magistratura – l’esigenza di ristabilire limiti precisi alla proprietà privata, e nel capitolo finale di questo libro proverò a ricordare alcuni tra i rimedi che sono stati proposti. Ma qui non vedo nulla, oltre la tirata retorica che così prosegue: “proporre di considerare un’entità (acqua, università, patrimonio culturale, rendita fondiaria, lavoro, informazione...) come ‘bene comune’ al fine del suo governo politico-ecologico ha certamente lo spirito di una radicale ‘inversione di rotta’ rispetto al trend apparentemente inarrestabile delle privatizzazioni, ma non significa affatto che la prospettiva sia limitata ad un ritorno di tutto il potere nelle mani di un settore pubblico burocratico, autoritario o colluso. Al contrario, la strada da intraprendere è quella dell’istituzionalizzazione, a qualunque livello politicamente possibile, di un governo partecipato dei beni comuni, capace di restituirli in una prima fase alle ‘comunità di utenti e di lavoratori’ (art. 43 Cost.) e poi definitivamente alle moltitudini che ne hanno necessità”.
Questa conclusione, tuttavia, è utile ai fini di un’analisi critica delle linee essenziali del libro di Mattei, perché – suo malgrado, o se preferite, a sua insaputa – ne riassume i vicoli ciechi e le contraddizioni. Solo per anticiparne uno, da un lato si richiama la Costituzione (art. 43) e si invita a quella che io definirei “resistenza costituzionale”, dall’altro si vagheggia una soluzione rivoluzionaria sulla scia di Hardt e Negri, quando il potere (perché di questo si tratta, o no?) sarà “restituito” alle “moltitudini che ne hanno necessità”.
Ma non voglio, come si suol dire, “sparare sulla Croce Rossa”, ossia soffermarmi più di tanto a imputare a “un manifesto” qualche spavalda quanto maldestra uscita sul terreno della filosofia pura. Su questo terreno tanto vale risalire alle fonti e analizzare le posizioni di Toni Negri, in particolare in Comune. Oltre il privato e il pubblico, ultimo volume della trilogia firmata con Michael Hardt, senza trascurare alcune interessanti pagine di un giovane studioso come Coccoli. Anche se di questi aspetti strettamente filosofici si occuperà il prossimo paragrafo, è opportuno – senza insistere, per carità! – presentare un breve florilegio tratto da “un manifesto”.
In primo luogo, nella “narrativa” benecomunista “prima vengono gli interessi di tutti (umani e non), concepiti come un ecosistema di relazioni di reciproca dipendenza, e solo successivamente gli interessi individuali. Poiché gli individui non sono neppure materialmente concepibili come monadi isolate (in natura, l’individuo solo necessariamente soccombe e muore), i beni comuni smascherano gli assunti irrealistici dell’individualismo borghese. Il loro riconoscimento promuove la costruzione di un immaginario comune in cui la libertà individuale va considerata come parte del mondo dell’essere, consistente nella facoltà di accedere e godere dei beni comuni e delle relazioni sociali comunitarie (e politiche) che essi rendono possibili. La libertà dell’essere va nettamente separata dalla brutale soddisfazione degli appetiti acquisitivi dell’avere per accumulare” (M, 49).
C’è un’amplissima letteratura, che parte dall’antica Grecia, sulla difficoltà estrema di coniugare una qualsiasi idea di bene comune con le libertà individuali, per il semplice fatto che sull’argomento la condivisione intersoggettiva tende a zero. Il bene comune, ammesso che esista, ciascuno lo vede a modo suo... Non a caso, Platone affida il riconoscimento e la gestione del bene comune al re-filosofo o ai pochissimi re-filosofi, ovvero a una ristrettissima élite fondata sulla conoscenza che deve “persuadere” le altre componenti di una collettività politica concepita in forma organica e fortemente gerarchica. E poi questa storia degli “assunti irrealistici dell’individualismo borghese”! Già Hobbes chiarisce il punto nel Leviatano (1651), quando replica agli scopritori di acqua calda i quali, “a mo’ di grande obiezione”, affermano che lo stato di natura puro – la condizione della guerra di tutti contro tutti degli individui nati dalla terra come funghi – non esiste. Hobbes riconosce la natura ipotetica e non storica di questa condizione, che serve soltanto – come fanno gli scienziati quando creano condizioni artificiali in laboratorio – a comprendere quale sia il modo migliore per costruire l’architettura istituzionale dello Stato.
Andando avanti, si legge che “l’opposizione strutturale con cui ci stiamo familiarizzando è quella fra la logica riduzionistica e meccanicistica della modernità (condivisa da proprietà privata e Stato) e quella fenomenologica, relazionale, partecipativa, olistica e critica propria del comune. Soltanto quest’ultimo supera il riduzionismo cartesiano soggetto-oggetto e il conseguente delirio della modernità, che ha portato l’umano (soggetto astratto) a collocarsi al di fuori della natura, autoproclamandosi suo dominus” (M, 69). Anche qui potremmo chiedere di quale natura stiamo parlando, perché ci sono molte idee diverse di natura (basta consultare un dizionario di filosofia), o quale sia esattamente il nesso tra logica meccanicistica, proprietà privata e Stato; o ancora, come sfuggire (senza fare uso di sofismi) alla distinzione tra soggetto e oggetto senza distruggere la grammatica che anche Mattei grosso modo rispetta, e così via. Sono domande noiose, lo so, che non scaldano il cuore e non predispongono alla lotta, ma se non si prova a dare una risposta articolata si scopre prima o poi che ci si è impegnati in una lotta fondata su un castello di sabbia costruito con parole vuote. E sono risvegli amari.
Infine, il passaggio più esoterico: “si va imponendo sempre più una visione che vede Gaia [la terra vivente] come una comunità di comunità ecologiche, legate fra loro in una grande rete, un network di relazioni simbiotiche e mutualistiche, in cui ciascun individuo (umano o meno che sia) non può che esistere nel quadro di rapporti e relazioni diffusi, secondo modelli di reciprocità complessa” (M, 101). Una volta Bobbio definì Heidegger “principe delle tenebre”: qui, in sedicesimo, si potrebbe parlare di un “barone della penombra”. In ogni caso, adesso scendo in paese e vedo quanti sanno chi è Gaia, per vedere a che punto siamo con questa visione che si va imponendo (probabilmente mi risponderanno che è la figlia del sindaco, e sarà già un successo...).
Ma lasciamo Gaia e l’alta filosofia per tornare alla conclusione di “un manifesto” citata sopra, e che per comodità del lettore riprendo: “proporre di considerare un’entità (acqua, università, patrimonio culturale, rendita fondiaria, lavoro, informazione...) come ‘bene comune’ al fine del suo governo politico-ecologico ha certamente lo spirito di una radicale ‘inversione di rotta’ rispetto al trend apparentemente inarrestabile delle privatizzazioni, ma non significa affatto che la prospettiva sia limitata ad un ritorno di tutto il potere nelle mani di un settore pubblico burocratico, autoritario o colluso. Al contrario, la strada da intraprendere è quella dell’istituzionalizzazione, a qualunque livello politicamente possibile, di un governo partecipato dei beni comuni, capace di restituirli in una prima fase alle ‘comunità di utenti e di lavoratori’ (art. 43 Cost.) e poi definitivamente alle moltitudini che ne hanno necessità” (M, 106).
Per comprendere se ci siano e quali siano le contraddizioni e i vicoli ciechi del benecomunismo, o almeno di questa sua (autorevole) versione, vorrei porre a “un manifesto” quattro domande, che anche in questa conclusione riaffiorano carsicamente, non risolte, come anime del purgatorio. L’impresa non è facile, dato il carattere affabulatorio del testo, che ben si presta a sostenere che in ogni caso l’interlocutore ha frainteso. Comunque sia, ci proviamo.
La prima domanda, imprescindibile da un punto di vista teorico-analitico ma credo interessante anche da quello di chi nel concreto già militi o vorrebbe militare sotto le bandiere del benecomunismo, riguarda la definizione. Tutti i grandi autori della filosofia politica e giuridica definiscono i loro concetti fondamentali. È la premessa per dare senso al dialogo, ne è il sale, sia pure nel più aspro dissenso. Per esempio, nella Repubblica platonica Trasimaco definisce la giustizia come l’utile del più forte, e Socrate gli contrappone la definizione della giustizia come “l’attitudine di ciascun cittadino a svolgere il suo proprio ruolo”. Anche l’immaginifico Platone, che intesse i suoi dialoghi di miti e grandi allegorie, non può prescindere dalle definizioni.
Che cosa diavolo sono i beni comuni? Un manifesto dei beni comuni dovrebbe dircelo con la massima chiarezza possibile, ma l’elenco di “entità” tanto disparate – seguito per giunta da “puntini, puntini” – che troviamo nelle conclusioni non rassicura. Tuttavia mai dire mai: magari non una vera e propria definizione, ma qualche indicazione che potrebbe tradursi in un abbozzo di definizione e di tipologia forse si potrà trovare.
La seconda domanda, ammesso che si trovi una risposta plausibile alla prima, potrebbe essere formulata così: a chi sono comuni i (o quali) beni comuni? A piccole comunità tradizionali, come nei casi studiati da Ostrom, alla nazione, a collettività (idealmente) sovranazionali come l’Unione europea, all’umanità in quanto tale? O l’affermazione dei beni comuni implica un moto rivoluzionario che ridisegni tutta la nostra tavola dei poteri politici e delle competenze istituzionali? Vediamo se si trova qualche indizio in tal senso, perché rispondere “alle moltitudini che ne hanno necessità”, al netto della retorica, non vuol dire nulla.
La terza domanda, una volta stabilito quali siano e a chi sono comuni i beni comuni, riguarda il governo (la governance? Sarebbe uno slittamento lessicale curioso...) dei medesimi, ossia la loro gestione. Chi amministrerà i beni comuni? Certo non lo Stato burocratico, autoritario o colluso, ma allora chi? Tutti i consoci (i comunardi?) direttamente, come pare indicare l’espressione “governo partecipato dei beni comuni”, cioè in forme di democrazia assembleare, o saranno ammesse deleghe ad un “esecutivo” e forme di rappresentanza, con o senza vincolo di mandato? Oppure vogliamo dichiarare che tutto il bagaglio di argomenti e controargomenti elaborato in duemilacinquecento anni di pensiero politico va gettato a mare, perché qui siamo di fronte all’assolutamente inedito, al Nuovo con la maiuscola che presuppone innanzitutto l’uomo nuovo?
Le dure repliche della storia ci insegnano che finora la costruzione della “nuova umanità” è sempre terminata con grandi carneficine, con la negazione di qualsiasi umanità. Però, chissà mai che questa sia la volta buona.
La quarta domanda riguarda il terreno relativamente più solido e delimitato del costituzionalismo. Si fa riferimento all’art. 43 della Costituzione italiana, che appartiene a quell’insieme di articoli che vanno sotto il titolo di “Rapporti etico-sociali” e in particolare a quel gruppo (artt. 41-47) che definisce le forme di economia e di proprietà. Ciò che si legge a chiare lettere è che “la proprietà è pubblica o privata” (art. 42) e che “l’iniziativa economica privata è libera”, ma non può svolgersi “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana” (art. 41). Si riconosce inoltre “la funzione sociale della cooperazione” (art. 45) e la possibilità che “ai fini di utilità generale” si riservino originariamente, o tramite espropriazione salvo indennizzo, “determinate imprese o categorie d’imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale” allo Stato, a enti pubblici o, infine, a “comunità di lavoratori o di utenti”.
Francamente, mi pare che, anche a voler forzare un’interpretazione, lo spazio che la Costituzione italiana riserva all’eventualità dei beni comuni sia residuale. Ahimè, la proprietà è pubblica o privata. Ciò che sembra premere ai costituenti è soprattutto – e non è poco, e andrebbe riscattato dall’oblio – che la proprietà privata non sia in contrasto con l’interesse generale dello Stato e con i diritti fondamentali della persona e del cittadino. E allora la quarta domanda è: che ne vogliono fare i benecomunisti della nostra Costituzione? Continuare a tenerla in onore, forse riformandola nella delicatissima prima parte (perché fino all’art. 54 siamo nella prima parte), o scriverne una nuova, una costituzione rivoluzionaria, prendendo magari a modello le osannate costituzioni dell’Ecuador e della Bolivia?
2. Vicoli ciechi, si esce a colpi di scena
Proviamo dunque a procedere con ordine, iniziando dalla prima domanda, che cosa sono per “un manifesto” i beni comuni: “Un bene comune, a differenza tanto della proprietà privata quanto di quella pubblica (appartenente allo Stato: proprietà demaniale), non può concepirsi come un mero oggetto, una porzione tangibile del mondo esterno. Non può essere colto con la logica meccanicistica e riduzionistica tipica dell’Illuminismo, che separa nettamente il soggetto dall’oggetto. In una parola, non può essere ricondotto all’idea moderna di merce. Il bene comune, infatti, esiste soltanto in una relazione qualitativa. Noi non abbiamo un bene comune (un ecosistema, dell’acqua) ma in un certo senso ‘siamo’ (partecipi del) bene comune (siamo acqua, siamo parte di un ecosistema urbano o rurale)” (M, 52).
Poco oltre: “La fenomenologia dei beni comuni è nettamente funzionalistica, nel senso che essi divengono rilevanti per un particolare fine sociale coerente con le esigenze dell’ecologia politica. I beni comuni richiedono perciò una percezione olistica, che ne colga appieno gli inestricabili nessi con la comunità di riferimento e con le altre comunità ad essa contigue o che con essa si sovrappongono. Essi non possono in alcun caso essere oggettificati. Ecco perché alcune delle classificazioni che cominciano ad emergere riguardo ai beni comuni – quali ad esempio beni comuni naturali (ambiente, acqua, aria pura) e beni comuni sociali (beni culturali, memoria storica, sapere), o ancora beni comuni materiali (piazze, giardini pubblici) o immateriali (spazio comune del web) – devono essere oggetto di riflessione critica approfondita e vanno maneggiate con consapevolezza e grande cautela. Esse veicolano in qualche modo la vecchia logica meccanicistica fra soggetto e oggetto, con conseguenti rischi, sempre in agguato, della mercificazione” (M, 54).
Si potrebbe andare avanti, ma credo possa bastare per rendersi conto. Partiamo dal fondo, dalla critica a qualsiasi tentativo di classificazione dei beni comuni che implica anche il tentativo di dichiarare che cosa è bene comune e che cosa invece rimane prop...