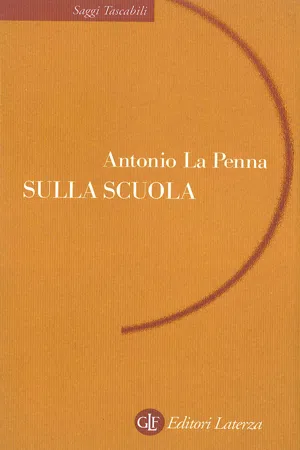
- 172 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Sulla scuola
Informazioni su questo libro
Un grande maestro degli studi sull'antichità classica fornisce una diagnosi controcorrente della grave crisi della scuola italiana, ricavando dalla propria esperienza proposte di rimedi e di sviluppo.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Argomento
DidatticaCategoria
Politiche educativeII. La Commissione dei «Saggi» ovvero Un’orchestra senza maestro
1. La formazione della Commissione
Non so quanta attenzione l’opinione pubblica e il mondo della scuola abbiano dedicato ai lavori della Commissione dei «Saggi», istituita dal ministero della Pubblica Istruzione e riunitasi sei volte dal gennaio al maggio del 1997, e quanti abbiano letto il volume che raccoglie i frutti di quei lavori1. La mole (438 pp.) e le molte ripetizioni (in parte inevitabili) possono indurre facilmente nella tentazione di buttar via il volume; e certamente ciò che di utile se ne ricava è troppo poco rispetto alla mole; credo, tuttavia, che di utile se ne ricavi parecchio: più che idee nuove, vi troviamo la conferma, talvolta ben argomentata, di orientamenti per lo più giusti; ma questo non è poco nel disorientamento in cui ci troviamo a vivere dopo la cosiddetta caduta delle ideologie (che si potrebbe dire, più precisamente, mancanza di idee, di ideali, e anche di programmi); si consideri, poi, che il libro riguarda uno dei problemi più gravi della società italiana di oggi: insomma, io ne consiglierei la lettura a quanti vivono nel mondo della scuola e a quanti per i problemi della scuola hanno un interesse non superficiale.
L’idea di consultare, in vista di una riforma della scuola che vuol essere molto innovativa, personalità di rilievo nel mondo della cultura, ma esterne al sistema della scuola, non era da scartare a priori: è certamente utile sapere come la scuola viene vista dal di fuori e che cosa ci si aspetta dalla scuola. Tuttavia i criteri fissati per la scelta non riescono chiari, e ancora meno chiaro è in che modo siano stati seguiti. Dal primo documento introduttivo parrebbe che i criteri fossero tre2:
1) i Saggi della Commissione dovevano essere «esterni al sistema scuola»;
2) dovevano essere degli esperti (esperti, si suppone, dei problemi della scuola);
3) i membri erano stati identificati come «Saggi» dai «grandi mezzi di comunicazione» (penso che l’espressione si riferisca ai giornali e alla televisione).
Ora anche un inesperto si accorge che in realtà nessuno di questi criteri è stato seguito con rigore. I membri non sono tutti esterni al sistema scuola: vi figurano, infatti, ispettori ministeriali e anche una preside; inoltre c’è da chiedersi se si possano considerare esterni al sistema scuola «Saggi» come Clotilde Pontecorvo, che, studiando da tempo i problemi della scuola, ha con essa contatti diretti e ne ha una conoscenza invidiabile, o come Vittorio Cogliati Dezza, che è responsabile nazionale del settore scuola e formazione di Legambiente; ma non voglio stare a sottilizzare. Molto più perplessi si resta sull’applicazione del secondo criterio. Se un intellettuale, più o meno illustre, sia esperto di scuola, dovrebbe risultare dalle opere scritte o da interventi non sporadici, in cui abbia dato prove della sua esperienza; ma niente di questo mi risulta per membri illustri, di alti meriti nel loro campo di attività, come Giuliano Amato, Carlo Bo, Rita Levi Montalcini, Mario Martone, Riccardo Muti (e potrei allungare l’elenco). Ho parecchi dubbi anche sulla fedeltà al terzo criterio: nell’elenco trovo, certo, alcuni personaggi famosi, ma altri (fra cui alcuni colleghi universitari) hanno fama solo nell’ambito del loro ateneo; di altri non avevo mai sentito il nome prima di leggere questo volume. Tuttavia debbo accompagnare questi dubbi con forti riserve: io non sono assiduo lettore delle gazzette (Nietzsche ne evitava la lettura per non guastarsi lo stile, ma io non ho di tali pretese: dipende solo da mancanza di tempo e da pigrizia); la sera frequento un po’ di più la televisione, ma solo per ascoltare un notiziario e distrarmi con qualche film giallo: quindi non posso escludere che qualcuno dei personaggi a me ignoti goda di un’audience confrontabile con quella di Raffaella Carrà o Mara Venier. Del resto il non aver seguito con rigore il criterio dell’audience presenta anche dei vantaggi: così è stato chiamato nella Commissione Luigi Radicati, uno scienziato di grandi meriti, serio e davvero «Saggio», mentre è restato fuori lo Zichichi, ben noto al pubblico televisivo. Intendiamoci: io non lamento che i criteri fissati siano stati poco seguiti; voglio solo segnalare una scarsa chiarezza di idee, che ha avuto conseguenze ben visibili sui frutti del lavoro.
Cerchiamo di capire meglio come la Commissione fosse formata effettivamente. Larga la presenza di docenti universitari, alcuni dei quali ben noti per i loro meriti scientifici; ma tra i docenti solo pochi erano veramente esperti di scuola e hanno dimostrato qualche impegno nel loro compito (per es., Silvano Tagliagambe, Tullio De Mauro, la Pontecorvo); altri si sono astenuti o hanno dato risposte banali e insignificanti. Non è particolarmente originale, per es., l’intervento del premio Nobel della Commissione, Rita Levi Montalcini, che viene spesso interpellata dalla televisione e disserta, o cinguetta, su qualsiasi argomento, come se il premio Nobel conferisse l’onniscienza. Ha ripetuto una lamentela largamente diffusa, anche in seno alla Commissione, denunciando il pericolo «rappresentato da un sistema sommatorio di un sapere illusoriamente enciclopedico»; poi esorta, riferendosi agli insegnanti, a «cercare i mezzi per incentivare l’impegno e migliorare la qualità della loro attività didattica» e propone una verifica periodica della preparazione e dell’attività dei docenti, corsi di aggiornamento, l’anno sabbatico3: tutte proposte lodevoli, ma non peregrine. Si tratta, comunque, di trovare i mezzi necessari. Denunciare il carattere dispersivo, sommatorio, falsamente enciclopedico del nostro insegnamento scolastico è facile; il difficile è indicare una base o un asse unitario della formazione (torneremo a questo problema più in là). Questo intervento, tuttavia, è denso e illuminante in confronto con quello del chiarissimo matematico Edoardo Vesentini, il quale ammonisce che «il legame unificante è affidato al docente»4 (come se nelle scuole medie il docente fosse unico).
Provenivano da organismi operanti nel mondo dell’economia Carlo Callieri e Giuseppe De Rita, il primo vicepresidente della Confindustria e guida della Commissione scuola della stessa Confindustria, il secondo presidente del Cnel. Si ha l’impressione che in questa sfera si proceda e si pensi con più serietà: ambedue hanno dimostrato buona preparazione sui problemi generali della scuola e li hanno affrontati in un orizzonte ampio; io non sono del tutto d’accordo con la loro impostazione, ma tutto ciò che essi hanno scritto in questo volume, va meditato attentamente. Ben altra impressione suscitano i «Saggi» provenienti dal mondo delle gazzette e degli spettacoli: qui si entra nel mondo dell’improvvisazione e della provvisorietà, della doxa ancora lontana dall’alètheia, del discorso agile ed estroso, ma privo di ponderazione, di controllo, di verifiche, delle parole leggere, sospese in aria, del lògos che ricerca l’effetto, la forza di persuasione, non la verità; non nego, tuttavia, che anche da questo pensiero leggero e provvisorio si possano ricavare suggerimenti utili. Un buon esemplare di questa varia tipologia culturale è il professor Paolo Damiani, presidente dell’Associazione italiana di jazz. Il primo intervento5, propiziato da due citazioni preliminari, l’una di Pietro Citati, l’altra di Pablo Neruda, e ornato poi di parecchie altre citazioni, si apre con slancio lirico: «Le immagini complesse e forti contenute nella lettera dell’onorevole Luigi Berlinguer prefigurano scuole nuove in cui tra l’altro sia possibile ‘navigare liberamente dentro aree mobili del sapere’». La scuola ha per obiettivo di portare il giovane a scegliere liberamente la propria strada, e «ad assumersi responsabilità, a crescere [...] cercando il piacere di vivere».
Vediamo ora in che cosa consiste questo piacere e quale dev’essere la funzione del docente:
Questo piacere consiste nel partecipare a processi creativi che devono essere attivati insieme, nella scuola e fuori di essa. Per conseguire questo obiettivo è necessario che il docente possieda una buona dose di passione ed abbia sufficiente conoscenza del proprio mondo interiore.
Dunque passione e conoscenza di sé: pare meno importante che il docente possieda competenze scientifiche su qualche parte del mondo che è fuori di lui. I Lehrjahre del ragazzo sono un viaggio di piacere attraverso le Immagini, che sono più importanti delle Storie; e la fine del viaggio è meravigliosa: «Ecco allora una scuola che ti dura dentro, anche quando è finita, perché ti ha regalato un’immagine, quella dell’avventura della quotidianità».
Non è il caso di citare altri brani lirici: è abbastanza chiaro, io credo, che questa navigazione libera e avventurosa non approda a niente di formativo: con la leggerezza di Valéry e di Calvino non si forma né un elettrotecnico né un ingegnere né un medico. Una tale pedagogia potrà andar bene per musicisti o pittori in erba, per ragazzi di grande talento, ma, sottovalutando troppo la tecnica rispetto alla creatività, non serve neppure a formare suonatori d’orchestra o pittori di livello modesto. Non vorrei essere frainteso: da queste effusioni liriche Damiani emerge come una personalità ricca di estro e di fantasia, che si ascolta con piacere; ma non credo che possa dare nessun contributo serio per risolvere i problemi della scuola.
Sono stati interpellati anche scrittori noti a un largo pubblico, come il romanziere Antonio Tabucchi e il poeta Mario Luzi. Tabucchi, che cerca d’infondere un po’ d’impegno civile nella dilagante letteratura amena dei nostri tempi, non vuole apparire privo di originalità6 e propone di «creare» una disciplina che potrebbe perfettamente costituire una «navigazione mobile». Affascinato anche lui dall’immagine della libera navigazione, pensa a una disciplina che «dovrebbe muoversi tra Storia-Letteratura-Antropologia-Sociologia (senza nessun esplicito e privilegiato riferimento a queste discipline specifiche)»; in concreto consiglia lo studio di opere come il Traité de la tolérance di Voltaire, Dei delitti e delle pene di Beccaria o il Corano. Ma Voltaire e Beccaria possono trovar posto in una disciplina già esistente, che viene chiamata educazione civica e viene associata con la storia; che la si insegni poco e male, è un’altra questione; del resto «la mobile navigazione» di Tabucchi potrebbe finire anche peggio. Ora prevale la tendenza, che ritengo giusta, a sostituire l’educazione civica con diritto ed economia, e nell’insegnamento elementare di diritto si collocherebbe opportunamente l’opera di Beccaria; il secolo dei lumi si studia sia in storia sia in filosofia, e in storia si studia anche l’Islam. Perché aggiungere un’altra disciplina? Meno peregrina è la proposta di utilizzare di più l’immagine, ricorrendo agli strumenti audiovisivi, e di far vedere come viene elaborata la trasposizione cinematografica di un romanzo. Nella scuola oggi si fa molto di più: il teatro ha preso un discreto spazio, che si va ampliando, e gli studenti stessi fanno da attori in opere teatrali, talvolta rielaborate e adattate liberamente. L’intervento di Tabucchi è vivace e interessante, ma proviene da uno che conosce poco la scuola di oggi e, quindi, sa poco di ciò che vi si insegna e delle proposte affacciate in dibattiti e progetti.
A Mario Luzi7 gli amici del liceo classico (fra i quali mi pongo anch’io) devono essere grati per ciò che ha scritto su questo curriculum scolastico:
Il Liceo deve a mio parere restare l’asse e il modello del nostro sistema formativo umanistico che se vivo è predisposto a tutte le esigenze e le acquisizioni predicate dal documento di sintesi del lavoro che la commissione ha già fatto.
Per chi studia Luzi, è interessante anche l’indicazione dei temi da lui preferiti: filosofia, religione, arte e poesia del Duecento e del Trecento, del Cinquecento; «la lunga lotta per una società libera, il periodo romantico»; «il Novecento, la sua ricerca della realtà». Altri scrittori, registi, direttori d’orchestra, che figurano nell’albo dei «Saggi», non hanno espresso (almeno a quanto risulta dal volume) nessuna opinione: mi riferisco, per es., a Carlo Bo, Mario Martone, Riccardo Muti. Forse Carlo Bo, senatore a vita, «duca di Urbino», benché abbia scritto tanto sulle gazzette, in questo caso ha preferito ispirarsi ad uno dei poeti romantici a lui cari:
Seul le silence est grand: tout le reste est faiblesse.
Ma è più probabile che abbia ritenuto la fatica poco remunerativa e, quindi, inutile. Né si poteva immaginare che si scomodasse un divo degli spettacoli musicali come Riccardo Muti: avrà pensato che era roba per esperti di jazz o di rock-and-roll.
Più degni di attenzione sono contributi dati da personaggi che lavorano nel mondo della scuola; ma non oserei estendere questo giudizio all’unica preside eletta nella Commissione. Questa signora ha superato tutti per impegno, zelo, assiduità: fra i contributi si possono l...
Indice dei contenuti
- Prefazione
- Parte prima
- I. I moderni e gli antichi
- II. La Commissione dei «Saggi» ovvero Un’orchestra senza maestro
- III. L’irruzione della storia del Novecento nelle scuole medie
- IV. Per una scuola aperta e anticonformista
- Parte seconda
- V. La crisi della scuola media superiore in Italia
- VI. La democrazia possibile e utile nella scuola
- Nota al testo
- Appendice. Altri scritti dello stesso autore su problemi delle scuole medie in Italia
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Sulla scuola di Antonio La Penna in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Didattica e Politiche educative. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.