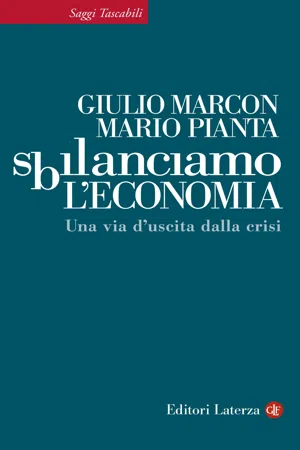1. Europa, Italia. I problemi, le soluzioni
L’economia in recessione, la società in frantumi, la politica bloccata. Questa è l’Italia del 2013, dopo cinque anni di crisi, iniziata con il crollo finanziario del 2008 negli Stati Uniti. Nel 2013 si prevede un nuovo calo del prodotto interno lordo (pil) del paese, dopo che nel 2012 il pil è diminuito del 2,4%. Era già caduto dell’1,2% nel 2008, del 5,1% nel 2009 ed era rimasto stagnante nel 2010 e 2011. Dopo quattro anni di governi di Silvio Berlusconi e Mario Monti il bilancio è che oggi, in termini reali, al netto dell’aumento dei prezzi, il pil italiano è ai livelli di dieci anni fa. Se lo dividiamo per il numero di abitanti, il reddito medio pro capite è sceso ai livelli del 2000. Ma il reddito “medio” è un’illusione statistica, le disuguaglianze sono aumentate e tutto l’aumento di reddito degli ultimi dieci anni è finito ad aumentare la ricchezza del 10% più ricco degli italiani, che a fine 2010 possedeva il 45,9% di tutta la ricchezza – immobiliare e finanziaria – del paese, mentre al 50% degli italiani meno fortunati rimaneva appena il 9,4%. Nove italiani su dieci stanno ora peggio di dieci anni fa.
Il peggioramento dell’economia si è accompagnato a una crisi sociale senza precedenti. Il tasso di disoccupazione a fine 2012 era all’11,1%, pari a 2,8 milioni di persone, a cui si deve aggiungere l’equivalente di 520 mila persone in cassa integrazione a zero ore (1,1 miliardi di ore di lavoro perdute da due milioni di lavoratori, il 12% in più rispetto al 2011) e circa un milione e mezzo di persone in cerca di lavoro ma “scoraggiate”, che scivolano fuori dalla definizione restrittiva delle statistiche sulla disoccupazione. In tutto, se ricalcoliamo la percentuale effettiva dei senza lavoro su chi vorrebbe lavorare, arriviamo al 18%, più di un italiano su sei.
I giovani sono i più colpiti. Nel 2012 il 37% dei giovani non lavora, un livello che non ha precedenti. Due milioni di ragazzi non studiano né lavorano e rischiano di restare fuori da ogni forma di integrazione sociale. Tra coloro che un lavoro ce l’hanno ci sono oggi quattro milioni di lavoratori precari, in maggioranza giovani – quasi un dipendente su quattro, un altro record negativo – distribuiti nella quarantina di diversi contratti di lavoro introdotti da una serie infinita di “riforme” del mercato del lavoro.
Tutto questo si accompagna a una grave caduta dei redditi e dei consumi. I profitti delle imprese aumentano molto più dei salari e l’inflazione nel 2012 ha ridotto i salari reali del 2%. Nel 2010 in Italia il salario medio (al lordo delle tasse, per un lavoro a tempo pieno) nel settore privato era di 28 mila euro, contro gli oltre 42 mila di Germania, Gran Bretagna, Austria, Belgio, Olanda e Svezia. Tra chi è occupato, lavoratori di età avanzata con contratti stabili e salari dignitosi vengono sostituiti da giovani con contratti precari e salari spesso dimezzati. Aumenta così la povertà: oltre 8 milioni di persone, l’11,1% delle famiglie, vivevano nel 2011 con un reddito sotto la soglia di mille euro per una famiglia di due persone.
Oltre ai bassi salari, le pensioni sono state ridotte e l’età per andarci è aumentata; ci sono 390 mila lavoratori “esodati” che erano usciti dall’impiego con la prospettiva di andare in pensione che nel 2012 si sono trovati senza né l’uno, né l’altra. I servizi di welfare – la scuola, la salute, l’assistenza – vengono ridimensionati dai tagli di spesa e diventano più costosi – peggiorando le condizioni di vita degli italiani. L’incertezza sul futuro pesa sulle scelte di vita – famiglie, figli, studi, ecc. – e porta a una società bloccata. L’immigrazione è rallentata molto e, secondo alcune fonti, gli italiani che emigrano – soprattutto verso il Nord Europa – (e gli immigrati che si spostano altrove) sono già più numerosi degli stranieri in arrivo nel paese. Con il degrado sociale crescono le spinte razziste e xenofobe, aumentano i reati, si allarga l’economia criminale.
E, accanto alla crisi sociale, scoppia l’emergenza ambientale. Il cambiamento climatico provocato dalle nostre emissioni porta a situazioni meteorologiche estreme, siccità da un lato, piogge e inondazioni dall’altro. Un uso del territorio dissennato ha moltiplicato le nuove costruzioni in zone inadatte, devastando il paesaggio e rompendo gli equilibri ecologici; un’inondazione si trasforma così, sempre più di frequente, in un disastro ambientale con molte vittime. La pianificazione urbanistica, la tutela del territorio e la prevenzione sono state abbandonate alla “libertà di costruire” e i sistemi naturali sono stati sconvolti dallo sviluppo insostenibile che ha avuto il paese. In ogni ambito – l’ambiente, l’acqua, l’agricoltura, l’energia, le risorse naturali, i rifiuti, i trasporti, ecc. – siamo di fronte a crisi sempre più frequenti e all’incapacità di trovare soluzioni.
Questa crisi profonda del paese ha molte cause. C’è la traiettoria di lungo periodo del modello di sviluppo del paese che è inadeguato sul piano economico – segnato dall’ascesa della finanza e dal declino della produzione –, ingiusto sul piano sociale, insostenibile sul piano ambientale. C’è l’effetto della crisi scoppiata nel 2008 e delle politiche europee di austerità che sono state imposte al paese. C’è infine l’incapacità delle autorità europee e del governo italiano di costruire una politica che sappia trovare una via d’uscita alla crisi di oggi. Esaminiamo ora ciascuno di questi fattori.
1. Il lungo declino italiano
La crisi italiana è resa evidente dal crollo della produzione industriale. Secondo il Centro studi Confindustria la produzione industriale nel dicembre 2012 è del 25% inferiore al livello pre-crisi (aprile 2008). In questi cinque anni un quarto della capacità produttiva del paese è rimasta inutilizzata e rischia di andare perduta. Ma è l’intera traiettoria dello sviluppo italiano degli ultimi vent’anni a presentare gravi distorsioni, che sono alla base del declino italiano. Le possiamo riassumere in quattro problemi principali: la crescita della finanza e l’assenza di investimenti produttivi; la mancanza di ricerca e innovazione; una struttura produttiva debole; imprese troppo piccole. Quattro problemi strettamente intrecciati tra loro, a cui si aggiunge l’insostenibilità ambientale del modello di sviluppo.
Troppa finanza, pochi investimenti. Il primo problema è l’estendersi della finanza. Le imprese, le banche e gli italiani più ricchi si sono lanciati nei circuiti della finanza globale alla ricerca di guadagni speculativi. Secondo le Relazioni della Banca d’Italia, le attività finanziarie totali dell’Italia – depositi bancari, titoli, azioni, fondi, investimenti finanziari all’estero di famiglie e imprese, crediti concessi dalle banche, ecc. – avevano nel 1996 un valore pari a meno di cinque volte il pil; nel 2011 rappresentano un ammontare pari a quasi otto volte e mezzo il pil del paese. Le attività finanziarie non hanno subito in modo significativo gli effetti della crisi, e la loro crescita è continuata anche in questi anni di recessione (con l’eccezione del 2010). La dimensione internazionale della finanza è cresciuta notevolmente; sono stati utilizzati paradisi fiscali per trasferire capitali e profitti dove la tassazione è minima; solo in Svizzera si valuta ci siano 150 miliardi di euro di capitali italiani trasferiti clandestinamente, sottratti all’imposizione fiscale.
Sono risorse finanziarie che vengono dagli alti profitti ottenuti dalle imprese. In Italia il rapporto tra profitti lordi delle società (non finanziarie) e valore aggiunto è molto più alto che negli altri paesi europei – oltre il 40% nell’anno di crisi 2009, contro il 30% in Francia – ma gli investimenti fissi sono appena il 22% del valore aggiunto e il peso degli investimenti in macchinari, che consentono produzioni più efficienti, è diminuito. Le imprese non hanno reinvestito i profitti in nuove produzioni, si sono indebitate di più con le banche (approfittando dei bassi tassi d’interesse) e hanno trasferito grandi risorse finanziarie ai proprietari (ad esempio con alti dividendi agli azionisti, “super bonus” ai manager e operazioni straordinarie “familiari”). La finanza e la speculazione sono state così alimentate da un trasferimento di risorse dell’ordine di centinaia di miliardi, che ha limitato le possibilità di sviluppo del paese.
Poca ricerca, poca innovazione. L’Italia nel 2010 ha speso per ricerca e sviluppo appena l’1,26% del pil, contro il 2,2% della Francia, il 2,8% della Germania, il 3,4% della Svezia. Tale divario è dovuto soprattutto ai bassi livelli di spesa delle imprese private. Le imprese non investono e con la crisi è arrivata la chiusura di molti laboratori; le università hanno avuto i fondi tagliati, migliaia di ricercatori italiani sono emigrati all’estero. Con meno ricerca, meno personale scientifico e tecnologico, e livelli di istruzione che sono ancora molto al di sotto degli altri paesi europei, il risultato è una minor innovazione: in Italia solo il 30% delle imprese ha introdotto nel 2008 un nuovo prodotto o processo, mentre la media dell’Europa a 15 è vicina al 40%. Le innovazioni vanno soprattutto nell’acquisto di macchinari, che hanno in prevalenza l’effetto di sostituire lavoratori, mentre è ridotta la capacità di competere attraverso tecnologie superiori, che consentirebbero – come in Germania e in Svezia – livelli di produttività e salario più elevati.
Troppi settori tradizionali. La struttura del sistema produttivo italiano è ancora segnata da un peso elevato di industrie tradizionali (alimentari, tessile, calzature, legno, prodotti in metallo), che contano per il 46% degli occupati manifatturieri, contro il 31% della Germania. Lo stesso avviene nei servizi, con un peso elevato in Italia del commercio al dettaglio, riparazioni, ecc., mentre i servizi avanzati alle imprese sono quelli in maggior crescita nel resto d’Europa. Una struttura economica di questo tipo porta a risultati economici peggiori: una minor dinamica della produttività media, salari più bassi, la perdita di esportazioni per la concorrenza dei paesi emergenti, un maggior deficit degli scambi con l’estero, più vulnerabilità di fronte alla crisi.
Imprese troppo piccole. L’Italia ha il record negativo della dimensione d’impresa: ci sono 510 mila imprese con meno di 9 addetti, l’84% del totale, e un altro 15% ha tra 10 e 49 addetti. Le imprese con più di 250 addetti sono 1400 in Italia e 4000 in Germania. Solo imprese di una certa dimensione possono investire in attività avanzate, ottenere economie di scala e riduzioni dei costi, aumentare l’efficienza. Molte piccole imprese hanno tentato di ridurre i costi spostando produzioni (e posti di lavoro) nei paesi dell’Est e del Mediterraneo, senza però ottenere risultati significativi in termini di mercato. Il “modello italiano” di reti di piccole imprese e di distretti industriali è stato particolarmente colpito dalla crisi, con chiusura di aziende e caduta di occupazione; attività crescenti sono ora integrate nei sistemi di produzione internazionale controllati da grandi imprese straniere.
La caduta della produttività. Il risultato di quest’insieme di problemi strutturali è stata la stagnazione della produzione, la perdita di quote di esportazione, il ristagno della produttività del lavoro, che riflette il valore di quanto produce in media ciascun lavoratore occupato, utilizzando i capitali, le tecnologie, i modelli organizzativi presenti nelle imprese. I dati Istat mostrano una produttività che cresce di appena lo 0,9% l’anno tra 1992 e 2011. Ma tra il 2000 e il 2009 la produttività cade dello 0,5% l’anno, un andamento che non ha paralleli in nessun altro paese. Nel periodo 2000-2011 la crescita della produttività in Italia è stata dell’1,2% l’anno in meno della media dell’Europa a 27, il peggiore risultato dell’Unione. Nell’industria manifatturiera tra 2000 e 2007 i dati registrano una diminuzione dello 0,07% l’anno, mentre in Germania c’è una crescita del 3,3%; nei servizi in Italia la diminuzione è dell’1,4% l’anno, risultato di un valore aggiunto che cresce dell’1,6% e di un’occupazione – precaria e a bassi salari – che aumenta del 3%; in Germania invece è aumentata dell’1%. Con una produttività che non cresce, l’Italia ha finito per perdere competitività internazionale, si trova con minore efficienza produttiva e salari peggiori.
Uno sviluppo insostenibile. La quantità dello sviluppo italiano è stata modesta, ma la sua qualità è stata anche peggiore. L’impatto ambientale dell’economia italiana non è migliorato in modo significativo. I consumi finali di energia del paese sono rimasti stabili; tra 2000 e 2010 il calo in tonnellate equivalenti di petrolio è stato di meno dell’1% in dieci anni, mentre la Germania li ha ridotti del 2,4%; l’intensità energetica del pil italiano si è ridotta di appena l’1%, mentre in Germania del 12%. Nel 2011 i problemi di inquinamento dell’aria sono sentiti come molto o abbastanza presenti dal 37% delle famiglie italiane, quelli legati al rumore dal 33%, quelli del traffico dal 41%, con un lieve calo rispetto al 2008 (Istat 2012b, pp. 28-30).
Le emissioni di anidride carbonica e di altri gas che producono l’effetto serra e alimentano il cambiamento del clima sono diminuite nell’Europa a 27 tra il 1990 e il 2010, con un indice che passa da 100 a 85; la Germania scende da 100 a 75; l’Italia resta ferma, da 100 a 97, e il calo è legato solo alla crisi del 2009, ancora nel 2008 l’indice arrivava a 104. La quota di energie rinnovabili nell’insieme della Ue è salita dall’8% del 2004 al 12% del 2010, in Italia è passata dal 5 al 10%. Molti altri indicatori documentano il continuo ritardo del paese sul fronte dello sviluppo sostenibile, a cui si somma la gravità delle emergenze ambientali in tutte le regioni del paese, fin...