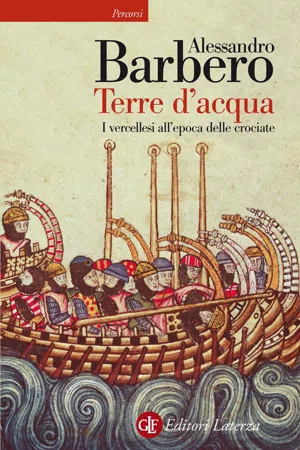
- 152 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Storia e cronache di un angolo della pianura piemontese e dei molti personaggi dalle avventure spesso strabilianti che lì nacquero e vissero, ma che da lì partirono per giocare, in luoghi lontanissimi, parti mirabolanti sulla scena mondiale: Cesari di Bisanzio, re di Gerusalemme, patriarchi di Antiochia. Con la sua consueta finezza di storico e narratore, Alessandro Barbero ricostruisce la vicenda d'un minuscolo territorio dell'Occidente – poche centinaia di chilometri quadrati oggi in provincia di Vercelli – all'epoca delle crociate, e ripercorre i fili che ne collegano la storia locale a quella globale dell'area mediterranea.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Terre d'acqua di Alessandro Barbero in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a History e European Medieval History. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
HistoryCategoria
European Medieval History1. Ieri e oggi, le terre d’acqua
1. Il bosco della Partecipanza
Nel bosco della Partecipanza si può camminare per ore senza incontrare un altro essere umano. Ci si arriva da Trino per strade sterrate, seguendo avare indicazioni; lasciata la macchina al Ponte d’Assi s’imbocca un sentiero coperto di ghiande e di foglie morte, e dopo pochi passi il mondo esterno scompare, rimangono soltanto gli alberi. In lontananza schiamazzano i corvi, e ogni tanto una minuscola ranocchia di bronzo attraversa in due salti il sentiero e si perde fra gli arbusti del sottobosco. Ci sono foreste che risvegliano paure ancestrali, di lupi, di streghe e di demoni, ma questo è un bosco luminoso; le querce secolari sono affiancate da alberelli più umili, robinie soprattutto, coi loro sottili tronchi spinosi, e ovunque ci si trovi basta alzare il naso per rivedere il cielo: si capisce subito che non siamo in una foresta primordiale, ma in un bosco civilizzato, che da mille anni l’uomo ha sfruttato e curato, tagliando la legna con giudizio, secondo regole precise, per non impoverirlo. Oggi è attrezzato con percorsi ben tracciati e addirittura circuiti di esercizi ginnici; ma già prima di aprirsi, timidamente, al turismo il bosco apparteneva a una natura amica, che gli abitanti della zona sapevano addomesticare senza farle violenza.
Il bosco della Partecipanza è una rarità naturale, l’unica foresta planiziale ancora esistente nella Valle Padana, l’avanzo miracolosamente conservato di un ambiente vegetale un tempo comunissimo e ora ovunque scomparso. Nelle fotografie aeree prese dal satellite, che chiunque può visionare sul proprio computer tramite siti come lo straordinario www.maps.google.it, il bosco si presenta come una gran macchia scura, in mezzo a un fittissimo reticolo di risaie; una macchia di forma geometrica, dal perimetro squadrato, chiaramente opera dell’uomo. Il bosco come lo conosciamo oggi, infatti, è soltanto l’avanzo deliberato di un’attività di dissodamenti che hanno progressivamente ridotto all’estensione attuale, di circa 575 ettari, una foresta immensa, e che si sono fermati appena in tempo per trasmettere fino a noi questo autentico fossile di un’epoca perduta.
È una storia che prende il via già prima dell’anno Mille, quando una popolazione in crescita comincia ad avere bisogno di allargare le superfici coltivate e di produrre più cereali, a costo di ridimensionare le aree di bosco consacrate alla raccolta della legna e all’allevamento brado del maiale. Un’espansione che nella nostra zona conobbe un’accelerazione decisiva all’inizio del XII secolo, quando i monaci cistercensi, sulla spinta dell’enorme successo incontrato dal loro movimento, cominciarono a prendere contatti internazionali per fondare nuove abbazie collegate alla casa madre di Cîteaux, in Borgogna. A quell’epoca tutta la pianura vercellese a nord del Po, solcata oggi dal canale Cavour e da innumerevoli rogge d’irrigazione, e interamente consacrata alla coltivazione del riso, era ancora in gran parte coperta di boschi. L’uomo abitava soltanto lungo il corso del grande fiume, in una manciata di villaggi, Trino, Palazzolo, Fontanetto, Crescentino; ma da lì chi voleva spingersi verso nord doveva aprirsi la strada attraverso il bosco per dieci o anche quindici chilometri, una buona mezza giornata di cammino, prima di sbucare nuovamente in aperta campagna e intravvedere, sull’orizzonte, le torri e i campanili di Vercelli.
Questa vastissima fascia incolta, fatta di foresta vera e propria, di boscaglia, di brughiera, di acquitrini, venne quasi interamente liquidata nello spazio di poche generazioni, proprio nell’epoca che qui vogliamo raccontare. Fra la fondazione dell’abbazia cistercense di Santa Maria di Lucedio nel 1123 e l’atto con cui il comune di Trino, nel 1285, vieta il pascolo delle pecore in quelli che ormai sono chiamati «i boschi comuni di Trino», l’incolto si trasformò da orizzonte immenso e potenzialmente ostile, che bisognava aggredire e ridurre per lasciare spazio all’attività umana, a risorsa limitata che occorreva salvaguardare, disciplinandone lo sfruttamento. In un secolo e mezzo si era consumato in quest’angolo di Piemonte (ma allora questo nome non aveva ancora attecchito: e tutti, qui, erano e si sentivano lombardi) uno dei grandi eventi storici del nostro passato, ben documentato in tutta Europa all’indomani dell’anno Mille: l’ondata dei grandi dissodamenti, la distruzione delle foreste e delle paludi, sostituite da pascoli e colture, via via che gli uomini si moltiplicavano, l’economia cresceva, e si compiva il trapasso dalla società più statica dell’Alto Medioevo a quella dinamica, aggressiva e ottimista del Basso Medioevo.
I dissodamenti trasformarono il volto dell’Europa, e la loro traccia si legge ancor oggi, ad esempio nella toponomastica: per limitarci all’Italia, quanti Ronco, Ronchi, Roncaglia indicano ancor oggi il luogo in cui i contadini, armati di roncola, aggredivano la boscaglia per trasformarla in campi; quanti Borgonuovo, Villanova, Castelnuovo segnano il luogo in cui un principe o un comune cittadino decise di fondare dal nulla un villaggio; e quanti Borgofranco, Villafranca, Castelfranco ci ricordano che per attirare braccia le autorità fondatrici erano disposte a riconoscere agli immigrati garanzie scritte e privilegi fiscali («franchigie»). Anche nell’area intorno al bosco della Partecipanza diversi toponimi, ad esempio due cascine chiamate «i Ronchi», ci ricordano che lì non abitava nessuno prima che la roncola dei dissodatori arrivasse a sfoltire la boscaglia, lavorando con pazienza e con metodo, fino a dare al bosco superstite i suoi attuali confini squadrati. Qualche chilometro a nord del bosco uno di questi toponimi, Ronsecco, ha dato origine a un centro abitato più consistente, oggi sede comunale; nella forma Ronchum sichum, è già segnalato fin dal 999 come confine dell’area forestale, a testimonianza che i più antichi interventi di dissodamento aggredirono il bosco da quella parte, dal lato della pianura e non da quello del Po. I nomi dei luoghi, insomma, a saperli leggere ci raccontano ancora oggi molte cose sul passato. Ma non sono molte in Europa le zone in cui la vicenda dei dissodamenti è ancora così visibile dall’occhio umano, in cui il «prima» e il dopo» stanno ancora fianco a fianco, come in quest’angolo della pianura vercellese, dove i quasi seicento ettari di querce e pioppi del bosco della Partecipanza si stagliano ancora all’orizzonte come un frammento di anno Mille sopravvissuto fino al Duemila.
2. Un’eredità antropologica
Il bosco della Partecipanza è una rarità anche dal punto di vista giuridico, perché appartiene tuttora agli eredi degli antichi abitanti di Trino, che nel Medioevo lo sfruttavano collettivamente e nel corso dei secoli elaborarono un sistema di regole miracolosamente sopravvissuto all’impatto della modernità. Quella che all’epoca delle crociate era una sistemazione banalissima, il diritto d’una comunità di sfruttare collettivamente le risorse naturali del suo territorio, ai tempi nostri si conserva come una dimenticanza della storia: perché dappertutto la modernità e il capitalismo si sono annunciati, già da secoli, proprio con la liquidazione degli usi civici e dei possedimenti comuni. A Trino, i discendenti degli antichi consorti hanno conservato gelosamente i loro diritti di partecipazione, e li hanno difesi contro le nuove leggi d’uno stato centralizzato che guardava con insofferenza a qualsiasi anomalia giuridica: tuttora essi hanno il diritto di lasciare in eredità le loro quote secondo regole proprie, diverse da quelle previste dalle leggi della Repubblica, e di far legna per il proprio uso, secondo una ripartizione minuziosamente studiata, che non danneggia l’ambiente.
S’intende che nulla è mai davvero immobile nella storia, e perciò non pochi aggiustamenti e modifiche si sono introdotti col tempo nella procedura di sfruttamento del bosco, via via che una banale procedura di sfruttamento collettivo dell’incolto, familiare a qualunque abitante dell’Europa medievale, si trasformava in qualcosa di eccezionale, da difendere con tanto più accanimento in quanto componente unica di un’identità locale. La svolta cruciale è maturata, forse, soltanto nel Cinquecento: allora, mentre il borgo cresceva e gente nuova veniva ad abitarvi, si decise che esclusivamente i trinesi antichi avrebbero avuto il diritto di far legna. Il bosco cessò così di essere considerato una proprietà pubblica del comune di Trino per diventare il patrimonio di un’associazione, la Partecipanza appunto, i cui membri comprendevano gran parte degli abitanti del borgo, ma non più tutti.
Proprio questa parziale privatizzazione ha salvato il bosco dal destino comune di tutti i beni collettivi, che ogni comunità contadina sfruttava nel Medioevo, e che nell’età moderna vennero ovunque privatizzati da sindaci e consigli comunali in combutta con i notabili locali o con i capitalisti di città. A Trino la Partecipanza, in quanto associazione privata, seppe tener testa a questi tentativi con un’energia che le comunità locali, indebolite dalla crescita dello stato assoluto, non avevano più. Non che siano mancati i pericoli: nel 1593 l’assemblea dei Partecipanti votò il disboscamento di 450 moggia di bosco, pari a circa 150 ettari, trasformati in campi e vigne e assegnati in proprietà privata; nel 1868, in pieno boom del riso, altri 14 ettari vennero convertiti in risaia. Poteva essere l’inizio della fine, invece rimase un episodio isolato: la speculazione agraria non progredì oltre e il bosco è sopravvissuto intatto fino a oggi.
Nel verbale del 1593 appare per la prima volta il nome in uso ancor oggi: «il bosco della Partecipanza del comune di Trino, detto volgarmente ‘le sorti’». L’espressione nasce dal fatto che le quote sono suddivise fra gli aventi diritto appunto mediante sorteggio. Ogni anno, a ottobre, la zona assegnata al taglio viene suddivisa in strisce longitudinali – chiamate «prese» – secondo una procedura antichissima: un uomo si addentra nel bosco fino a un punto prefissato, segnalato da una fossa nel terreno, poi chiama un altro uomo che procede verso di lui tagliando rovi e arbusti e aprendo un sentiero nel sottobosco finché non lo raggiunge. Ogni striscia viene poi suddivisa in «punti», e finalmente, la prima domenica di novembre, nel cortile della sede della Partecipanza, si sorteggiano i punti fra tutti gli iscritti nel Gran Libro. Ciascuno estrae la sua sorte dall’urna; ma vi sono stati casi in cui l’estrazione è stata affidata a un bambino, perché in faccende del genere le precauzioni non sono mai troppe.
Sarebbe certo imprudente affermare che questa procedura risalga in tutti i suoi dettagli al Medioevo; al contrario, tutto lascia pensare che si sia coagulata, e più volte modificata, nel corso del tempo. È variato il numero dei «comunisti», termine che qui conserva il suo senso desueto, e per nulla minaccioso, di partecipanti a un diritto comune: attualmente sono 1265, di cui meno della metà risiedono a Trino; molti stanno in Francia o negli Stati Uniti, uno in Australia, uno in Messico, uno in Sudafrica (ma chi risiede fuori dal paese, se anche si presenta al sorteggio ha diritto a una quota ridotta). È variato il numero delle zone in cui è stabilmente suddiviso il bosco, che fino a poco tempo fa erano dieci, e poi sono state sdoppiate; sulle venti zone risultanti, cinque sono escluse dal taglio, che investe ciascuna delle altre, a rotazione, una volta ogni quindici anni. Varia anche il numero dei «punti»: attualmente sono 198, ma in passato, quando la legna era preziosa e nessuno voleva rinunciare a prelevare la sua quota, sono stati anche più di 600. Eppure, nelle sue grandi linee, la procedura che si ripete a Trino ogni prima domenica di novembre si presenta comunque agli occhi dello storico con tutto il fascino d’un fossile vivente, la tenace sopravvivenza di pratiche comunitarie ormai quasi ovunque scomparse. E non stupisce che gli abitanti del territorio considerino il bosco della Partecipanza come un’eredità da difendere a qualunque costo, un’eredità unica non soltanto dal punto di vista ecologico, ma anche da quello antropologico.
3. L’acqua e i coltivi
Accanto alla foresta, l’altro elemento che intorno all’anno Mille dominava il paesaggio della zona era l’acqua. Niente di nuovo, verrebbe da dire, perché oggi questo è il paese del riso e dipende interamente dall’irrigazione: non per nulla l’immagine evocativa delle «terre d’acqua» si è ufficialmente affermata come slogan identitario della pianura risicola vercellese. Ma nell’epoca di cui parliamo il dominio dell’acqua era un’altra cosa, e aveva una doppia faccia, benigna e nutritrice da un lato, terribile e distruttiva dall’altro.
Allora come oggi, l’acqua era innanzitutto quella del Po, il grande fiume che scorre placido ai piedi delle colline del Monferrato, e che a quel tempo era una forza selvaggia e anarchica, di fronte a cui l’uomo poteva poco o nulla. Anche nella nostra epoca ipertecnologica, naturalmente, gli abitanti della pianura sono indifesi davanti a un’inondazione del Po; e anche oggi chi ne segua il corso si accorge subito che la sua acqua non scorre dritta e sicura come quella d’un canale, ma si allarga e si restringe continuamente, fa emergere isole e si lascia indietro gore morte, come se fosse sempre indecisa su come proseguire. Molti secoli fa il corso del Po era ancora più incerto, si divideva continuamente in bracci secondari che poi riconfluivano nel corso principale o finivano ad agonizzare in un acquitrino. In epoca romana e altomedievale qualcuno ipotizza addirittura che il corso principale corresse qualche chilometro più a nord di quello attuale, tanto che i villaggi della nostra zona, Palazzolo, la stessa Trino, si trovavano sulla destra del fiume, non sulla sinistra come adesso. Solo dopo il Mille il lento assestamento del territorio, e forse qualche cataclisma decisivo, qualche inondazione rovinosa di cui non abbiamo notizia, portò al prosciugamento dei rami settentrionali, e incanalò definitivamente le acque nel letto attuale; ma ancor oggi nel territorio di Trino è possibile identificare, a parecchi chilometri dal corso odierno del fiume, certe zone che i vecchi catasti definiscono «del Po vecchio».
Si capisce che finché il corso del grande fiume rimase così capriccioso, il popolamento stabile della zona risultò difficile, se non impossibile. In epoca romana nuclei di contadini abitavano certamente sul territorio che oggi è di Trino, e tutto lascia pensare che la foresta, allora, fosse meno estesa rispetto a quella medievale, e il paesaggio, nel complesso, più segnato dalla presenza umana. Ma la minaccia costante delle inondazioni, e quella ancora più insidiosa delle paludi, il lento avanzare delle acque che soffocavano i campi, finirono per aver ragione dell’ostinazione umana, e quegli abitati scomparvero, divorati dalla boscaglia. Eppure l’uomo è perseverante, e continuava a tornare, ben sapendo che il fiume, per quanto minaccioso, è anche fonte di vita. Intorno al Mille, i nuclei di quelli che oggi sono i comuni della zona erano già di nuovo abitati, anche se soltanto da un pugno di famiglie, e l’intera area in cui correvano, ora placidi ora rovinosi, i diversi rami dell’immenso fiume pullulava di vita.
Lì, in acque che non sapevano ancora cosa fosse l’inquinamento, la pesca offriva da vivere a tanta gente (ma quando si pescava uno storione, il vescovo di Vercelli esigeva che il grande pesce prezioso gli fosse regalato, salvo ricompensare adeguatamente il fortunato pescatore). Lì passavano i barconi carichi di sale proveniente da Comacchio e di quel che avanzava delle ricche merci orientali, seta e spezie, dopo che il grosso era stato smaltito sul famoso mercato di Pavia. Ma la presenza dell’acqua si avvertiva dappertutto: acqua delle paludi che si spingevano fin dentro la foresta, tanto che ancor oggi una delle zone in cui è diviso il bosco della Partecipanza si chiama «Paludi di mezzo»; acqua degli affluenti e delle rogge, in parte naturali, in parte scavati dall’uomo, che qui rigano fittissimi la pianura e hanno sempre garantito l’abbondanza dei raccolti e la fertilità dei pascoli. L’arrivo del riso alla fine del Medioevo sarà solo uno sviluppo ulteriore nella storia d’una terra in cui l’acqua era da sempre una ricchezza e comunque un elemento imprescindibile.
Ma, appunto, il riso arriverà tardi. Dobbiamo avere ben chiaro che all’indomani dei grandi dissodamenti medievali i contadini (i «rustici», come li chiamavano i documenti del tempo) che lavoravano in questa zona, al servizio dei monaci di Lucedio o dei marchesi di Monferrato, praticavano uno sfruttamento del territorio molto diverso dall’attuale monocultura del riso. Oggi quando si esce dal bosco della Partecipanza, in qualunque direzione, ci si trova direttamente in mezzo alle risaie. A primavera, quando le parcelle sono appena state allagate, è un luccicante mare a quadretti, secondo un’espressione che piace agli uffici turistici. D’autunno il riso è stato quasi ovunque mietuto, e restano le stoppie gialle, fitte, gonfie d’umidità; qua e là, fra tutto quel giallo, s’intravvede il bruno della terra intrisa d’acqua, più fango che terra. Non è un paesaggio interamente monotono, perché a tratti macchie di alberi, o piante isolate, segnano l’inizio di un argine o il confine d’una proprietà; e tuttavia l’orizzonte è dominato dal riso, a perdita d’occhio. Ma nell’epoca di cui parliamo tutto questo non esisteva: il riso ha cominciato a essere coltivato da queste parti verso la fine del Quattrocento. Può ben darsi che i monaci, sempre attenti a far rendere bene la terra affidata loro da Dio, siano stati fra i primi a cogliere le potenzialità di quest’innovazione (ben prima di Napoleone, che incentiverà la coltura del riso per nutrire i suoi eserciti, e del conte di Cavour, che ci vedrà invece una scorciatoia verso la modernizzazione capitalistica dell’agricoltura piemontese): ma in ogni caso nel paesaggio medievale le risaie non c’erano.
E non c’era neppure il mais, l’altra grande coltura della Pianura Padana, arrivato dall’America soltanto nel Seicento; il mais che qui non ha trovato spazio, per via dello strapotere del riso, ma che tuttavia si fa in tempo a scoprire, qua e là, in radi campi, se si attraversa Trino e si scende verso il Po. Nei secoli che qui vogliamo rievocare, all’indomani del Mille, mentre il fiume lentamente si assestava nel suo letto attuale, le zone paludose cominciavano qua e là a prosciugarsi, e i nuclei di capanne tirati su dai coloni nelle radure della foresta si trasformavano in veri villaggi, i contadini che aggredivano la boscaglia non avevano mai sentito parlare del riso né del mais; quello che avevano in mente era di ricavare terra da arare, coi loro leggeri aratri di legno e acciaio tirati da buoi, per seminare il grano – frumento e segala innanzitutto, ma anche il panico e il miglio, meno nutrienti ma più robusti, buoni per gli anni di clima cattivo e di carestia.
E dunque quando il lavoro dei dissodatori si fermò, una volta arrivato al costone su cui oggi sorge solitario il bosco della Partecipanza, interrompendosi di netto su quella linea dritta come un fronte di guerra che si ritrova oggi nelle fotografie aeree, tutt’intorno erano sorti campi di cereali, di quei cereali che nelle varietà premoderne crescevano fino ad altezza d’uomo, e si mietevano poi col falcetto, spaccandosi la schiena sotto il sole di giugno; e c’erano vigne, giacché la vite si coltivava dappertutto, allora, e il vino faceva parte della dieta quotidiana; e pascoli, buoni per fare il fieno grazie all’acqua di tutte quelle rogge, e soprattutto (almeno là dove a decidere erano i monaci) buoni per le greggi di pecore, il ramo imprenditoriale in cui erano specializzati i cistercensi. Oggi gli ovini non sono così comuni nella campagna piemontese, e ci vuole, anche qui, un certo sforzo per ricordarci che nel Medioevo questo era l’allevamento più diffuso, e la carne di castrato dominava sui banchi dei macellai, come testimoniano i regolamenti dei mercati. Sono quelle stesse pecore da cui già nel 1285 il comune di Trino deciderà di voler difendere il suo bosco, proibendone l’accesso alle greggi; e dunque se uscendo dal bosco della Partecipanza vogliamo provare a immaginare questa terra com’era al tempo delle crociate, dobbiamo vedere con l’immaginazione, al posto delle risaie, campi di grano, e pascoli verdi per innumerevoli greggi di pecore.
2. Gli uomini del potere
1. La città e il vescovo
Nell’orizzonte piatto delle risaie Vercelli s’intravvede già di lontano, come un’isola in mezzo al mare. La prima cosa che si distingue, in mezzo alla nebbia che d’autunno grava sulla pianura gonfia d’umidità, sono ...
Indice dei contenuti
- Premessa
- 1. Ieri e oggi, le terre d’acqua
- 2. Gli uomini del potere
- 3. I monaci a Lucedio e la nascita delle grange
- 4. Trino: la nascita di un borgo
- 5. I marchesi di Monferrato a Bisanzio e Gerusalemme
- 6. La saga di Bonifacio di Monferrato
- 7. I vercellesi oltremare
- Epilogo. Trino, 1305
- Bibliografia