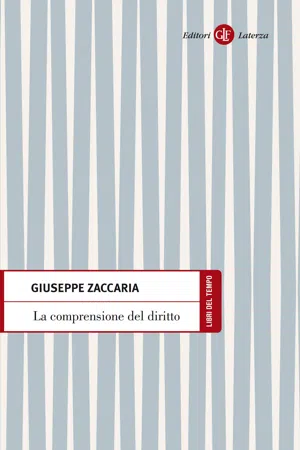1. La giurisprudenza come fonte di diritto: un’evoluzione storica e teorica
1. Giusto quarant’anni fa Josef Esser, in un memorabile saggio che coniugava mirabilmente sottili competenze tecniche spazianti sull’intero spettro del diritto – dal civile al costituzionale, dall’amministrativo al penale – con una rara capacità di porre il tema del fondamento nei sistemi giuridici di civil law, affrontava la spinosa questione della natura e del ruolo del diritto giurisprudenziale. Nel titolo del saggio, contenuto nel volume collettaneo per il settantesimo compleanno di Fritz von Hippel, il Richterrecht veniva da Esser affiancato al Gerichtsgebrauch e al Gewohnheitsrecht. Non a caso, giacché l’impostazione di Esser si può considerare emblematica, al massimo livello, dell’intento di utilizzare fino in fondo le possibilità evolutive aperte dai concetti elaborati dalla dogmatica giuridica tradizionale, che in quel momento riconosceva come fonti di diritto, nei sistemi di civil law, soltanto il diritto legale da un lato e il diritto consuetudinario dall’altro; e ciò proprio con il fine di individuare nuovi compiti e nuove responsabilità nella comprensione del rinnovarsi quotidiano del diritto.
Inevitabilmente oggi, a quarant’anni di distanza da quel saggio fondamentale, il tema della giurisprudenza come fonte di diritto viene posto in modi e con approcci completamente diversi: ed il nostro discorso di oggi mira anzitutto a dar conto del rilevante percorso che in parallelo alle trasformazioni reali del diritto è stato compiuto in tema di dottrina delle fonti dalla teoria giuridica contemporanea.
Tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta del secolo scorso, in un contesto in cui il giuspositivismo mantiene ancora una posizione molto influente, pur se messo in difficoltà dal prepotente emergere delle correnti antilogicistiche dell’argomentazione giuridica – da Toulmin a Viehweg, a Perelman –, dalla riabilitazione della «ragion pratica» e dalle proposte dell’ermeneutica giuridica, il diritto giurisprudenziale viene visto esclusivamente come fonte materiale ma non come fonte formale di diritto; cosicché l’unica via attraverso cui, nell’area culturale tedesca, si riesce a giustificare il difficile passaggio da una serie di norme singole di origine giudiziale individuali a norme di carattere e portata generale, dotate di forza vincolante per successivi giudizi su casi analoghi, è quella del diritto consuetudinario. Quest’estensione della categoria di consuetudine giudiziaria consente in sostanza di riconoscere alla giurisprudenza la dignità di fonte del diritto. Era stato Savigny per primo a considerare i precedenti come diritto consuetudinario e come momento del diritto scientifico: e all’interno della cultura giuridica tedesca giocano un ruolo assai importante, tra Otto e Novecento, l’influsso della Scuola storica del diritto e l’idea che il diritto entra a far parte e si afferma nella vita della comunità essenzialmente attraverso la pratica dei giuristi. Un’idea che tuttavia in quella cultura non viene mai disgiunta dalla consapevolezza di quanto sia rilevante la responsabilità del giudice nell’adempimento, nel quadro dello Stato di diritto, del suo compito istituzionale. In altre parole, alla giurisdizione è affidato un processo istituzionalizzatore delle novità giuridiche introdotte per via giurisprudenziale; processo che si realizza attraverso le due vie dell’uso giudiziale e del diritto consuetudinario giudiziale, dove l’uso giudiziale rappresenta un momento inferiore, perché meno stabile ed evoluto, del diritto consuetudinario. Insomma nel c.d. caso di usus fori, quando cioè la giurisprudenza giunge a possedere requisiti di durata e di stabilità tali da condurre ad un uso generalizzato, costante ed uniforme di una sua determinata opinione, essa si tramuta in diritto consuetudinario giudiziale, ed in quanto tale è da applicarsi come soluzione vincolante, a partire dal presupposto della sua giuridicità e della sua obbligatorietà.
Questa, dunque, la tesi prevalente nella dottrina giuridica tedesca degli anni Sessanta del Novecento, rispetto alla quale l’acuta analisi di Esser giustamente obiettava che l’autorità del diritto di origine giudiziale non si può far discendere da un fondamento di natura consuetudinaria, ma piuttosto dalla sua effettiva giustezza e dalla capacità di essere conforme al «convincimento giuridico vivente». Pur appartenendo a pieno titolo alla migliore dottrina e alla più agguerrita dogmatica giuridica, Esser coglie insomma perfettamente come la via del diritto consuetudinario altro non sia che un mascheramento ideologico – basato non a caso su un’idea ampiamente diffusa, fin dalla Scuola storica del diritto, nella cultura giuridica tedesca – con la funzione di occultare una conclusione che in quel momento storico non si può ancora esplicitamente riconoscere, e cioè la natura di fonte di diritto tout court del Richterrecht.
Non soltanto: lo stesso Esser coglieva acutamente come, in quella tesi del diritto giudiziale come diritto consuetudinario, un inconveniente non banale e non secondario fosse rappresentato dalla cristallizzazione del diritto e della giurisprudenza che tale tesi portava inevitabilmente con sé – la formazione di precedenti attraverso la via del diritto consuetudinario richiede un periodo di tempo lungo – e come ne venisse di conseguenza preclusa, o comunque sconsigliata, quell’innovazione che è invece funzionalmente essenziale alla stessa struttura di fondo del diritto, alla sua credibilità e autorità. Quando ci si muove sul terreno dell’interpretazione del giudice, pur sottolineando la rilevanza, per il consolidamento e la certezza del diritto, della continuità e della permanenza di quest’ultimo nel tempo – segno di una tradizione giurisprudenziale rilevante per la saldezza dell’organizzazione giuridica – è essenziale ribadire nel contempo la libertà e l’autoresponsabilità del giudice nella comprensione del diritto e nell’adempimento del suo compito istituzionale. Fino a prova contraria nei sistemi di civil law i tribunali sono pienamente liberi nell’interpretare ogni enunciato giuridico ed ogni caso analogo in modo diverso, ed una giurisprudenza che modifichi l’opinione fino a quel momento dominante deve essere in qualsiasi momento ammessa. Il diritto del giudice è sempre, in ogni sua decisione, in action, in un divenire continuo che mal sopporta di essere «congelato» nei lunghi tempi di incubazione necessari per produrre diritto consuetudinario.
2. Ma un’altra e diversa via, nello stesso periodo che stiamo considerando e che in Italia vedeva la solitaria riflessione di Gino Gorla attorno al valore del precedente giudiziario, veniva percorsa per riconoscere sostanzialmente alla giurisprudenza la natura di fonte del diritto. Una via che puntava invece sulla forza istituzionalizzante della giurisdizione, essenziale in un sistema giuridico sviluppato, e fondamentalmente basata sul vincolo al precedente.
Il principale protagonista di quest’ulteriore svolta teorica è Martin Kriele, che nel 1967 pubblicava un saggio denso e innovativo, Theorie der Rechtsgewinnung entwickelt am Problem der Verfassungsinterpretation. Il cuore del saggio sta nel rilievo che ormai, anche nei sistemi di civil law, è tale l’influenza di fatto dei precedenti nell’orientare l’interpretazione e la decisione giudiziale, che si può tranquillamente parlare di una loro «vincolatività presuntiva».
In effetti, è agevole constatare come nella realtà effettiva della prassi giuridica, cioè nel momento dell’interpretazione e dell’applicazione del diritto, si muova dai precedenti, e da essi ci si allontani solo se sussistono buone ragioni per farlo. Con immagine suggestiva, nella sua prefazione a L’impero del diritto, Ronald Dworkin ha parlato a questo proposito di una «forza gravitazionale delle decisioni precedenti». È questa una condizione non contingente, ma strutturale e permanente della prassi giudiziaria, ed è perciò preciso compito di una metodologia del diritto che intenda comprendere correttamente in quale modo funzioni l’interpretazione giudiziale della legge non tralasciare questa caratteristica durevole della pratica del diritto.
Infatti il giurista che non rispetti tale regola, sia pure non scritta, della prassi giuridica, rischierà, come tale, d’esser messo fuori gioco: se un avvocato non tiene conto dell’orientamento precedente della giurisprudenza, ben difficilmente potrà avere successo e comunque ne risponderà ai propri clienti; le decisioni di un giudice o di un tribunale che trascurino precedenti essenziali di Corti superiori potranno essere oggetto d’impugnazione e di revisione, mentre un funzionario pubblico che non consideri importanti precedenti può essere responsabile per violazione di doveri d’ufficio.
Si può in definitiva riconoscere che anche là dove non sia attribuita una rilevanza formale ai precedenti, agli indirizzi giurisprudenziali consolidati, questi ultimi esercitano di fatto una considerevole influenza sulle decisioni giudiziali, sull’attività legislativa, sulla stessa attività dei consociati nel loro insieme. Non per nulla le decisioni dei giudici, in particolare dei giudici di rango superiore, sono invocate come elementi autorevoli tanto negli atti degli avvocati quanto nelle motivazioni delle sentenze, e sono tenute in conto dalla dottrina.
Ma come concretamente funziona, nell’analisi di Kriele, questa presunzione di vincolatività a favore del precedente? Se la questione sottoposta al giudice rientra in uno dei casi tipici in vista dei quali è stata formata la costruzione della ratio decidendi sviluppata in sede giudiziale, egli potrà senz’altro servirsi di quest’ultima, senza l’onere di ragionare sulla giustezza del risultato in quel caso specifico, e comunque gli sarà così garantito di pervenire ad un risultato incontestabile. Avvalendosi di una soluzione sperimentata, la presunzione a favore del precedente solleva in tal modo il giudice dall’onere di rinnovare in ogni nuovo caso la verifica circa la «tenuta» della ratio decidendi, che viene ad assumere in questo contesto la tradizionale funzione della norma generale ed astratta. Si presuppone infatti che quella conclusione sia stata esposta alla critica, dibattuta e alla fine trovata buona. Solo quando al giudice si impongono argomenti di forza tale da far cessare la presunzione a favore del precedente, egli dovrà riponderare le questioni già decise in precedenza e riprendere quindi in esame il contesto effettivo del caso specifico. Dove si può osservare in sede critica che il diritto non si trova precostituito neppure nel «deposito» dei precedenti, ma deve essere di volta in volta nuovamente reperito e realizzato alla luce delle novità del caso singolo, dunque con un rapporto sempre nuovo e rinnovato tra la norma ed il fatto.
Prendendo atto così a livello teorico che ormai nella realtà giuridica europeo-continentale i precedenti venivano ad avere un’importanza pressoché simile a quella dell’ambito angloamericano, l’impostazione di Kriele, mentre registrava l’innegabile evoluzione dei sistemi giuridici di civil law, ne minimizzava, in nome di una più puntuale adesione alla realtà della prassi giuridica, le differenze rispetto a quelli di common law e così sanciva la fine della tesi metodologica precedentemente dominante, di un modo gerarchico di intendere il processo di reperimento del diritto, secondo il quale il diritto giudiziale non poteva che avere natura appendicolare e secondaria rispetto al diritto d’origine legislativa. D’altra parte, a questa importante «rottura» teorica della tradizione dottrinale dominante in tema di fonti, grazie alla quale ci si orientava verso una più realistica collaborazione e «suddivisione del lavoro» di produrre diritto tra potere legislativo e potere decisionale del giudice, faceva riscontro nei fatti una convergenza sempre più marcata ed un sempre più evidente avvicinamento tra i due sistemi giuridici, in nome appunto di quella vincolatività presuntiva dei precedenti che li portava ad essere non più assolutamente vincolanti come un tempo nei sistemi di common law, e di fatto sempre più influenti nei sistemi di civil law. Una convergenza ed un avvicinamento grazie ai quali per un verso gli atti applicativi del diritto codificato acquistano una valenza creativa di diritto, mentre per altro verso l’adesione al precedente diritto di creazione giudiziale non ne preclude lo sviluppo ulteriore. Il fatto è – e qui si va al cuore di questa convergenza di sistemi – che il giudizio comparativo tra i due casi che il giudice prende in esame, il precedente e quello che egli deve risolvere, implica sempre aspetti di comparazione, di ponderazione valutativa che soppesi analogie e ...